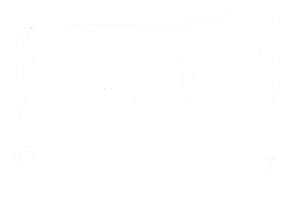COLOSSALI FRAINTENDIMENTI
(APPUNTI DI VIAGGIO E DI RICERCA)
— a cura del CENTRO STUDI arya —
Da molto tempo, ormai, a causa delle nostre attività e del nostro impegno, capita sovente di confrontarci con ricercatori genericamente definiti “spirituali”, appartenenti alle più varie estrazioni e aventi i più disparati orientamenti. E, quasi invariabilmente, ci si trova di fronte ad alcuni colossali fraintendimenti che qui vorremmo tentare di mettere in chiaro, almeno nelle linee essenziali o in alcune manifestazioni particolarmente evidenti.
Partiamo da una riflessione di base che, per noi, riveste la configurazione di un presupposto fondamentale. Quando si avverte in sé l’aspirazione a iniziare un percorso che si ponga come meta ultima la ricerca della Verità assoluta, la prima necessità è quella di ammettere la propria ignoranza, mediante la constatazione (fondata, ovviamente, sull’investigazione personale e l’esperienza diretta e non su assunti aprioristici) che la mente razionale (analitica per definizione) non è lo strumento adeguato per trovare la Conoscenza suprema (unitaria e globale), così come non lo è la mente emotiva, questa grande fabbricatrice di illusioni, di dogmi e di credenze stereotipate o poggiate sulle fragili fondamenta del sentimentalismo. Bisogna insomma avere il coraggio di mettersi in cammino nell’ignoto, abbandonando ogni preconcetto. E, proprio per questo, occorre in primo luogo (reiteriamo: prima di ogni altra cosa!) fare tabula rasa di tutte le false conoscenze stereotipate, acquisite (perlopiù in modo acritico) dall’educazione: l’ambiente sociale e culturale nel quale siamo nati e cresciuti, la fitta trama collettiva dei pregiudizi che caratterizzano il nostro tempo (e che ci offre la futile illusione di essere al riparo dal pericolo della barbarie, mentre in realtà ci omologa in modo fatale e aberrante), la particolare concatenazione di esperienze passate entro la quale ciascun individuo si trova intrappolato come in una ragnatela vischiosa da cui a prima vista sembra impossibile uscire, fino ad arrivare all’assai più elusiva e subdola struttura cromosomica che ereditiamo dai nostri antenati, con la pletora delle sue idiosincrasie e il groviglio apparentemente inestricabile delle pulsioni più ancestrali e ostinate.
Qualcuno sarà forse maggiormente attrezzato di noi (ce lo auguriamo di tutto cuore!) nell’individuare e sfaldare dall’interno questa mastodontica e magmatica struttura edificata sulla più abnorme ignoranza fondamentale, ma la nostra personale esperienza ci porta — purtroppo — a parlare in termini di decennî, non certo di mesi e nemmeno di qualche anno.
E, a questo proposito, la prima constatazione — fatta sul campo — è che molti ricercatori, magari anche dotati di una aspirazione fondamentalmente genuina, per una serie di motivazioni (il più delle volte si tratta di una fretta ansiosa, per certi versi comprensibile ma che può rivelarsi fatale, di assicurarsi un primo punto d’appoggio sufficientemente saldo; oppure può sussistere una insufficiente capacità di auto-analisi e di discriminazione; o, ancora, può emergere e imporsi un elemento di superficialità che si accontenta di qualche misera scappatoia, al punto da far perdere la più ampia prospettiva del cammino) non affrontino tale opera preliminare di smantellamento dell’ego e dei suoi mille nascondigli.
A volte, per fare qualche esempio concreto, capita di confrontarsi con persone che, nate in una determinata tradizione religiosa, lottano interi anni per liberarsi da tale imposizione, sinceramente e talvolta addirittura con una ammirevole precisione metodica, oggettivando e rigettando dal sistema tutti i condizionamenti indotti, passivamente subiti, per finire però ad abbracciare un’altra tradizione religiosa (o, per fotografare la realtà in modo più preciso, mistico-religiosa) con troppa ingenuità, prendendo tutto per oro colato, senza fare leva su quelle preziosissime capacità discriminative che hanno permesso loro di affrancarsi dall’indottrinamento subito nel corso dell’infanzia!
In altri casi, invece, perfino l’indispensabile emancipazione da qualunque tradizione religiosa, d’occidente o d’oriente, non evita al ricercatore di cadere nella trappola della dipendenza da una autorità, fraintendendo e distorcendo nel modo più banale la verità sottostante il rapporto fra ‘maestro’ (guru) e ‘discepolo’ (cela). Un vero Maestro aiuta (perlopiù silenziosamente, con la propria forza interiore) il proprio discepolo senza manipolarlo in alcun modo, insegnandogli come prima cosa l’importanza di non delegare nessuno e di mettersi in gioco in prima persona; lungi dal cercare di imporre le sue verità, sprona il discepolo a trovare le proprie. Immaginate pertanto la nostra stupefazione quando, discutendo con il seguace di un famoso “yogi” dell’India a proposito del mito di Atlantide, per tutta risposta ci sentimmo dire: «Dato che il mio Guru ne parlava come di una civiltà storicamente esistita, io devo credere per forza nella sua esistenza»! E questo esempio è tanto più significativo quanto più lo si guarda come la punta di un immenso iceberg, interamente costituito da analoghe accettazioni supine di ‘articoli di fede’ dogmatici e aprioristici, in una oziosa e ottusa mania di rinchiudere il libero volo entro una rigida gabbia di ricette preconfezionate.
A questo proposito, è forse necessario aprire una parentesi sull’assurdità della concezione (piuttosto diffusa in India e allargatasi a macchia d’olio in molti ambienti orientaleggianti d’Europa e d’America) secondo cui il guru è infallibile. Esiste un detto, in India, volto ad asserire che perfino quando il guru sbaglia, in realtà lo fa di proposito, per mettere alla prova il discepolo e stimolarlo a non fermarsi alle apparenze... In pratica, si passa dall’infallibilità del papa all’infallibilità del guru senza avere sviluppato la minima facoltà critica e mantenendo la medesima e perniciosa attitudine all’ipse dixit. Di fatto, si sostituisce una chiesa con un’altra chiesa, un intermediario con un altro intermediario, un dogma con un altro dogma (magari meno pernicioso, pur se non necessariamente — in ogni caso, l’operazione di rimpiazzare una grande menzogna con una menzogna minore non è certo risolutiva o augurabile). Il rapporto, così speciale e così importante, fra ‘guru’ e ‘cela’, assume in tal caso connotazioni patologiche di transfert della personalità, ben note presso gli indirizzi di psicologia comportamentale. E così, in breve, la saggezza diviene scemenza totale. Infatti, ostinarsi a ritenere che il guru non possa mai sbagliare è, sostanzialmente, un atto di pura idiozia — proiettiamo le nostre concezioni puerili di onniscienza e onnipotenza su qualcun altro che consideriamo ‘perfetto’ per attribuirgli comportamenti che, nella nostra scempiaggine e nel nostro delirio egocentrico, desidereremmo appartenessero a noi.
Un altro comportamento assai diffuso è quello di proiettarsi verso una linea di ricerca assai lontana dalle forme culturali cui siamo stati abituati e che ci sono state inculcate durante l’infanzia e la prima adolescenza, riversando in essa inconsciamente tutte (o quasi) quelle false certezze preconfezionate che abbiamo subìto in modo acritico e che non ci siamo mai (pre)occupati di mettere in discussione.
Con il passare del tempo, poi, se non si accede a un significativo processo di esperienze personali, può perfino accadere (e anche questa è una tendenza piuttosto diffusa, in base a quanto abbiamo potuto constatare) — a forza di leggere e di rimuginare conoscenze recepite indirettamente — di farsi preda dell’illusione di avere perfettamente introiettato tali esperienze prese a prestito, arrivando più o meno inconsciamente a ritenerle ‘nostre’, vissute per una sorta di affinità elettiva, per così dire. Anche qui, si può arrivare a ben note manifestazioni patologiche di devianza schizofrenica.
Gli esempi, in tal senso, potrebbero essere numerosissimi e la maggior parte di essi si mostrerebbe grandemente imbarazzante quanto a ingenuità, ma il rischio di fomentare l’odioso pettegolezzo ci impone un più prudente silenzio. Preferiamo che ciascuno constati di persona e tragga le proprie conclusioni, per arricchire il proprio bagaglio di esperienze e farne tesoro nel suo personale percorso di vita.
Molto più istruttivo riteniamo possa essere il soffermarsi invece su quell’immenso orizzonte di ricerca sperimentale, a noi particolarmente caro, volto alla realizzazione di uno stato “senza-morte”, vale a dire il tentativo di rendere l’inalienabile immortalità interiore dello Spirito eterno manifesta anche nell’eterno Divenire fenomenico. Ci porterebbe troppo oltre illustrare, qui, le solide basi filosofiche che rendono tale approccio altrettanto legittimo di linee di ricerca diametralmente opposte ma ugualmente degne di rispetto — quelle, ad esempio, tendenti a considerare l’universo fenomenico una immensa illusione, un incubo funesto, un gioco perverso, una malia irreale da cui emanciparsi —, mentre intendiamo soffermarci sui ‘colossali fraintendimenti’, cui alludevamo in apertura. Per inciso, quanti volessero approfondire le basi filosofiche sopra accennate, sono caldamente invitati a immergersi nell’incomparabile opera The Life Divine, di Sri Aurobindo, purtroppo non ancora adeguatamente tradotta in italiano (le traduzioni attualmente esistenti sono perlopiù depistanti: la prosa sublime e luminosissima di Sri Aurobindo è stata barbaramente soffocata, molto probabilmente in buona fede, sotto una coltre opprimente di insopportabili contorcimenti cerebrali e di una resa terminologica inadeguata e deviante, che ne fanno un’opera cervellotica e terribilmente contorta — ovvero, l’esatto opposto di ciò che essa è nell’originale); di questa Opera fondamentale, nel nostro sito si può trovare l’intera SINOSSI che, ci auguriamo, possa dimostrarsi di una qualche utilità.
Tornando a noi, è risaputo come il mito dell’immortalità esista dall’alba dell’uomo e, quindi, si riveli quanto mai necessario — al pari di ogni altro elemento recepito in modo inconscio —, sottoporlo a quel medesimo processo di oggettivazione e di destrutturazione cui abbiamo dedicato lo spazio introduttivo del presente articolo, al fine di individuarne le ingenuità, le derive popolareggianti, le falle, le incongruità, le eventuali inattuabilità, i madornali equivoci e ogni altro elemento oscuro e fuorviante. Anche in questo ambito, infatti, dobbiamo constatare a malincuore di avere sovente riscontrato un atteggiamento più mediocremente fideistico che genuinamente sperimentale.
E allora, ricorriamo anzitutto alle scrupolose riflessioni sulla fatale illusione dell’immortalità di uno dei più acuti osservatori della realtà contemporanea: Wolfgang Sofsky —
«Il desiderio di annullamento della sofferenza è basato sulla speranza di eternità. La cultura è lo sforzo vano di superare la morte. Essa ha la medesima radice della violenza assoluta: la megalomania della sopravvivenza. La cultura fornisce ricette per dissipare la paura della morte. Ma le creazioni culturali non assicurano l’esistenza fisica, bensì l’illusione della durevolezza. E così, l’illusione nutre l’illusione. Il miraggio del superamento della morte è un miraggio mortale. La violenza non è che la conseguenza di una cultura eretta sulla trascendenza dell’esistenza.» (da “Saggio sulla violenza”).
Quanti hanno compulsato il lungimirante saggio di Jean Baudrillard "L'illusione della fine”, avranno già ricevuto i migliori stimoli di riflessione in tal senso, grazie al magistrale capitolo intitolato L'immortalità. E, anche in questo caso, ci piace citarne un estratto, in cui il geniale sociologo e filosofo si interroga sui problemi posti dai teologi medioevali sul dogma (particolarmente aberrante e deformato!) della resurrezione dei corpi —
«I corpi resusciteranno con tutti i loro organi (compresi quelli sessuali), con le loro malattie, i loro tratti distintivi, tutto ciò che faceva di loro degli esseri viventi specifici — oggi, si potrebbe allargare la questione chiedendosi se resusciteremo con i nostri desideri, i nostri difetti, le nostre nevrosi, il nostro inconscio, la nostra alienazione; con i nostri handicap, i nostri virus, i nostri deliri. [...] Se Dio esiste, non c'è bisogno di crederci, mentre se non esiste è assolutamente necessario crederci. Se credenza non è il riflesso dell'esistenza, sta per l'esistenza, proprio come il linguaggio non è il riflesso del senso ma sta al posto del senso. Credere in Dio significa quindi dubitare della sua esistenza, della sua evidenza, della sua presenza. Dio, quando a lui, se esiste, non ha bisogno di credere alla propria esistenza, ma lascia che sia il soggetto a crederci, e a credere di crederci, o a non crederci, o a non credere di non crederci. [...] È in Pensieri sulla morte e l'immortalità che Feuerbach opera la decostruzione di tutta questa configurazione religiosa dell'aldilà, dell'immortalità e della resurrezione. Questa emancipazione da tutte le superstizioni corrisponde al ricupero da parte del genere umano della sua essenza perduta. [...] Nietzsche ha magnificamente parlato dell'illusione vitale, non di quella dei retromondi ma dell'illusione delle apparenze [...]. [...] la specie umana può raggiungere la sovranità attraverso una trasmutazione dei valori, altrimenti rimane votata a tutte le superstizioni, comprese quelle, più moderne, della psicologia e della tecnica, compresa la superstizione di se stessa in quanto specie definitiva.»
Talmente radicato è l'atavico istinto alla sopravvivenza che, quando — all’interno del circolo ristretto dell’Ashram di Mère e Sri Aurobindo —, avvenne il primo caso di decesso, si produsse un forte e generale sgomento tra i simpatizzanti (Mère ne parla nella Sua Agenda, con molta ironia e chiarezza). Questa illusione dell’immortalità (vale a dire, la speranza di una sopravvivenza a oltranza della limitata, ridicola, inadeguata formazione egoica individuale, per nostra fortuna effimera e transitoria) aveva ghermito perfino le persone fisicamente (ma non necessariamente in spirito) più vicine a Mère e Sri Aurobindo. Figuriamoci quindi quelle più lontane nello spazio e nel tempo che, sbandierando un sedicente discepolato (fa sempre comodo mettersi la casacca del ‘discepolo’, soprattutto quando l’eventuale maestro non è più in grado di confermare la propria accettazione o il proprio rifiuto), in realtà si rendono, ancora oggi, preda delle più ingenue fantasie superomistiche (l’immortalità dell’ego, per l’appunto, o anche solo del limitatissimo e quanto mai provvisorio involucro fisico che ingabbia l’individuo), accettate senza una adeguata verifica e senza il sia pur minimo riscontro all’interno della loro personale esperienza — che, in fin dei conti, è la sola a contare per davvero!
Senza parlare di quanti, ancora oggi, soprattutto nelle classi più abbienti, si fanno costruire immensi e costosissimi mausolei, antiatomici e appositamente refrigerati, forniti di tutti i più avanzati ritrovati della tecnologia, della medicina e della criogenetica, entro i quali, il giorno del loro trapasso — da sciocchi e vanagloriosi faraoni moderni — poter far custodire le proprie spoglie corporee, nella ridicola speranza che la scienza, in un futuro non troppo lontano, sia in grado di riesumare quell'inutile mucchietto di ossa e di renderlo ‘immortale’. E così, l’essere umano, questa «animula che si trascina un cadavere», nelle mordaci parole di Epitteto, si trasformerebbe in una sorta di spettro che si trascina una salma tenuta artificialmente in vita a perpetuità — l’illusione più aberrante che perversione mentale potesse mai immaginare!
La NUOVA SPECIE preconizzata da Mère e Sri Aurobindo non è una triste e ridicola umanità di sopravvissuti (quelli, al contrario, devono sparire!), bensì di SOPRAviventi.
Settembre 2013