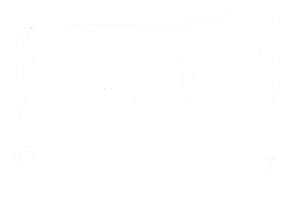ARTURO ONOFRI
e la TERRESTRITÀ DEL SOLE
di Tommaso Iorco
(autore tutelato S.I.A.E.)
Nel corso degli ultimi quattro anni della sua vita, tra il 1925 e il 1928, Arturo Onofri si dedica al ciclo lirico della Terrestrità del sole, che rappresenta il canto del cigno dell’Autore (pubblicato perlopiù postumo). Esso è composto da cinque vaste sillogi (Terrestrità del sole, Vincere il drago!, Zolla ritorna cosmo, Suoni del gral, Aprirsi fiore), nate con l’intento di realizzare quanto egli aveva espresso, da un punto di vista teorico, nel Nuovo Rinascimento come arte dell’Io, un saggio poetico pubblicato nel 1925 in cui si afferma che «L’arte è uno strumento di auto-rivelazione spirituale»; la poesia, in particolare, è «un arrivare a toccare con la magia delle parole l’essenza dell’universo invisibile, un comunicarsi col mistero divino, un partecipare, per amore parlante, all’atto originario del Verbo creatore». Ci si ricollega in tal modo a quelle antichissime intuizioni che vedono nella Parola il principio creatore originario, come nel concetto greco del Logos, nella Qabalah ebraica e, prima ancora, nella mistica vedica e vedantica (e, in seguito, in quella tantrica).
E, proprio come nelle antiche concezioni, l’atteggiamento che ne deriva è marcatamente spirituale. Il percorso iniziatico che il ciclo poetico onofriano illustra si snoda attraverso la consapevolezza della volontaria autolimitazione dell’essere e nella presa di coscienza del nostro vero essere — perciò, anzitutto, la cosiddetta ‘caduta’ dell’anima non è un errore, ma una conseguenza necessaria in vista di una rinascita e di una nuova e più ampia integrazione.
In vista di tale meta, occorre anzitutto liberarsi dall’illusione di credersi separati dal tutto, dimentichi della propria vera origine. Ed è proprio su queste premesse che si fonda la silloge Terrestrità del sole (pubblicata nel 1927 e composta tra il 26 gennaio 1925 e il 4 gennaio 1926), la quale segna la prima tappa di questo cammino iniziatico. Riportiamo, a titolo di esempio, il sonetto CXXVI.
Quando la mia presenza eterna è fuori
di me stesso, nel sonno della notte,
e incontra le sequele ininterrotte
d’altri se stessi in astri e in dèi sonori,
verità regna i compensati errori
di ieri, che il domani in sé ringhiotte:
son fede le viltà, luce le lotte,
unico Sol dei soli è un Cuor dei cuori.
Assume allora aspetto (uno e diversi)
d’uomo celeste in uomini mortali,
il Verbo-Eternità fatto universi;
e vita me ne crea (mentre in me dorme)
il morir mio, che in quel pullulio d’ali
respira infinità d’umane forme.
Occorre pertanto ritrovare quella essenzialità eterna che si manifesta incessantemente negli esseri e nei mondi che — a ben vedere — sono diverse espressioni dell’Unico. Il principale ostacolo alla presa di coscienza di questa nostra vera realtà, e alla conseguente conciliazione degli apparenti opposti, nella poesia di Onofri è rappresentato dal Drago, che ostruisce il cammino, impedendo all’anima di procedere, e cercando anzi di renderla schiava delle apparenze. Vincere il drago! (pubblicato nel 1928 e scritto tra il 26 giugno e il 26 novembre del 1926) è per l’appunto il titolo della seconda tappa di questo ciclo dal respiro poematico. La lirica che proponiamo qui è la CL.
Una vita irraggiante si palesa
nella tua volontà di dir parole
da dentro la mia anima, protesa
fino a dimenticarsi
in questa sua catarsi.
Un effluvio di mondi si propaga
nel calore di te, che invade il petto
della mia vita angusta, ma presaga
(dandosi a te) dell’impeto perfetto
che le tue stelle regge,
come il pastore un gregge.
L’oceano del tuo suono eterno dice
al sangue umano ch’esita perplesso:
— Dónati alla parola beatrice
che sazia i cieli, e avrai quivi il te stesso
cui vagamente aneli:
pari a tutti i miei cieli.
Son così tuo, che l’anima tua m’ama
dentro di sé senza sapermi in lei.
Se appena origli, la tua vita grama
ecco, s’allenta in musica, e tu sei
magnificato, almeno
un lampo, entro il mio seno.
Questo diventar me, della tua vita,
è il volere ond’io crebbi e cielo e terra,
è l’amore ch’edifica infinita
armonia d’unità, dentro ogni guerra,
è l’impeto che dorme,
mio verbo, in queste forme.
Così mi parli. E l’anima che origlia,
quando poi volge gli occhi aperti e intenti
al dolore del mondo, oh meraviglia,
ella vi scopre sue le onnipotenti
virtù del tuo cuor santo,
ond’ella ascolta il canto.
È chiaramente visibile, fin da queste due prime liriche riportate, l’importanza preponderante che il verbo poetico assume in una simile tensione mistico-sapienziale. La ricerca interiore e la sua espressione artistica, in Onofri, appaiono come le due facce di un unico opus alchemico; parafrasando Mallarmé, il Nostro arriva ad affermare che il poeta «ha da diventare un auto-illuminato del linguaggio, un auto-illuminato dal linguaggio» (Nuovo Rinascimento, op.cit.). L’atto stesso del poetare determina una catarsi e una trasformazione che, per una sorta di affinità elettiva, può estendersi finanche al lettore.
Ad ogni modo, la riconquista di sé conduce l’uomo-zolla a reintegrarsi con il tutto primordiale da cui l’anima si staccò. E Zolla ritorna cosmo (pubblicato nel 1930 e composto tra il 1° gennaio e il 30 settembre del 1927) segna la terza tappa di questa ricerca; la poesia che abbiamo scelto è la LXXV.
La tenacia dei tendini che tiene
avvinto all’ossa rigide l’elastico
fuoco del Karma in muscoli ed in vene,
osta avvertitamente al troppo plastico
slancio, che svuoterebbe
l’uomo stesso in cui crebbe.
Dorme nel chiuso nimbo del suo caldo
sangue; e il suo sonno pio già s’assottiglia
in improvvisi lampi di smeraldo
angelico, da cui sorge e s’ingiglia
il calice d’un fiore,
nato puro splendore.
Alza in femineo calice di grazia,
la tua maschia tenacia corporale,
anima illuminata! e alfin sii sazia
del raggio di quel sole universale,
che in spirito t’inondi
del fuoco dei suoi mondi.
È a questo punto che si perviene, per Onofri, alla mutazione alchemica in cui, evidentemente, il ciclo graaliano rappresenta un simbolico percorso di iniziazione. Suoni del gral (pubblicata nel 1932 e scritto tra il 1° ottobre e l’8 aprile 1928) rappresenta in modo del tutto consequenziale la quarta tappa del processo poetico e interiore dell’Autore, di cui riportiamo il sonetto XII.
Il dolcissimo viso della Grazia,
che si promise in sillabe di canto
al mio cercarla in tenebre soltanto,
apre al mio sonno i cieli ov’ella spazia.
Viso che irradia carità, ringrazia
ella il dolor dei mondi che in un santo
spasimo, affida a lei, dal proprio schianto,
l’esserne integra gioia, unica e sazia.
E il rivelarsi del suo dolce viso,
arcanamente onnipotente, è il pegno
di quell’Amore che ci vuol suo regno:
suo regno qui, benché sembri diviso
in una moltitudine di forme
sparse, ove ancora il voler nostro dorme.
L’uomo, infine, giunge al «compimento eccelso d’esistere», rappresentato simbolicamente dal fiore, in quanto sboccio supremo dell’essere nell’estasi del sole originario. Aprirsi fiore (pubblicato nel 1935 e composto tra aprile e settembre del 1928) titola la raccolta conclusiva, la quale dovrebbe attestare la raggiunta integrazione. Ne costituisce un bell’esempio la poesia XVII.
L’anima che si spinge verso l’alto
del suo celeste fremito immortale
s’affranca dal suo carcere di smalto,
per aprirsi in un fiore, che trasale,
al raggio d’una grazia
che sola ormai la sazia.
E se non vuol da sé, schiuder se stessa
con l’energia che in lei freme assopita
rimane imprigionata entro la ressa
del sangue, che ne trae la propria vita,
serrandole ogni forza
nella sua propria scorza.
Ma quando volontà d’uomo è risorta
fino ad aprirsi in calici di fiore,
l’anima che gemeva fredda e smorta
sente su lei discendere il fulgore
del suo rinascere sempre
in rinnovate tempre.
Onofri è un poeta che merita indubbiamente maggiori riconoscimenti e approfondimenti. Certo, la sua produzione poetica (presa nell’insieme) è ben lungi dal rappresentare un qualche modello di perfezione. Egli ha un modo di poetare che è sovrabbondante all’eccesso, privo dell’olimpica meticolosità dei grandi poeti (finanche le innumeri correzioni sui propri manoscritti e dattiloscritti hanno qualcosa di forsennato); si avverte in lui un’impazienza febbrile — sacra, forse, ma anche incontinente (presagiva egli, inconsciamente, la sua prematura dipartita?). Innumeri sono le falle ravvisabili nella propria costruzione poetica, senza considerare che le concezioni esoteriche cui si riferisce poggiano sul terreno malcerto delle sabbie antroposofiche. Egli non sa — o magari non vuole, o più probabilmente sa per metà e perciò non vuole — distinguere il verbo che giunge dall’alto da quello costruito nell’officina del cervello. E tuttavia, Arturo Onofri è un vero poeta: possiede il dono dell’ispirazione (pur se troppo spesso oppresso dall’invadente struttura di una mente discorsiva incapace di tacere), è intenso e genuino, sa magicamente convogliare ritmi e melodie sonore in rivi metrici dal flusso ampio e potente; la sua poesia appare come un fiume in piena, che trascina tutto con sé, senza curarsi di selezionare solo quegli elementi che non rendano torbide le sue acque… cadaveri di morte idee, fanghiglie steineriane, vecchi residui concettuali confluiscono tutti quanti nell’impeto delle sue rapide — assieme, ovviamente, a freschezze intramontabili, a correnti di pura luce e fiamma, lampi d’un bagliore sovrano e sovrannaturale e perle d’ammirevole perfezione, intensi slanci lirici di pura passione spirituale, ali sublimi provenienti da un altrove che si vorrebbe in terra.
Trasaliscono i monti al soffio lieve
del respiro serale, e abbrividendo
si velano d’un velo di viola
che si vena d’un tremulo affiorare
d’oro, nel verde argenteo del tuo cielo.
Dove tu stendi l’eccitata luce
delle tue prospettive, ivi t’innalzo,
dal mio segreto fremito, l’offerta
di questo breve tempo della terra,
ch’è il ritmo del mio petto, ove mi parli.
Dagli spazi lucenti, sulla soglia
della notte, al fiorir delle tue stelle,
trasaliscono i monti, in un respiro
che rassomiglia al mio, nel dolce suono
del tempo di quaggiù, che d’uomo ha il canto
e di terra la forma e la speranza.
La lirica appena riportata, è tratta dalla raccolta Simili a melodie rapprese in mondo, che Arturo Onofri considerava un tutt’uno con Aprirsi fiore.
La poesia italiana del futuro ha probabilmente parecchio da imparare dalla lezione onofriana — dai compimenti raggiunti, come pure dai suoi fallimenti. Ciò che maggiormente sorprende, in lui, è l’incapacità di applicare le proprie indubbie doti di critico nei confronti della sua stessa produzione poetica. Nel suo già citato Nuovo rinascimento come arte dell’Io, leggiamo ad esempio: «Risultato tipico è il sovrabbondare della materia verbale in rapporto all’essenza, allo spirito dell’espressione, e in cento pagine si trova diluito ciò che avrebbe avuto la sua giusta manifestazione forse in dieci o in cinque potenti tratti verbali. […] Il grosso corpo verbale schiaccia e soffoca il tenue spirito espressivo che avrebbe voluto manifestarsi». Onofri si riferisce qui alla poesia priva di vera ispirazione spirituale, ma le sue parole si attagliano con estrema efficacia alla sua pur interessantissima opera poetica.
Non si avverte, inoltre, un vero crescendo di esperienze spirituali, percorrendo per intero il tragitto delle cinque raccolte (d’altronde, realizzare nel breve spazio di tre anni una tale opera alchemica, sarebbe difficilmente possibile perfino ai più grandi personaggi spirituali che l’umanità ha conosciuto!). Le stesse premesse, condensate in modo efficace dal titolo del ciclo — terrestrità del sole —, a rappresentare una avvenuta integrazione tra cielo e terra, viene tradito in nome di una trascendenza, seppure mai esclusivamente extracosmica, e in una fede troppo vaga in un possibile riscatto terrestre.
Infine, Arturo Onofri sembra non essere mai riuscito a superare, nella propria ispirazione, quella ‘mente illuminata’ che Sri Aurobindo indicava come il secondo (partendo dal basso) dei quattro gradi di ispirazione giungente dall’alto (mente superiore, mente illuminata, intuizione, surmentale), da quella vetta mantrica dalla quale proviene il sommo Logos. Il dominio più consueto, nella poesia onofriana, è la mente superiore, con qualche splendida incursione nella mente illuminata. Nelle sue poesie ci si imbatte talvolta in versi di grande forza ed efficacia, subito soffocate da un ammasso verbale di fattura mentale e vitale. Particolarmente riusciti gli attacchi onofriani, il cui prosieguo, purtroppo, non sempre riesce a mantenere l’altezza. Qualche esempio (noi diamo l’incipit, lasciando al lettore il compito di andarsi a leggere come il prosieguo si sviluppa o, meglio, si stempera) —
Dall’irreale amplesso di sognarlo
ti sei fiorita un corpo di dolcezza. (T.S., CIX)
Nel dormiveglia argenteo dell’autunno,
scintillano al mio passo le memorie
vergini della primavera in sonno,
quando i prati sognavano pianeti,
germogliandone immagini di fiori. (T.S., CXXVII)
Un profumo d’amore agita il petto
della terra in travaglio di fiorire, (V.D., XXXII)
La multipla unità del cielo eterno
colma di sé questo mio petto antico, (V.D., LXVI)
Nel destino che veglia oltre la morte, (V.D., CXV)
Balza da quella pietra, o chiuso fuoco (V.D., CXIX)
Stanco di simmetrie, l’occhio riposa
nell’oceanico etere dei mondi,
che schiuma immensità d’astri nel sole. (Z.R.C., XXXIX)
Musica d’altre sfere, ecco, traspare,
dalla clausura cieca della pietra, (Z.R.C., LXVIII)
Quando avrai pace, anima mia, nel sole? (Z.R.C., LXXXIII)
Nell’ardore d’offrirmi alla tua gloria,
ch’è la luce dei vivi sulla terra,
sfaccio l’arcaico laccio in cui mi serra
un mondo, ch’è mio cumulo di scoria. (Z.R.C., CI)
Il mio volermi oltre me stesso vola (Z.R.C., CXXIII)
Una campana d’oro in alto squilla
dalle ampiezze dei mondi e tocca il cuore
profondo che si sveglia estri di fuoco, (Z.R.C., CXI)
Fa ch’io sia risanato, integro e mondo,
come il pino che sorge senza brama,
dal suolo chiuso, al cielo ampio e profondo
col suo fusto che in verdi aghi dirama. (S.G. XIV)
La luce che da te piove nel cavo
di questa conoscente anima schiusa,
è libertà che innalza il cuor già schiavo (A.F., XXII)
Dalle sembianze argentee del mattino,
l’arcobaleno dei pensieri eterni
serra in tacito cerchio il suo stupore, (A.F., XXVIII)
Una luce che tìmpana dal sole
include nel suo fermo fuoco d’oro (A.F., XLVII)
L’impressione globale che ne risulta, pare essere quella di un artista che non inizia mai a poetare senza sentire in sé la presenza delle Muse, ma subito dopo le abbandona per avviticchiarsi attorno al chiacchiericcio metafisico della sua mente pensante. E tuttavia ci sono liriche, come il sonetto XLIX di Aprirsi fiore, che si snoda in modo non del tutto convincente, per poi concludersi con una splendida terzina:
e in quella goccia d’oro, unica, vive
l’oceano immenso delle tue parole
che ondeggiano di mondi senza rive.
Concludiamo riportando una di quelle liriche inedite che Onofri non inserì in alcuna raccolta, ma che testimonia piuttosto bene la sua originalità e insieme la modernità del suo dettato.
Un prisma d’oro avventa un poliedro
di colori e di squilli: aureole d’aria
azzurra, intorno intorno al vecchio cedro,
svegliandone memoria millenaria.
Fiammei zoccoli guizzano. È il Polledro
del Cielo, quale apparve agli antichi Arya
nel Dodici ch’è in noi: dodecaedro
cosmico in terra: casa planetaria.
Fra i rami or sono uccelli; e li ripara
col frastagliarsi di colori d’oro
la tenebra negli occhi nostri avara;
ma ne riguizza a lampi, di straforo,
un risorgere cieli, dalla bara
del nostro sangue, in albero canoro.
Aprile 2004