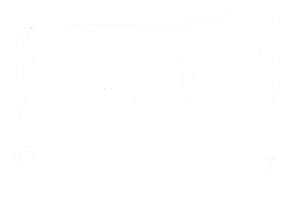LABORA ET LABORA
(a cura del CENTRO STUDI arya)
Nelle strutture sociali dell’antichità, il lavoro era vissuto assai spesso come una spiacevole necessità… accuratamente evitata dalla classe dominante. I nobili cinesi, come è noto, si lasciavano crescere le unghie senza mai tagliarle, proprio per indicare che non si sporcavano le mani. In Grecia il lavoro veniva svolto per la maggior parte dagli schiavi, in modo per lo più coatto. Gli ebrei consideravano il lavoro come una penosa condanna, triste conseguenza del peccato originale. Concetto, quest’ultimo, che il cristianesimo ereditò pienamente. Fu solo in tempi relativamente recenti, ovvero con l’avvento dello spirito della Riforma in epoca tardo-rinascimentale, che il concetto del lavoro assunse una colorazione etica. Le Chiese protestanti, infatti (e in particolar modo i puritani seguaci di Calvino), fondarono il senso moderno del concetto di lavoro come «la base e la chiave della vita»: il miglior modo di glorificare Dio era — secondo tali religiosi — quello di svolgere al meglio la propria professione. Di conseguenza, l’otium, che per i nostri avi latini rappresentava un importante momento di ristoro creativo e di genuino nutrimento estetico-intellettuale, incominciò a essere considerato sinonimo di peccato: “ozio padre del vizio”, come recita l’odioso adagio. In un secondo tempo, allo svanire della pretestuosa giustificazione religiosa, si cercarono analoghi appigli legati alla dignità e al valore del lavoro. In tal modo, la già discutibile e bigotta colorazione etica dei primi puritani è stata deformata e contraffatta ulteriormente nel mondo moderno, in particolare con l’avvento dell’industrializzazione, attraverso il vago concetto del dovere morale e il luogo comune secondo cui, come si suol dire, “il lavoro nobilita l’uomo”. Fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui, con lo svilupparsi dell’importanza dei consumi di massa, si è ricorso sempre più a incentivi puramente monetarî. In altre parole, il lavoro viene oggi considerato dalla stragrande maggioranza delle persone un mezzo noioso (e ingombrante, nel senso che occupa un eccessivo arco di tempo nella breve vita umana) con il quale raggiungere determinati fini materiali. Non a caso Henri Laborit, uno dei maggiori biologi del nostro tempo, ritiene il lavoro una necessità per appagare i bisogni fondamentali, anziché un diritto — «Dopo avere insegnato, fin dall’inizio del neolitico, agli abitanti delle zone temperate del globo che il loro dovere era lavorare col sudore della fronte, questo automatismo culturale si è così ben radicato nel loro sistema nervoso, che essi oggi reclamano il diritto al lavoro, il diritto al sudore della fronte, affinché cresca il mondo consumista e vengano mantenute le gerarchie. Disoccupati, soffrono di non poter realizzare l’immagine ideale di se stessi che questo mondo gli ha inculcato perché ne aveva bisogno» (Laborit, La colomba assassinata).
Non sono certo mancate voci fuori dal coro, ma non sono mai state prese in seria considerazione. Quella di Tommaso Moro, per esempio, nella cui Utopia auspicava, tra le altre cose, una giornata lavorativa di sei ore. Oppure quella di Tommaso Campanella che, nella sua Città del Sole, sognava una società i cui beni fossero messi in comune. Ai giorni nostri, il poeta Octavio Paz, premio Nobel per la letteratura 1990, arriva a affermare che «a misura che la sfera del lavoro si amplia, si riduce quella del riso». Infatti, diventare adulto significa imparare a lavorare, smettere di giocare, diventare serio e formale. «Ma il lavoro — prosegue il poeta con innegabile sagacia — mentre umanizza la natura, rende disumano l’uomo. Il lavoro allontana letteralmente l’uomo dalla sua umanità. E non solo perché trasforma il lavoratore in salariato, ma perché identifica la sua vita con il suo lavoro. Lo rende inseparabile dai suoi attrezzi, lo marchia con il ferro dei suoi utensili. E tutti gli attrezzi da lavoro sono seri. Il lavoro divora l’essere dell’uomo: immobilizza il suo volto, gli impedisce di piangere o di ridere. Certo, l’uomo è uomo grazie al lavoro; tuttavia bisogna aggiungere che riesce a essere completamente uomo quando se ne libera o lo trasforma in gioco creativo» (Passione e lettura). Questo è uno dei motivi che rende lo sfruttamento minorile un crimine atroce e disumano, che strappa al bambino quel diritto al gioco che gli adulti stupidamente tendono a sottovalutare e a rimuovere. Ed è perlomeno curioso notare come la parola ‘piacere’ il più delle volte sia bandita nel vocabolario — e ancor più nella pratica — del lavoro. Quando si vogliono esaltare le capacità lavorative di una persona, per esempio, si parla di “serietà professionale”, e mai di “orgasmo professionale”! Eppure, il piacere è una delle principali e più importanti molle propulsive dell’uomo: nostalgia dell’unità originale e anelito verso una gioiosa riconciliazione con il mondo, con noi stessi, con il tutto.
Lavorare stanca, diceva il poeta Cesare Pavese, che identificava i singoli gesti dell’uomo e il paesaggio in cui vive, descrivendoli con dovizia di particolari e immettendoli in quel vasto ciclo che è appunto la vita. Il lavoro debilita l’uomo, dovremmo quindi dire, modificando il celebre proverbio — giacché, spesso, il lavoro agisce sull’uomo in modo assai nefasto: lo degrada e lo rende schiavo. A meno che, per l’appunto, il lavoro non assuma un carattere apertamente ludico, facendosi strumento per una espressione creativa del proprio essere, della propria interiorità, della propria unicità. Non si fraintenda: considerare il lavoro come un gioco non abolisce affatto la necessità dell’impegno e del rigore; al contrario, sappiamo bene che ogni gioco, per essere veramente divertente e creativo, deve avere delle regole precise che vanno rispettate. Non si può, per portare un esempio concreto, giocare a calcio con il giusto divertimento senza fissare dei limiti al campo, oltre i quali la palla è da considerarsi fuori gioco, così come sarebbe completamente senza senso non stabilire una serie di falli da non commettere nei confronti degli altri giocatori. L’attore teatrale, per proporre un esempio più pregnante e a noi più congeniale, sa bene quanto il suo giocare di fingere d’essere Tizio o Caio richieda assiduo e paziente lavoro, dallo sviluppo delle proprie capacità di introspezione, all’impegno creativo che il compito richiede, come pure a un incessante approfondimento che implichi il coinvolgimento a tutti i livelli possibili del proprio essere, fisico, emotivo, psicologico, e così di seguito.
Ma i cosiddetti potenti giudicano pericoloso un simile concetto (che circoscrivono con cura all’artista, allo sportivo o al saltimbanco, e che non si sognerebbero mai di estendere a tutti quanti), giacché le implicazioni pratiche di tale allargamento distruggerebbero ipso facto le logiche di sfruttamento. La direzione che il mondo del lavoro sta prendendo nei decenni più recenti (con una preoccupante accelerazione e esasperazione negli ultimissimi anni), va anzi nel senso diametralmente opposto, con un aumento impressionante di ingiustizie sociali fatte passare per importanti conquiste verso una maggiore e sibillina ‘flessibilità’ di mercato, grazie anche a un indottrinamento che comincia fin dalla più tenera età. Di grande stimolo, in questo senso, le parole di Silvano Agosti in questo video dal titolo piuttosto esplicito —
IL DISCORSO TIPICO DELLO SCHIAVO
A questo punto, prima di arrivare a parlare dei problemi presenti nel mondo lavorativo attuale, notiamo anzitutto come la maggioranza di psicologi e sociologi siano concordi sul fatto che chi possiede un grado di cultura elevato si rivela essere più scontento nei confronti del tipo di lavoro svolto, più frustrato. Ciò può apparire paradossale e inesatto solo agli occhi di quanti considerano la cultura sinonimo di istruzione — purtroppo, nella realtà dei fatti, non è così. Oggi noi assistiamo a una crescente scolarizzazione e, di conseguenza, a un decisivo e positivo innalzamento del tasso di istruzione generale; e tuttavia, analizzando con attenzione la tipologia di istruzione che viene impartita nelle scuole (pubbliche o private che siano) si nota una forte tendenza verso un ammaestramento il più possibile tecnico e utilitario, finalizzato all’apprendimento di strumenti professionali che rendano più agevole e più efficace il successivo inserimento nel mondo del lavoro. È “l’ammaestramento del pappagallo” di cui si lamentava già il poeta indiano Tagore un secolo fa (in un libello intitolato per l’appunto The Parrot’s Training). Nelle più recenti riforme scolastiche, le discipline umanistiche vengono sempre di più bandite dai programmi, perfino nelle scuole a chiaro indirizzo letterario, privilegiando invece le ormai celebri tre “i”: internet, inglese, impresa — alle quali occorrerebbe aggiungerne una quarta: ignoranza, di sé e dell’essenza delle cose. Questo fatto, unitamente all’indottrinamento quotidiano sciorinato da parte dei mass-media, tendente a una vera e propria esasperazione del concetto di profitto e di consumo, rappresenta la quadratura del cerchio che consente di ‘formare’ individui perfettamente integrati nel ciclo delle moderne società industriali, aventi cioè una sempre più alta competenza e efficienza professionale, ma con una capacità critica ridotta ai minimi termini. Alle tre ‘i’ noi vorremmo quindi affiancare tre ‘a’: arte, ambiente (recante, a sua volta, le tre ‘erre’ degli ambientalisti: riduci i consumi, riutilizza i prodotti, ricicla i rifiuti), associazionismo (inteso, quest’ultimo, come solidarietà e reciproco interscambio a scopi genuinamente culturali, anziché lucrativi). Non si tratta di eliminare le tre ‘i’ (il che ci pare costituirebbe un evidente segno di chiusura in uno sciocco e ridicolo antimodernismo), bensì di integrarle e di subordinarle a valori più autenticamente umani.
A ben vedere, perfino la drastica riduzione di lavoro manuale pesante è da vedere in termini di maggiore efficienza produttiva: già a fine Ottocento, infatti, lo statunitense Frederick Taylor (da cui ebbe nascita il famigerato ‘taylorismo’), si accorse che un lavoratore affaticato è, spesso, un lavoratore poco efficiente e, quindi, poco produttivo.
C’è poi da non sottovalutare il fattore psicologico di rimozione dell’insoddisfazione per il lavoro svolto, proprio per il sentimento collettivo che non essere soddisfatti — di sé o del proprio lavoro — costituisce una vergognosa ammissione di fallimento personale. Oltretutto, la grande quantità di variabili che influenzano il comportamento sul lavoro inducono gli studiosi a una certa cautela nei confronti delle semplificazioni dei fattori inerenti alla soddisfazione. Per fare un esempio, è ormai un fatto assodato che nella maggior parte dei casi il lavoro è influenzato dall’ambiente in cui viene svolto; ma al posto di migliori condizioni ambientali (o addirittura di maggiori guadagni) i lavoratori insoddisfatti avrebbero oggi bisogno di un ambiente migliore nel senso di un trattamento più “umano”. Questo gli imprenditori e i dirigenti aziendali non sanno né possono vedere, abituati come sono a dare, nella loro vita, una eccessiva — quando non addirittura esclusiva — importanza al denaro.
Recenti studi hanno peraltro dimostrato che si potrebbe vivere tutti quanti, e addirittura con un più elevato livello di benessere rispetto all’attuale (ed esteso in modo più equo in senso orizzontale, pur nel rispetto delle dovute differenze meritocratiche in senso verticale, ma senza le attuali assurde esasperazioni), con sole quattro ore al giorno di lavoro (superando quindi le già ottimistiche previsioni di Tommaso Moro), se l’avidità umana non portasse pochi individui a pretendere di accumulare ricchezze smoderate. Oggi, nel mondo, l’avidità di appena duemila persone straricche è causa della povertà di ben quattro miliardi di esseri umani. I patrimoni dei tre uomini più ricchi del pianeta superano il PIL (prodotto interno lordo) dei paesi meno sviluppati, cioè di qualcosa come seicento milioni di esseri umani condannati alla povertà e alla fame. Se soltanto venissero distribuite le ricchezze dei cento uomini più ricchi, si risolverebbe all’istante il problema della fame nel mondo. Non saremo certo noi a proporre di espropriare le ricchezze di questi signori, intendiamoci — neanche se ne avessimo il potere. Se essi sono così gretti e poveri di spirito da tenere strette a sé quelle ricchezze economiche che la vita ha dato loro (o che hanno strappato con furti e intrallazzi varî, a seconda dei casi), ebbene, tant pis pour eux. Tuttavia ci pare utile, di tanto in tanto, riflettere su questi fatti, anziché fare come gli struzzi. Fa bene guardare gli uomini più ricchi della terra per ciò che realmente sono, e cioè esseri meschini, avidi, cinici, profittatori, insensibili e gretti, anziché vederli come dei modelli da imitare.
In più, come accennavamo prima, il crollo del cosiddetto “socialismo reale” ha determinato negli ultimi anni un forte sbilanciamento — ci auguriamo provvisorio — nel già precario equilibrio esistente tra Capitale e Lavoro, rendendo quest’ultimo assai più debole, con la nefasta conseguenza di un notevole peggioramento della condizione dei lavoratori; è ormai un fatto sotto gli occhi di tutti la preoccupante perdita di molte conquiste sociali che negli anni Sessanta e Settanta erano state ottenute grazie a faticose lotte (qualcuno porta ancora sul proprio corpo i segni delle randellate della polizia) e a legittime rivendicazioni sindacali.
Il diritto dei lavoratori a essere rappresentati e tutelati sindacalmente è piuttosto recente, dato che la sua necessità è stata sentita in modo particolarmente acuto proprio con la nascita dell’industrializzazione, che ha aperto tutta una serie di problematiche legate al lavoro di fabbrica e ai suoi stressanti ritmi di produzione. In più, l’aumento demografico e la cosiddetta “apertura del mondo del lavoro alle donne” (come se prima dell’industrializzazione le donne non lavorassero!) hanno reso ancora più urgente l’esigenza di creare un organismo a tutela della forza lavoro. Ecco dunque che i lavoratori hanno dato nascita alle moderne organizzazioni sindacali (in Italia, nel 1906, con il nome di Confederazione generale del lavoro, CGIL). Già — quelle stesse organizzazioni sindacali che ai giorni nostri si cerca in vario modo di rendere innocue e di allontanare dal tavolo delle trattative. L’affermazione che “oggigiorno è finito il tempo dei sindacati” è diventata ormai un inappropriato luogo comune che viaggia pericolosamente di bocca in bocca.
Oggi sentiamo parlare con sempre maggiore insistenza di ‘flessibilità’ — un termine vago e colmo d’ipocrisia, che serve in realtà a occultare il vero obiettivo dei possessori di grandi capitali, interessati a rendere il lavoro sempre più precario e, di conseguenza, a far sì che il lavoratore sia più facilmente ricattabile e quindi sempre più debole e sottomesso.
Questo inopportuno squilibrio di forze ha esasperato a tal punto la situazione che, in Europa, perfino i varî partiti laburisti (o progressisti, che dir si voglia) si sono trovati costretti — in parte anche per mancanza di coraggio e di fedeltà ai loro stessi principî ispiratori di base — a fare pesanti compromessi in materia occupazionale.
Oltre al fatto che, in un clima di precarietà economica come il presente, dovuto anche a fattori e circostanze cosiddette congiunturali, i partiti dei capitalisti, interessati a conservare il vecchio stato di cose (e per ciò detti ‘conservatori’), sono riusciti a trovare ampi consensi perfino tra molti di quei lavoratori che per forza di cose non potranno mai essere da essi sinceramente rappresentati e tutelati. Ci sono esempi — quello italiano in primis — in cui ricchissimi imprenditori sono andati al potere (portando con sé il loro stuolo di lacché) grazie all’appoggio dei lavoratori, i quali credevano in tal modo di vedere migliorate le loro condizioni, in termini di maggiore benessere personale, di riduzione delle tasse e di maggiore efficienza dei servizi sociali. Il risultato, ovviamente, è l’esatto opposto (ovvero, il congelamento salariale, l’aumento delle tasse e una scellerata privatizzazione di scuole, ospedali, riserve naturali, ville storiche e quant’altro), ma la pesante demagogia e l’indisponibilità ad affrontare una seria e costruttiva autocritica da parte dei politici di sinistra, unita all’abilità stregonesca dei politici di destra a illudere gli elettori (grazie anche a situazioni di pressoché monopolio degli organi di informazione massmediatici) ha reso possibile l’impossibile: la vittima è arrivata a offrire il proprio voto di fiducia al suo stesso carnefice, auto-immolandosi sull’altare del consumismo più selvaggio!
Per concludere con una nota divertente (talvolta esorcizzare il male può essere un rimedio contro lo sconforto!), un capo indigeno delle isole Samoa, un certo Tuiavii, agli inizi del XX secolo compì un viaggio in Europa, venendo a contatto con gli usi e i costumi del “Papalagi”, ovvero dell’uomo bianco. Ne trasse delle impressioni folgoranti che mise sulla carta al fine di mettere in guardia il proprio popolo sul fascino perverso di quell’occidente che, da sempre, cerca di “civilizzare” questi popoli (ossia, di renderli schiavi). Erich Scheurmann, un artista tedesco fuggito nei mari del Sud per evitare la prima guerra mondiale, raccolse queste riflessioni e le pubblicò. Il titolo è, per l’appunto, Papalagi. Ne diamo qui un breve estratto, in cui Tuiavii riflette sul concetto che “l’uomo bianco” ha del lavoro. È ovvio che lo sguardo mordace, ma anche profondamente ingenuo, di questo simpatico capo-tribù, non può costituire una risposta alle contraddizioni sollevate nel presente articolo. Ma è perlomeno interessante guardare l’attuale civiltà con gli occhi di qualcuno che, come una sorta di ‘extra-terrestre’, osserva l’intricato congegno dall’esterno, e cerca di comprenderne i meccanismi.
«Non è possibile, nei paesi degli uomini bianchi, rimanere anche una sola volta, dall’alba al tramonto, senza denaro. “Lavora e avrai denaro”, recita una delle regole degli europei. Bisogna riconoscere che se sono necessarî molto metallo rotondo e carta pesante per ogni cosa, puoi anche riceverne facilmente. Devi solo fare una cosa che in Europa chiamano ‘lavorare’. Domina però una grande ingiustizia, sulla quale il Papalagi non riflette, e non vuole riflettere, perché allora dovrebbe riconoscere la sua stessa ingiustizia. Non tutti quelli che hanno molto denaro lavorano molto (tutti vorrebbero avere molto denaro senza lavorare). Le cose vanno così: quando un bianco guadagna abbastanza da poter mangiare, avere la sua capanna e le sue stuoie, e qualcosa di più, con il denaro che ha in più fa immediatamente lavorare il suo fratello. Per sé. Del denaro che quello produce, e che quindi dovrebbe avere per intero, gliene prende una parte, la più grande, e non appena può fa lavorare per sé due fratelli, e poi tre; sempre più fratelli devono costruire barche per lui. Finché non deve fare più niente, oltre a stare steso sulla stuoia, bere e bruciare rotoli da fumare, consegnare le barche pronte e farsi portare il metallo e la carta, che altri producono per lui. Allora si dice: è ricco. Lo invidiano, gli fanno complimenti e gli dicono cose altisonanti. Perché l’importanza di un uomo nel mondo dei bianchi non è data dalla sua nobiltà interiore o dal suo coraggio o dalla brillantezza della sua mente, ma dalla quantità del suo denaro, da quanto ne può fare ogni giorno, da quanto ne tiene rinchiuso nella sua pesante cassa di ferro che nessun terremoto può distruggere. Ci sono molti bianchi che accumulano il denaro che gli altri hanno fatto per loro, lo portano in un luogo ben protetto, ve ne portano sempre più finché un giorno non hanno bisogno più di nessun lavoratore, perché adesso è il denaro stesso che lavora per loro. Non ho mai ben capito come ciò sia possibile senza una terribile magia; ma le cose stanno veramente così, il denaro aumenta sempre di più, come le foglie degli alberi, e l’uomo diventa sempre più ricco, anche mentre dorme. Ora, quando uno ha molto denaro, molto di più della maggioranza degli altri, tanto che cento, anzi mille persone potrebbero rendere con quel denaro il loro lavoro più leggero, questa persona con molto denaro non dà niente; mette le sue mani sul metallo rotondo e si mette sopra la carta pesante con l’avidità e la voluttà negli occhi. E se gli chiedi: “Cosa vuoi fare con tutto questo denaro? Su questa terra non puoi fare molto di più che vestirti e placare la tua sete e la tua fame”, lui ti dice: “Voglio fare più soldi; ancora di più”. E ti accorgi subito che il denaro lo ha fatto ammalare, che tutti i suoi pensieri sono posseduti dal denaro. Non riesce a pensare: “Voglio andare via dal mondo senza sforzi e senza ingiustizie, così come ci sono venuto, perché il Grande Spirito mi ha mandato sulla terra senza il metallo rotondo e la carta pesante”. A questo sono pochi a pensarci. I più rimangono nella loro malattia» (Papalagi).
Non è passato poi così tanto tempo da quando si andava presso queste tribù ‘pagane’ per ‘civilizzarle’ (anzi, capita ancora, di tanto in tanto) e per dare a ognuno dei suoi componenti la possibilità di diventare persone per bene, coprire le loro vergognose nudità e insegnar loro a lavorare per poter avere il sommo privilegio di condividere la grande civiltà occidentale e meritarsi infine il paradiso che il Buondio ha preparato (solo per i consumatori cristiani, ovviamente).
In questo nostro mondo, come diceva saggiamente Blaise Pascal, «c’è abbastanza luce per chi vuole vedere e abbastanza buio per chi non vuol vedere». Ma c’è anche, purtroppo, chi si arroga il diritto di spegnere la luce a proprio piacimento onde occultare i propri intrallazzi al fine di manovrare le masse per una più rapida ed efficace realizzazione dei suoi loschi fini. Perciò, prima ci decideremo a tenere gli occhi bene aperti, meglio sarà per tutti.
Festa del Lavoro, 1° maggio 2003