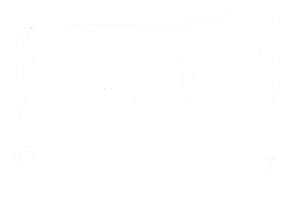La Parola creatrice
di Tommaso Iorco
(autore tutelato S.I.A.E.)

Generalmente, per noi la parola ha un valore perlopiù mentale, tendente a dare una connotazione del tutto convenzionale a ciò che vuole rappresentare. Il fatto che il ruscello si chiami ruscello e non in altro modo, per esempio, appare come una semplice convenzione stabilita agli albori della lingua italiana (o meglio latina); possiamo magari compiere una ricerca etimologica, tentare di ricostruirne la genealogia, risalire al latino volgare riuscellus, derivato a sua volta dal latino rivus, con la caduta della -v- intervocalica (da cui anche ‘rio’), già biasimata nel III sec. d.C. nell’Appendice di Probo; spingendoci ancora oltre, possiamo perfino rintracciare la probabile radice indoeuropea originaria, passando dal serbo-croato rijeka, ‘fiume’, per finire in termini sanscriti quali raya, rîty, rûdha, retas, tutti esprimenti l’atto di scorrere (perlopiù di un fiume), per approdare infine alle radici rei, ruj, per l’appunto collegate al senso del fluire, dello scorrere… ma tutto ciò non ci mostra ancora una eventuale connessione vibratoria con la cosa in sé.
Tuttavia, esistono antichissime concezioni secondo cui la parola, in stati di coscienza via via più profondi, si riapproprierebbe della sua potenza originaria, diventando una forza realmente creatrice e formatrice. C’è una qualche verità in questa intuizione, oppure ci troviamo soltanto di fronte a un “mito”? E, se la parola avesse davvero diversi gradi di potenza, quale relazione intercorrerebbe tra questi più alti livelli e l’umano linguaggio?
È innanzitutto interessante notare come dal concetto vedico di vac (la parola, con i suoi quattro gradi, padâni, ripresi e sviluppati ulteriormente nel Tantra), a quello greco del logos (di cui resta qualche traccia nel Vangelo di Giovanni: «Al principio era il Verbo», en arké en o Lógos), alla Qabalah ebraica (testi come il Sepher Yetzirah ne sono una evidente testimonianza, ponendo una precisa connessione tra i varî attributi del principio creativo con ciascuna delle ventidue lettere dell’alfabeto ebraico), fino ad arrivare a tutta quanta la poesia realmente ispirata (non a caso l’antico bardo era considerato nelle varie culture un veggente, sophos,vates, aruspex, kavi), alla parola è stata conferita una valenza mantrica che vorremmo qui brevemente illustrare, onde suscitare riflessioni e, magari addirittura, stimolare i dovuti approfondimenti.
Cominciamo col notare che le parole non nascono come prodotti artificiali, bensì come qualcosa di vivo che si sviluppa da suoni-seme, da cui si diramano un certo numero di suoni-radice (dhâtavah shabdayonayah, “le radici sono l’origine delle parole”, affermò giustamente l’antico grammatico sanscrito) che, a loro volta, danno vita al grande albero linguistico con le sue innumerevoli ramificazioni. È del tutto probabile che, ai loro inizi, i suoni del linguaggio non dovettero essere usati per esprimere dei concetti complessi o delle idee, ma unicamente per la loro equivalenza fonica con certe sensazioni. Ritornando alla parola ‘ruscello’, e al suo suono-radice, scopriamo ad esempio che la vibrazione della vocale sanscrita -r- fu associata a uno stato d’esistenza vibrante, pulsante nello spazio, attivo in un determinato punto, che si muove e procede entro limiti dati. Collegando tale suono vocalico puro alle varie consonanti, eccoci dunque alle sopracitate radici ruj, rei e a tutte le parole da esse derivate — compreso il nostro bel ruscello! Ormai, è peraltro opinione condivisa da tutti i linguisti più accreditati che la nostra meravigliosa lingua italiana è (al pari di tutte le altre lingue dell’area del Mediterraneo e oltre ancora) una sorta di dialetto dell’antico indoeuropeo originario, di cui il sanscrito vedico è la forma storicamente più vetusta conosciuta.
Con il passare del tempo, le parole si sono evolute in simboli fissi, rivestendo significati mentali sempre più precisi. Dapprincipio, come abbiamo visto nell’esempio, è il suono che determina il senso di una parola; mentre, alla fine della curva evolutiva del linguaggio, l’idea assume importanza predominante, inversamente al suono, che diventa a essa subordinato e, quindi, secondario. Tale progressione si muove dal generale al particolare o, per meglio dire, dal concreto all’astratto. Così sono nate tutte le lingue parlate dall’uomo, seguendo leggi sostanzialmente analoghe, adattate ovviamente ai diversi fattori ambientali e alle diverse circostanze intercorrenti tra i differenti gruppi di uomini che hanno preso a parlare una medesima lingua. Il vero poeta, tuttavia, riesce ancora a percepire la valenza vibratoria della parola, e ad essa accorda la sua giusta importanza, rifiutandosi di limitarla alla sola valenza razionale, al suo significato mentale. L’attore, similmente, presta la massima attenzione nello scandire bene ogni singola parola, al fine di metterne in luce la musicalità intrinseca, cercando di dare il giusto rilievo alle consonanti e l’appropriata valenza sonora alle vocali.
Potremmo dire che il linguaggio, partendo dalla Natura fisica, è andato oltre di essa, perfezionandosi e svilendosi al tempo stesso. Perché, se da una parte la possibilità di esprimerci con una maggiore precisione intellettuale e psicologica ci ha arricchito notevolmente, dall’altro, come si diceva, ciò è avvenuto perlopiù a discapito della pura forza sonora. In ogni caso, il fatto che noi si possa creare, attraverso la parola, qualcosa che non esiste nel mondo osservabile dai cinque organi di senso — un pensiero astratto di tipo metafisico, per esempio, come il concetto di un Assoluto pervadente e trascendente al tempo stesso la formula universale — costituisce una prova della forza creatrice della parola: chiunque sia in possesso degli strumenti linguistici adeguati, può costruire in sé un’immagine in certa misura corrispondente al concetto medesimo. E ogni qualvolta leggiamo una poesia nella quale le immagini, i suoni, i termini in essa utilizzati sono in grado di suscitare in noi delle sincere emozioni, riuscendo spontaneamente a far vibrare corde assai profonde dentro di noi, non facciamo altro che confermare nella pratica tale magia creatrice della parola. Ovviamente, il vero e proprio verbo mantrico viene afferrato assai raramente dall’uomo, ma vi sono tuttavia momenti di grazia in cui la poesia è realmente ispirata, riuscendo a calarci qualcosa dei ritmi vasti e gioiosi risuonanti nelle sfere attualmente sovracoscienti e subliminali dell’essere. Come dice Sri Aurobindo, «il linguaggio umano al suo culmine tenta semplicemente di ritrovare attraverso la rivelazione e l’ispirazione un’assoluta espressione di Verità che già esiste nell’Infinito al di sopra della nostra comprensione mentale. Ciò implica, di conseguenza, che la Parola deve trovarsi al di là del nostro potere di costruzione mentale» (The Supreme Word).
E, trasponendo tale potere creativo alle sue vette più eccelse, arriviamo alle antiche concezioni della Parola creatrice dell’universale realtà. L’intero universo sarebbe nato dalla vibrazione sonora scaturita nel seno dell’Assoluto, shabda-brahman. La Parola, vak (latinovox), è così diventata tutti questi mondi, come dice il poeta vedico, vâgeva vishvâ bhuvanâni jajñe. Agni, il fuoco mistico che arde dentro di noi, principia le sue funzioni di mediatore tra l’umano e il divino proprio in veste di voce umana, agnir vâg bhûtah. Per questo i veggenti vedici erano persuasi che i loro inni avessero il potere — carro di fuoco delle settuplici estasi — di aiutarli a compiere efficacemente il loro viaggio spirituale.
Esiste quindi una corrispondenza, per quanto approssimativa, tra la suprema Parola creatrice e l’umano linguaggio. Possiamo anzi dire che la poesia mantrica è una sorta di invisibile ponte che ci permette in qualche modo di colmare l’abisso tra l’uno e l’altra. Abhinavagupta, il grande mistico kashmiriano, ha definito questo ponte sospeso tra la Parola suprema, paravac, e la Parola ordinaria, vaikharî, con il suggestivo nome dipashyanti, ovvero “la Parola che vede”: una parola, quindi, che veicoli non soltanto un significato mentale, ma una vera e propria visione della Verità. Visione che, secondo il Rig Veda, è ‘ascolto’ del Verbo, shruti. Certo, la parola umana, per quanto elevata, resta sempre un potere derivato del sommo Logos, e tuttavia mantiene in sé qualcosa della sua forza creatrice originaria,mantrashakti — un’ombra luminosa, un riflesso dorato.
L’Assoluto, il Brahman upanishadico, «esprime per mezzo della parola una forma o una figurazione di se stesso negli oggetti sensoriali e coscienziali che costituiscono l’universo, proprio come la parola umana esprime un’immagine mentale di quei medesimi oggetti. Quella suprema Parola è creatrice in un più profondo e originale senso rispetto alla parola umana, e con un potere di cui la più alta creatività dell’umano linguaggio costituisce soltanto una lontana e debole analogia» (Sri Aurobindo, op.cit.). Tuttavia, ciò è sufficiente a colmare la parola umana degli echi dell’infinito da cui proviene, rendendola un estremo significante che, in una qualche misura, può ricondurci alla sua divina fonte.
La concezione del mantra prende spunto proprio da tale magica corrispondenza. Il mantra è una parola di potere, una parola che possiede il potere di rendere manifeste dentro di noi le verità racchiuse in essa, in forma di armonia — armonia conoscitiva, estetica, emotiva, psichica. È infatti risaputo che il mantra è in grado di creare in noi stati di coscienza soggettivi che sono assolutamente reali per colui che li sperimenta, così come può rivelarci delle conoscenze che ignoravamo, o addirittura può creare delle vere e proprie forme fisiche. A tal proposito, sappiamo che recentemente sono stati condotti da alcuni scienziati degli esperimenti effettuati sulle vibrazioni dei canti di monaci tibetani: ponendo un sottile strato di sabbia su una superficie piana molto liscia, si è potuto rilevare che i granelli di sabbia rispondevano alle vibrazioni fisiche del canto formando delle strutture geometriche di grande simmetria e precisione, quasi deimandala. Similmente, un attore del calibro di Riszard Cieslak era in grado di far saltare un bicchiere di cristallo emettendo dei semplici vocalizzi — e ciò non in virtù del volume della voce (come nel caso di Ella Fitzgerald), assolutamente moderato, bensì entrando in contatto con il grado di risonanza del bicchiere, se così si può dire.
Ovviamente, la coscienza e l’udito interiore di chi ascolta il verbo poetico vanno affinati notevolmente per essere in grado di cogliere i diversi gradi di potere mantrico che giungono al nostro orecchio fisico. Prendiamo ad esempio quel famosissimo verso di Virgilio che tanta ammirazione suscitò tra i Romantici:
Sunt lacrimæ rerum et mentem mortalia tangunt.(Eneide, I.462)
Per alcuni, questo verso può apparire semplicemente come un insieme di parole tendente a esprimere con singolare efficacia e stringatezza l’amara percezione della sofferenza insita nell’umana vita; altri, invece, vi possono vedere un affascinante e geniale incontro di sublime sonorità e di mirabile immagine poetica; altri ancora, infine, possono arrivare a coglierne l’essenza vibratoria più autentica, sentendolo pregno di echi provenienti da un piano di coscienza posto al limitare tra l’umano e il divino dal quale il poeta ha tratto la propria ispirazione.
D’altronde, una qualche preparazione è necessaria per poter fruire adeguatamente di ogni forma d’arte. Di fronte al ritratto di Monna Lisa, molti non provano nessuna emozione particolare che vada oltre l’apprezzamento della bravura tecnica dell’Autore. Ma se si trattasse solo di perfezione tecnica, allora un Richard Estes sarebbe forse da considerare superiore al divino Leonardo. Invece, è proprio quando attraverso la superficie di ciò che è visibile l’artista riesce a mostrare — a chi sa guardare e ascoltare nel modo giusto — l’essenza spirituale insita nella realtà, che egli crea la vera opera d’arte. La grandezza del ritratto di Monna Lisa non sta nella perizia tecnica, ma nell’aver mostrato (grazie anche alla padronanza della tecnica espressiva, ovviamente, ma soprattutto in virtù dell’ispirazione e della forza creativa che pervade l’artista e lo attraversa come un canale di armonie superiori) lo spirituale nel sensibile, a essere dunque riuscito a darci una rappresentazione concreta e sublime di quanto Jaspers definiva la «spiritualità nel corporeo».
È questo il vero compito dell’Arte, e la poesia non fa certo eccezione. Anzi, la poesia, grazie a questo suo connubio intrinseco e oltremodo intrigante tra significato verbale e incorporea musicalità, può forse meglio di tutte le altre arti condurci nel sancta sanctorum dell’estasi creativa del divino Artista; lo strumento peculiare del poeta è infatti la visione, proprio come per il pittore, ma ad essa si aggiunge l’orecchio del musicista, giacché la poesia richiede non solo intensità di visione e di significato, ma anche di ritmo. È mediante la suprema e assoluta Gioia d’essere (ânanda) — ci dicono i sommi poeti delle Upanishad —, che tutti questi mondi sono nati e si sviluppano e crescono, così come è all’Ananda che ogni cosa volge e in cui trova il suo supremo compimento.
© Agosto 2002