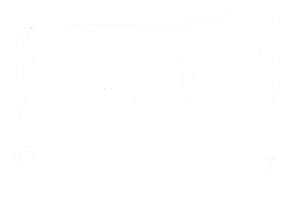UNA TAPPA INEVITABILE:
MEMENTO MORI
di Mario Gregori
(“Occidente Buddhista”, nr. 17/18, luglio-agosto 1997)
Negli anni ‘60, in uno dei tanti licei italiani, un insegnante di filosofia, che preferisco non nominare (de cuyo nombre no quiero acordarme, direbbe Miguel Cervantes), a uno studente che gli domandava il suo parere sul sistema Yoga, rispose molto sbrigativamente, suggerendo di "lasciar perdere simili dottrine che, esortando a liberarsi del cosiddetto Velo di Maya, quindi del corpo, praticamente sono una specie di indiretto incoraggiamento al suicidio". Lungi da me, ovviamente, l’atteggiamento di codardo oltraggio nei confronti di un docente coscienzioso e dalle indubbie capacità didattiche; non posso tuttavia fare a meno di notare come, con la succitata considerazione, pregna di schopenhaueriano pessimismo, egli abbia dimostrato di essere caduto nella trappola di quelli che Francis Bacon (1) chiamava idola theatri, o, più specificamente idola scholae, cioè le forme di conoscenza distorta, non direttamente sperimentale, filtrate attraverso la visione personale di un autore o di un insegnante, con particolare riferimento a quelli delle scuole filosofiche e alla loro pretesa di risolvere tutto in sillogismi. Uno di questi idola è sicuramente la tendenza idiocentrica - comune a ogni cultura -, che porta a valutare in modo soggettivo ogni forma culturale diversa dalla propria, adottando i parametri delle proprie tradizioni, filosofiche, religiose, sociali, e via dicendo. Per quel che riguarda il contesto occidentale, è un dato di fatto che l’insegnamento filosofico nelle scuole medie superiori sia limitato ad una carrellata storica del pensiero occidentale dai Greci fino ad oggi; a causa dell’esigua disponibilità di tempo, spesso tutto si riduce a livello nozionistico, senza i necessari approfondimenti; non è raro il caso in cui le convinzioni religiose o politiche degli insegnanti fanno sì che alcuni filosofi vengano messi al bando mentre altri vengano privilegiati per strumentalizzazioni ideologiche di vario genere. In un simile contesto le filosofie orientali sono state metodicamente ignorate, quando non addirittura travisate. Un caso tipico è proprio quello di Arthur Schopenhauer (2) che, se ha avuto il grande merito di contribuire alla diffusione delle dottrine orientali in Occidente, mutuando elementi dottrinali dalle tradizioni vedica, upanishadica e buddhista, ne ha dato una sua interpretazione personale non sempre fedele, che ha causato spesso malintesi. La premurosa esortazione del summenzionato insegnante dimostra come spesso, ignorando il saggio motto baconiano Omnia experiri (3) e fidandocisi del sentito dire (seppur proclamato ex cathedra), si possano prendere delle cantonate mostruose. É vero che in Occidente, negli anni ’60, dottrine come lo Yoga, il Buddhismo e altre dottrine orientali erano agli albori della diffusione e trovare maestri qualificati o testi autorevoli in materia non era facile come ai giorni nostri; eppure, sarebbe bastato consultare uno dei più elementari manuali di Yoga, già allora reperibili, per rendersi conto che il liberarsi del Velo di Maya, ben lungi dall’idea del suicidio, indica il trascendere, mediante la pratica assidua, i condizionamenti della natura materiale e arrivare a percepire la realtà così come essa è realmente: vi è in ciò una similitudine con lo scostare il velo di Iside, tappa finale del percorso iniziatico delle scuole esoteriche di tradizione egiziana. Quanto al suicidio poi, soprattutto in ambito buddhista, anche da un’analisi superficiale risulta quanto sia considerato un atto negativo, non meno che in ambito cristiano. I riferimenti dottrinali in merito sono innumerevoli, ma un esempio che mi sembra particolarmente adatto al caso, è quello del venerabile Lama Lodrö (4) che, a un discepolo che gli domandava se sia possibile suicidarsi mentre si hanno pensieri positivi, rispose: "Assolutamente no. È impossibile che un essere si suicidi mentre si trova in uno stato mentale positivo. È una contraddizione in termini. Se, grazie alla pratica della meditazione, una persona ha raggiunto un certo livello di comprensione, essa rifletterà sulla sofferenza cui sono soggetti tutti gli esseri, e avrà il desiderio di continuare a impegnarsi per la loro liberazione. Non ingannerà se stessa illudendosi che da un'azione negativa come il suicidio possa derivare qualcosa di buono. In alcune culture, il suicidio rituale è tenuto in alta considerazione. Fra quelle genti, l'orgoglio per la propria immagine dopo la morte viene spesso confuso con qualche tipo di realizzazione. Tuttavia i Buddha non si suicidano mai". Se il buon Schopenhauer e i suoi epigoni - sotto la guida di qualche Guru, piuttosto che delle proprie capacità interpretative - avessero approfondito l’analisi delle dottrine vediche e buddhiste, oltre a ricavarne significative ispirazioni di vita, probabilmente avrebbero dato di tali dottrine una versione meno distorta evitando soprattutto di far etichettare come nichilismo la realizzazione della vacuità, o come pessimismo la consapevolezza dell’impermanenza e della morte. A proposito di sofferenza, ho sentito una ricorrente obiezione di matrice genericamente cristiana, secondo la quale l’idea di una sofferenza dominante sull’esistenza materiale sarebbe estranea al cristianesimo; a prescindere dal classico motto latino sic transit gloria mundi (così passa la gloria del mondo) - mutuato dalla tradizione imperiale, ma ancora familiare in contesto cattolico-romano - vorrei rispondere con una pacata domanda: non appartiene forse al contesto cristiano il frequente riferimento a quella famosa lacrimarum vallis, valle di lacrime, dalla quale la Divina Grazia dovrebbe salvarci e che ogni moribondo dovrebbe abbandonare senza rimpianti (nonostante qualche meno fervido praticante sostenga che ci si piange così bene...)? Coloro che tacciano la Dottrina del Buddha di pessimismo alludendo alla realistica constatazione della sofferenza e della sua origine, dimostrano, a mio avviso una certa dose di superficialità; si potrebbe parlare di pessimismo se tutto si riducesse ad un’unica, perpetua sofferenza senza alcuna via d’uscita. E non è così, dal momento che, nel corso dei secoli e in contesti culturali diversi, varie epifanie divine, come Krishna, il Buddha storico Shakyamuni, Gesù Cristo o Mohammed, hanno rischiarato e rischiareranno con il loro insegnamento la via dell’emancipazione spirituale, offrendo l’efficace mezzo per stroncare la catena delle sofferenze samsariche. Questa via non è - come si è visto - il suicidio, né un nichilismo ol-tranzista (che, se mai, potrebbe essere causa di sconforto e sofferenza ancor maggiore), ma il Nirvâna (in Pali Nibbâ-na). Questa parola, troppo spesso usata a sproposito e spesso fraintesa (a volte intenzionalmente) significa, letteralmente, senza angoscia e indica quello stato di coscienza nel quale si trova chi, avendo superato tutti i condizionamenti della natura materiale e avendo realizzato la piena comprensione della realtà ultima dei fenomeni, cioè la Perfezione della Saggezza, è andato al di là dei limiti dell’esistenza e del mondo fenomenico, raggiungendo la Realtà Assoluta in uno stato - come lo definisce il Buddha stesso - non-nato, non-originato, non-creato, non-formato. Una simile meta, ben lungi dall’essere l’estinzione totale nel nulla - come sostiene chi taccia la Buona Dottrina di pessimismo nichilista - è piuttosto uno stato trascendentale di perfetta beatitudine e consapevolezza, che comunque non è esprimibile in termini convenzionali; è la terza delle quattro Nobili verità (Arya-satyâni): la Cessazione o Estinzione (Nirodha) della Sofferenza (Duhkha), che si realizza mediante la Via conducente alla cessazione della Sofferenza (Duhkha-nirodha-gaminî-pratipad), nota anche come Ottuplice Sentiero (Ashtânga-mârga), cioè la quarta Verità.
La riflessione, sull’impermanenza (Anitya) e la morte è di fondamentale importanza per la comprensione delle altre due verità: la Sofferenza (Duhkha) e la sua Origine (Samudaya). I testi canonici (5) narrano (e non sarà male ricordarlo) che proprio la vista di un vecchio malato, di un morto e di un asceta costituirono lo stimolo che spinse il giovane Gautama Siddharta al percorso spirituale verso l’illuminazione.
In un testo tantrico shàiva, la Shiva Samhitâ (I-69) si legge: "Il Signore ha voluto creare le sue creature; dalla sua volontà è scaturita l’avidya, la madre di questo falso universo". L’ignoranza (Avidya) gioca un ruolo significativo nella generazione della sofferenza: non è una semplice mancanza di erudizione, quanto una tragica forma di inconsapevolezza primordiale, è quel già citato Velo di Maya che ci fa percepire la realtà in modo distorto e causa prima di ogni manifestazione materiale: rimuoverlo e liberarsene quindi, ben lungi dal suicidarsi, significa vivere intensamente, ma al di fuori dei condizionamenti samsarici, poiché ogni azione, guidata dalla consapevolezza, non produce ulteriore karma. L’ignoranza è quel fattore che fa vivere gli esseri senzienti nell’illusione che questa dimensione materiale sia eterna e immutabile; possiamo ben immaginare la delusione e l’infelicità, allorché devono loro malgrado constatare come tutto cambia, decade, perisce. Molto significativa in tal senso, la storia di Kisâ-Gotamî (6), una madre affranta per la morte del figlioletto. Recatasi dal Buddha per chiedere un rimedio, questi le disse di procurargli un seme di senape, preso da ogni casa dove non fosse morto nessuno. La donna dapprima cercò inutilmente il seme, quindi aderì all’ordine monastico, avendo acquisito la consapevolezza che: "Non è questa legge di villaggio e neppure di città, né è la legge di una sola stirpe, ma in tutto il mondo ed anche per i deva nel cielo questa è la legge: "tutto è impermanente!"".
Un grande acharya vàishnava di questi tempi, Bhaktivedanta Svami Prabhupada, era solito gratificare con l’epiteto di mascalzoni tutti quegli scienziati che si affannano a dimostrare che la scienza è in grado di risolvere e dare una risposta a tutti i problemi dell’universo e dell’umanità, secondo quanto pretende la corrente positivista; qualcuno potrà pensare che il venerabile acharya mancasse di tatto o spirito compassionevole, ma ascoltare eminenti scienziati (magari insigniti di prestigiosi riconoscimenti ufficiali) dichiarare che "tutto quello che era da scoprire è stato scoperto e, se ci fosse ancora qualcosa da scoprire, lo scopriremo a breve termine" credo che dovrebbe, come minimo, far pensare a una punta di presunzione, quando non addirittura di demagogia, soprattutto allorché oltre a illudere se stessi, fanno illudere le masse, dicendo di essere ben avviati per scoprire il segreto dell’eterna giovinezza e dell’immortalità. Basterebbe considerare il dispendio di energie e di risorse, impiegato per dimostrare la superiorità dell’essere umano sulla Natura - spesso con risultati catastrofici -, per considerare che molto probabilmente il mito di Faust non ha insegnato loro proprio nulla. Il mahasiddha Lûyipa avrebbe risposto a loro proprio come al re Indrapâla, "Mi serve solo un metodo per sconfiggere la vecchiaia e la morte": lo stile apparentemente paradossale della risposta è quanto mai appropriato alla circostanza, considerando i limiti insormontabili della scienza umana. Ed ecco ancora in tutta la sua prepotente ineluttabilità il tema dell’impermanenza, e soprattutto, della morte: un tema assai poco popolare, soprattutto di questi tempi. É un argomento molto scomodo e spesso si cerca di evitarlo. Qualcuno, al solo sentirne parlare, si profonde negli scongiuri più disparati, spesso accompagnati dagli ancestrali mudrâ di rito, più o meno ortodossi che siano. Le parole morte, morire, risultano sgradite ed è diffusa l’abitudine di ricorrere a sinonimi o perifrasi come passare a un’altra dimensione o altri eufemismi, quasi a voler esorcizzare il fatale evento; che dire poi dell’uso - ormai assai diffuso fra i cronisti radiotelevisivi - di usare il termine vittime invece di morti? Premesso che il termine in sé indica anche i feriti o altri danneggiati da qualche evento negativo, pensano forse che gli esseri in questione sarebbero meno morti o le loro spoglie meno cadaveriche, se li definissimo come vittime, defunti, passati a un’altra dimensione, e via dicendo, oppure che un semplice eufemismo o una perifrasi ci eviterà la stessa sorte? No di certo. Il motivo di questo terrore è l’attaccamento (upâdâna), dovuto all’illusione che ci fa identificare con i corpi che prendiamo vita dopo vita. Nella convinzione che questa sia l’unica forma di esistenza, ottenebrati dall’ignoranza che ci fa dimenticare della nostra natura spirituale, ci preoccupiamo oltremodo del benessere fisico e dedichiamo molto tempo alla soddisfazione di esigenze primarie o voluttuarie, dimenticando il reale corso della vita, a seguito del quale il corpo cambia continuamente, passando dall’infanzia e dall’adolescenza alla maturità e al decadimento senile, quindi alla morte. L’autoidentificazione con il proprio corpo fisico, alla base del pensiero materialista - come ad esempio la scuola Lokâyata (o anche Chârvâka, sorta in India intorno al 600 a.C.) ed altre, secondo cui tutto si estingue con la dissoluzione della materia - è un aspetto dal quale nessuno può essere esente. Inevitabile conseguenza è l’attaccamento, come dimostra il desiderio di alcuni di conservare il proprio corpo più a lungo possibile contro ogni logica naturale, come il tentativo di emulare l’ibernazione (che non è fisicamente prevista per l’organismo umano), oppure la mummificazione, nella vana illusione di potersi ancora servire del corpo in un tempo futuro. Anche l’esagerata preoccupazione di quello che avverrà del proprio corpo dopo la morte - come ad esempio il timore di soffrire di claustrofobia dentro una bara -, è chiaro indice di un errore di identificazione. La cosa non ci deve meravigliare poi tanto. Nel celebre dialogo platonico Fedone, o dell’anima, dopo le esaurienti e circostanziate spiegazioni di Socrate, Critone gli domanda come comportarsi per il suo funerale; la risposta di Socrate, quasi in stile Zen, sconcerta i discepoli: "Come volete, proprio così, sempre nel caso che riusciate a prendermi e ch’io non vi sfugga". Che Critone non abbia capito i suoi insegnamenti sulla differenza di identità fra anima e corpo è più che evidente. Socrate stesso spiega di seguito: "Non mi riesce, amici miei, di far persuaso Critone che sono io, Socrate, quello che in questo momento sta parlando con voi, quello che ha dato ordine e coerenza, discutendo con voi ad ogni sua parola; egli crede ch’io sia quell’altro, quello che tra poco egli vedrà morto, e in conseguenza mi rivolge domande circa i miei funerali". Un simile errore è assai diffuso in svariati contesti religiosi. Spesso, riferendocisi all’identità anagrafica relativa al nostro corpo fisico si suole parlare in prima persona, quando sarebbe invece più opportuno esprimersi riferendosi a quelli che temporaneamente sono i nostri aggregati; ovvero, non io faccio, scrivo, mangio, bensì i miei aggregati fanno, scrivono, mangiano, e via dicendo.
Per quel che succede dopo che il principio cosciente (o anima, se preferiamo un termine più familiare alla nostra cultura) - a meno che non si tratti di praticanti realizzati -, l’attaccamento al corpo è così forte che per lungo tempo continua ad aggirarsi vicino ai propri resti mortali, oltre che nei luoghi che gli erano familiari. Per accelerare il suo distacco dal corpo, così come per evitare che sia i corpi sottili che quello grossolano possano essere utilizzati per scopi malvagi ad opera di demoni o praticanti di magia nera, viene praticata la cremazione o l’esposizione in luoghi particolari. La cremazione, introdotta in India dagli Indoeuropei, fu usata estesamente solo molto più tardi. All’epoca del Buddha storico, come attestato più volte anche nel Canone Pali, nell’India del Nord, era ancora in uso esporre i cadaveri in appositi campi, affinché fossero rapidamente consumati da avvoltoi, corvi, sciacalli, iene e altre simpatiche bestiole carnivore. Questa usanza era ancora in voga all’epoca dei Mahasiddha, intorno all’VIII secolo d. C.; tuttora, dall’area Himalayana fino alla Mongolia, i cadaveri vengono fatti a pezzi, ridotti in poltiglia e distribuiti agli avvoltoi o agli sciacalli: questa usanza, denominata funerale celeste, viene considerata un estremo atto di gentilezza, effettuato "per procura", da parte del defunto nei confronti di questi esseri senzienti. Anche gli zoroastriani Parsi - oriundi Persiani dell’India - hanno adottato questa pratica, esponendo tuttora i cadaveri sulle "Torri del silenzio" o daxma (7). I luoghi di cremazione e i cimiteri sono considerati come luoghi ideali per la pratica ascetica dell’asubhadarshâna, ovvero la contemplazione di ciò che è sgradevole, quindi della meditazione sull’impermanenza e la morte. Sono quindi diventati i luoghi prediletti da Sâdhu, Aghori, Kâpâlika e adepti di scuole tantriche shàiva e buddhiste, Bön (la religione originaria del Tibet), nonché praticanti del Ciöd (8). Diversi mahasiddha hanno raggiunto la realizzazione meditando in posti come questi, e tutt’oggi e possibile, in quelle regioni, incontrare yoghi e yoghinî, sâdhu e sâdhvinî adorni di ossa e col corpo ben cosparso di cenere proveniente dalle cremazioni (cenere che si portano appresso in un recipiente, per cospargersene ogni tanto, allorché sono lontani dai cimiteri). Qualcuno, storcendo il naso, avrà trovato questa consuetudine raccapricciante? Può anche darsi, ma non bisogna dimenticare che il simbolico rito cristiano del mercoledì delle ceneri - nel quale il sacerdote cosparge un pizzico di cenere (di fronde d’ulivo) sul capo del fedele, pronunciando il monito "ricorda che cenere sei e cenere ritornerai" - presenta significative affinità con la costumanza dei Sâdhu. Se poi qualcuno pensasse che il circondarsi di ossa umane per meditare sull’impermanenza e la meditazione sulla morte siano atteggiamenti rituali un po’ troppo estremi, devo ricordare che, nell’ampia iconografia cristiana di San Girolamo e di altri Padri del deserto, la presenza di crani e altre ossa umane non è un elemento puramente scenografico. Se non vado errato, in alcuni monasteri trappisti dovrebbe essere ancora in uso la pratica di tenere un cranio nella cella; inoltre, durante la notte, ogni ora, a turno, un monaco fa il giro delle celle, bussando e ammonendo i confratelli con il memento mori (ricordati che devi morire). Chi avesse l’occasione di visitare, a Roma, la chiesa dei Cappuccini, nei sotterranei potrà avere un fulgido esempio di come la meditazione sull’impermanenza si combini con l’arte: man mano che le ossa dei monaci sono riesumate, vengono disposte in modo da formare scene allegoriche, simboli e fregi decorativi. Sempre i Cappuccini, a Palermo, in vari livelli di catacombe, hanno ospitato le spoglie mummificate, non solo di confratelli, ma anche di prelati e laici di ambo i sessi e si sono ampiamente sbizzarriti a sistemare i corpi, nelle posture più svariate, creando un’originale sequenza figurativa scenica-statuaria, autentico trionfo della Morte. Qualcuno lo troverà anche macabro, ma trovo che fare una visita in questi posti aiuti molto a meditare sulla transitorietà delle cose di questo mondo. Non dobbiamo dimenticare che i frati Cappuccini appartengono all’ordine monastico, fondato da San Francesco d’Assisi, lo stesso che concludeva il Cantico delle Creature lodando il Signore per sora nostra morte corporale; francescano era anche quel Jacopone da Todi, che iniziava una contemplazione della morte e umiliazione della superbia con i versi: Quando t’allegri, omo, de altura, / va’, pone mente a la sepoltura: quando gioisci, o uomo, per la prosperità, rivolgi la tua attenzione alla sepoltura, alla morte; quello che segue è un autentico asubhadarshâna, degno del miglior ascetismo buddhista o shàiva. Anche un celebre manualetto morale del XV secolo, l’Imitazione di Cristo, nel capitolo XXIII, Il pensiero della morte, esorta vivere ogni momento della vita come fosse l’ultimo, e lo stile non è poi dissimile dal più recente Promemoria della morte del venerabile Lama Phabongkha Rinpoce. Vorrei infine ricordare che l’abito indossato dai danzatori Sufi Mawlawiyya, i famosi Dervisci roteanti, costituisce, per chi lo indossa, un promemoria del sudario e della tomba, quindi una costante meditazione sull’impermanenza e la morte. Uguale valore ha il colore nero dei Kesa, indossati dai monaci zen.
Se consideriamo quanto prima detto a proposito dell’ignoranza (Avidya), che domina e condiziona l’esistenza materiale, la morte viene vista come una medicina, una terapia che dovrebbe frenare gli entusiasmi degli esseri viventi, inducendoli alla riflessione, alla meditazione e alla ricerca della realtà ultima. Già Socrate, prima di morire ricordò a Critone di non dimenticare di sacrificare un gallo ad Esculapio, dio (nel senso di deva) della medicina, per ringraziarlo di averlo guarito dalla vita, intesa come una malattia incurabile. Il fatto stesso che a partire dalla nascita ogni essere senziente intraprende il tragitto che progressivamente ed inesorabilmente lo avvicina alla vecchiaia e alla morte è attestato anche da sant’Agostino, allorché dice "Come i medici, avendo esaminato una infermità e ravvisatala per mortale, dicono: - è morto, non se la cava -, così bisogna dire dal momento della nascita di un uomo: - non se la cava" (9) e ancora "Se uno comincia a morire, cioè ad essere nella morte; dal momento in cui la morte comincia ad agire in lui, cioè la detrazione della vita..., allora certamente l'uomo comincia ad essere nella morte dal momento in cui comincia ad essere nel corpo" (10). La morte è dunque sofferenza, ...ma nemmeno la vita è comoda, come si leggeva nel sottotitolo di un libro del disegnatore umoristico Giuseppe Novello. É lo stesso messaggio di un significativo mondô Zen: "Non riesco a sopportare la vita" disse un monaco. "Non è meglio morire?" "Ma come potrai sopportare la morte se non sopporti la vita?" disse Joshu.
L’unico modo per rendere la propria vita significativa è dunque una pratica improntata alla pratica spirituale mirata al beneficio di tutti gli esseri senzienti. Un simile desiderio, radicato nel continuum mentale, permetterà di accumulare meriti in tal misura, non solo da farci superare le avversità della vita, ma anche di superare con la consapevolezza l’esperienza della morte, liberandoci dalle pastoie del ciclo delle esistenze. Proprio il ciclo del perpetuo divenire, nell’iconografia tradizionale di tradizione himalayana, viene raffigurato tra le fauci e gli artigli di colui che alcuni reputano il demone Mara, molto verosimilmente identificabile anche nel deva della morte, Yamarâja (re Yama) o Yama. Secondo la tradizione induista correlato a Shiva, nella sua ipostasi distruttiva, ne ha anche gli attributi, come lo scettro (danda) con il teschio, simbolo della sovranità sul regno della morte, e il laccio (pâsha) per trascinare all’inferno i reprobi. Suo veicolo (vâhana) è talvolta il toro, veicolo anche di Shiva, talvolta il bufalo, animale associato al guna rajas (passione), controllato da Brahma, ma anche al tamas (ignoranza), controllato da Shiva. Talvolta è raffigurato con la testa di toro o di bufalo. Indossa una corona di cinque teschi e una collana di teste mozzate, un grembiule di pelle di tigre e di solito almeno un serpente velenoso (anch’esso attinente al culto shàiva). A volte calpesta un cadavere, ma nell’esempio qui proposto cavalca il suo veicolo, un toro nell’atto di accoppiamento con una donna, simbolo del desiderio e dell’ignoranza, causa del continuo ciclo di morti e rinascite. Il nome Yama può essere tradotto come colui che trattiene, frena, interrompe, riferito all’interruzione della vita, oppure come gemello, dovuto al fatto di avere una sorella gemella, Yamî, spesso raffigurata assieme a lui, come dâkinî. A seguito di un "garbato confronto" con Yamântaka (l’opponente di Yama), ipostasi irata del bodhisattva Manjushri, Yama si è trasformato in Protettore della Dottrina (Dharmapala) svolgendo il compito in maniera così esemplare da ottenere anche il titolo di Dharmarâja: Re del Dharma. Il ruolo di giudice delle anime, da lui svolto, ricorda molto quello del Minosse di virgiliana e dantesca memoria. Coloro che hanno accumulato sufficienti meriti, hanno dalla loro parte un valente difensore: il vidyarâja (Re della Sapienza) Achala, che brandisce con la destra la spada fiammeggiante della consapevolezza che sconfigge le oscurazioni, mentre con la sinistra tiene il laccio, col quale guida gli spiriti meritevoli verso una rinascita migliore.
__________________________________________
NOTE:
(1) In Italia più noto come Francesco Bacone (1561-1626).
(2) (1788-1860)
(3) Sperimentare tutto il possibile.
(4) Insegnamenti sul Bardo, Ubaldini, Roma, 1996, pag. 32
(5) Digha Nikaya XIV - Anguttara Nikaya III, 38 - Nidânakathâ, introduzione al Sâtaka, cfr. anche il Lalita Vistara.
(6) Commentario al Dhammapada, V 287, Therîgathâ 63 - cfr. anche Lalita Vistara
(7) Il termine parsi significa crematorio, e ci ricorda il primordiale uso di queste torri, secondo la tradizione indoeuropea.
(8) Particolare pratica esorcistica, mirante a sconfiggere il demone dell’ego, visualizzando l’offerta del proprio corpo illusorio.
(9) Quomodo medici quando inspexerint valetudinem, et mortiferam esse cognoverint, hoc pronuntiant, moritur, inde non evadit. Ex quo nascitur homo, dicendum est, non evadit (Serm., 97, 3; 3, PL 38, 590.)
(10) Si ex illo quisque incipit mori, hoc est esse in morte, ex quo in illo agi coeperit ipsa mors, id est vitae detractio.. profecto ex quo esse incipit in hoc corpore, in morte est. (De Civitate Dei, 13, io, CCL 48, 392.)