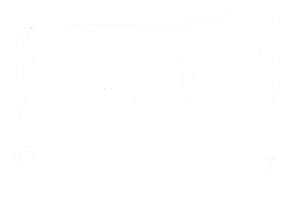La cineteca ideale
a cura della redazione del sito arianuova.org
Nella sezione inglese del sito, abbiamo inserito una lista dei 99 films che consideriamo i migliori finora realizzati.
Abbiamo pure redatto una lista, questa volta in italiano, contenente le pellicole da noi preferite appartenenti a generi là non presi in considerazione (come cartoni animati o films televisivi): Altri films.
Qui, invece, vorremmo offrire le ragioni delle scelte di quei 99 e commentare brevemente ogni singola pellicola.
Del periodo del cinema muto abbiamo salvato due soli lungometraggi, più un terzo che è per buona parte muto, sebbene il sonoro avesse fatto irruzione già da alcuni anni nel mondo del cinema e nel film stesso vi siano alcune concessioni in tal senso. Molti avranno capito a quale film ci riferiamo, ma procediamo con ordine, seguendo il naturale senso cronologico di realizzazione delle varie pellicole.
I critici cinematografici certo inorridiranno di fronte alla nostra scelta di lasciare fuori dalla lista il monumentale Intolerance, di David Wark Griffith (1916), lo straziante Bronenosec Potëmkin (‘La corazzata Potëmkin’, 1925), di Sergej Micholaevic Ejzenstejn, il visionario Metropolis, di Fritz Lang (1926), l’appassionato Sunrise (‘Aurora’), di Friedrich Wilhelm Murnau (1927). Eppure, sebbene riconosciamo i grandi meriti che tali lungometraggi possiedono (basti pensare alla forza delle scene di Metropolis in cui gli operai sembrano ridotti a una massa di schiavi robotizzati, stritolati dalla Macchina che si trasforma in un Moloch, o alla celebre scena della scalinata di Odessa in Bronenosec Potëmkin, calibrata con millimetrica precisione), non siamo affatto pentiti di questa nostra operazione chirurgica. Poiché ci risulta impossibile, oggi, guardare tali film dall’inizio alla fine senza essere assaliti dal tedio, infastiditi dalla recitazione enfatica o dall’eccessivo sentimentalismo di certe scene. Senza tuttavia dimenticare che grazie a queste pellicole e a questi registi il cinema si fece adulto.
Vi sono poi alcuni lungometraggi, che abbiamo ugualmente omesso, i quali sono da considerarsi notevolissimi nelle intenzioni, ma la cui realizzazione sfiora il ridicolo. Un esempio per tutti, davvero emblematico nel mostrare lo scarto abissale fra l’intuizione geniale che lo ha ispirato e la resa filmica inadeguata, è La Belle Verte (“Il pianeta verde”), realizzato nel 1995 da Coline Serreau (che è anche la protagonista). La critica del sistema capitalistico è puntuale e intelligente, così come assai felice risulta l’idea di mostrarla attraverso l’analisi degli abitanti di un altro pianeta, offrendola quindi con opportuno distacco, talvolta perfino con trovate esilaranti e argute al tempo stesso; e tuttavia, la sceneggiatura, la recitazione degli attori, i costumi, le scene sono perlopiù pessime o, nella migliore delle ipotesi, fortemente inadeguate. Eppure, sappiamo che si possono realizzare film a costi contenuti (alcuni li abbiamo perfino inseriti nella lista dei nostri 99) senza per questo cadere nell’inadeguato o, peggio ancora, nel pacchiano.
Il film muto da noi scelto, è realizzato da quel grandissimo e geniale attore comico quale fu Charlie Chaplin. Si tratta di City lights (‘Luci della città’), realizzato nel 1931. Attore dotato di una fisicità e di una mimica davvero uniche e straordinarie, Chaplin presto si è dimostrato anche un valido regista, un ottimo sceneggiatore, e perfino un discreto compositore (sue le musiche dei propri films). Il suo unico difetto è che, nelle sceneggiature, talvolta si lascia prendere un po’ troppo la mano dal gusto per il melodramma. La polemica sociale, per contro, è sempre presente e graffiante, condita da pezzi di bravura assolutamente perfetti (qui come altrove — in The Goldenrush, per esempio, o in The Circus), in cui ogni dettaglio è frutto di un lavoro lungo e assiduo, come un complicato meccanismo a orologeria, eppure il risultato finale è di una estrema naturalezza (basti pensare all’incontro di boxe strutturato come una danza, o al tormentone dei due ubriachi, oppure ancora all’irresistibile scena — in apertura del film — dell’inaugurazione della statua della prosperità, sorvegliata da uomini armati!). Chaplin, ha detto Jean Cocteau, «è il riso esperanto». Un riso universale, amaro, delicato e struggente al tempo stesso. Comici di questa levatura sono rari, e meritano tutto il nostro apprezzamento.
Ed ecco l’avvento del parlato. Il primo film che abbiamo selezionato porta la firma di Jean Vigo — considerato il Rimbaud del cinematografo —, e il suo “Bateau Ivre” è costituito per l’appunto da L’Atalante, del 1934, il suo unico lungometraggio (morì a soli 29 anni). Figlio di un anarchico, e formatosi alla scuola surrealista, Jean Vigo si impose subito come uno dei grandi cineasti del suo tempo, contraddistinguendosi per il lirismo radicato nel quotidiano e determinato da un’estrema tensione individuale, e insieme per la delicatezza, l’eleganza, la fantasia sfrenata e un velato umorismo di fondo che avvolge ogni cosa con affetto. Notevole la caratterizzazione dei personaggi da parte degli attori — Michel Simon innanzi tutti, nel ruolo di père Jules, è semplicemente straordinario, con tutti i suoi tatuaggi e quell’aria candida a metà tra un uomo burbero e un bambino disarmante, sembra uscito da un romanzo di Céline; la coppia Jean Dasté e Dita Parlo (nei ruoli di Jean e Juliette, due sposini, lui sempre imbronciato e un po’ scontroso, lei davvero deliziosa con quell’aria da contadinella ingenua e curiosa). E poi l’ambientazione, il ritmo, la musica danno all’avventura il tono di un sogno a occhi aperti. Il film, come gli riconobbe François Truffaut, «evita i trabocchetti dell’estetismo e quelli del realismo grazie alla sua delicatezza, alla sua raffinatezza, all’umorismo, all’eleganza, all’intelligenza, alla intuizione e alla sensibilità».
Viene quindi il semi-muto cui accennavano all’inizio, ed è di nuovo una produzione chapliniana, o meglio il suo capolavoro:Modern Times (‘Tempi moderni’), del 1936. Gustosissima satira dell’èra industriale con tutte le sue contraddizioni, il film è un meccanismo a orologeria perfettamente regolato, in cui ogni ingranaggio ha una sua precisa funzione — e l’ora del film è precisamente quella del XX secolo. Chaplin è qui nel più pieno possesso del suo genio comico, e la propensione melodrammatica è miracolosamente assente. Otto anni dopo la nascita del parlato, egli fa lo sberleffo alla mania del dialogo e realizza un film quasi interamente muto; la sola parte da lui parlata (o meglio cantata) è composta di sillabe senza senso: la canzone improvvisata nel ristorante-cabaret, sull’aria di Io cerco la Titina, che è un gustosissimo pezzo da rivista. Ma il ritmo del film è un’incalzante filza di disgrazie: i ritmi frenetici della catena di montaggio, la bandiera rossa raccolta unicamente come un gesto di cortesia e scambiata per il vessillo di una manifestazione operaia, le disavventure con il compagno di cella, i dolori del guardiano notturno sfortunato e del cameriere inesperto, fino alla fuga che lo conduce, assieme alla compagna (un’orfana costretta a vivere di espedienti), all’alba, lungo una strada maestra deserta. Un finale semplice, sobrio, toccante, che si è subito imposto nell’immaginario collettivo e ha fatto epoca.
Qualche anno dopo, nel 1941, il cinema fa un grande balzo in avanti grazie a Orson Welles e alla sua opera prima: Citizen Kane (letteralmente, ‘il cittadino Kane’, sebbene in italiano il titolo utilizzato fu ‘Quarto potere’). «La macchina da presa dev’essere un occhio nella testa di un poeta… Un film è un nastro di sogni». Su queste basi, Orson Welles ha edificato un fascinoso monumento che, come dice il suo autore, è «lo studio di un sultano che soffre di amnesia»; viene infatti narrata la vita di Charles Foster Kane (interpretato dallo stesso Welles), semi-immaginario magnate della stampa statunitense, dalla sua infanzia povera ai primi successi editoriali, la tentata carriera politica, i drammi sentimentali, le ambizioni frustrate — insomma, una versione moderna del Re di Thule, il cui eroe è un uomo la cui immensa fortuna non lo ha reso felice. Ma il riferimento più evidente sembra essere Shakespeare; nonostante l’infantile allegoria, tutto sommato banale, l’impianto narrativo — che fa leva sull’incastro di azioni, ricordi, luoghi — è magistrale (oltretutto, nessun film si era servito prima di allora con pari abilità del procedimento del flashback). Così, il pessimismo e la foga poetica di Orson Welles fanno di Kane il Re Lear del XX secolo. Per questo suo primo film, Welles chiamò a raccolta tecnici consumati, tra i quali lo sceneggiatore Hermann Mankiewicz e il direttore della fotografia Gregg Toland. Familiarizzandosi a tempo record con il linguaggio dello schermo, l’attore-regista accumulò le audacie della costruzione narrativa, le mirabili acrobazie visive (numerose le angolazioni dal basso), i suggestivi effetti di profondità di campo e di montaggio. Il risultato fu un’opera rivoluzionaria, che segnò una svolta decisiva nella cinematografia.
Anche l’Oriente mostra un vivo interesse per il cinema. Nel 1953 Kenji Mizoguchi, il quale aveva già al suo attivo più di settanta films, realizza Ugetsu Monogatari (‘I racconti della luna pallida d’agosto’), traendo la sceneggiatura da due racconti di Akinari Ueda ambientati nel XVI secolo (tratti dai suoi Racconti di pioggia e di luna, storie di fantasmi che riprendono spunti cinesi e motivi del folclore, del romanzo e del teatro giapponese kabuki). Film di grande raffinatezza, dalla bellezza ora altera e ora eterea, è una riflessione tutta buddhista sulla natura illusoria della felicità e delle umane ambizioni; soggetto prediletto del regista è la donna, vittima dell’orgoglio e dell’ambizione maschili (in questo influenzato certamente dal fatto che da bambino vide la sorella maggiore costretta a diventare una geisha). Tutto appare duplice: la costruzione oscilla tra due storie diverse, mescola il destino di due personaggi, contrappone due tipi complementari di donna, gioca sull’alternanza di due ritmi. Mizoguchi concilia la cruda realtà con il fascino del meraviglioso, e quanto potrebbe sembrare incoerente lascia invece l’impressione di un’armonia superiore che traspare come in filigrana.
Un altro regista giapponese si è imposto nel panorama della cinematografia mondiale, diventando in breve il più celebre registra orientale del mondo: Akira Kurosawa. Nel 1955 realizza Shichinin no samurai (‘I sette samurai’), un affresco epico e storico del Giappone del XVI secolo, narrato con eleganza e intensità e che cela un’elegia della terra e della solidarietà, in un incitamento contro la rassegnazione e lo scoramento, visti come i due grandi nemici dell’uomo. Il film servirà anche come trampolino di lancio per il talentuoso Toshiro Mifune, qui nella parte del buffo ma intrepido contadino Kikuchiyo, il quale cerca in tutti i modi di spacciarsi per un samurai. La storia è coinvolgente pur nella sua semplicità: una banda di briganti minaccia la tranquilla esistenza dei contadini di un villaggio; i quali, riuniti per decidere come difendersi, inviano alcuni di loro alla ricerca di samurai da ingaggiare. Il valente Kambei accetta l’incarico, e si occupa personalmente di costituire un gruppo di combattenti. Il film non possiede certo la trama intricata e pirandelliana del precedente Rashomon (che Kurosawa realizzò nel 1951, e che ricevette un vasto consenso da parte della critica occidentale) eppure abbiamo preferito quest’altra storia più lineare e più diretta, più schietta e meno contorta per rappresentare la prima produzione di Kurosawa.
Viene quindi un regista inclassificabile, Max Ophuls, con il suo Lola Montéz (del 1955), affresco delirante di quella che è stata definita la donna più scandalosa del secolo XIX. Difficile parlare di questo film. È, innanzitutto, una denuncia rigorosa di un modo roboante di intendere lo spettacolo e della manipolazione dei media (e in ciò è nettamente in anticipo sui tempi). Da un punto di vista tecnico e stilistico, poi, si tratta di un’impresa nuova e audace: l’uso originale del colore (e questo è oltretutto il primo film a colori della nostra lista), il ricorso a mascherine che permettono di modificare a volontà il formato dell’immagine in cinemascope (dando l’impressione di uno schermo di misura variabile, con raffinati cambiamenti a vista), l’agilità inebriante della cinepresa che giostra con le scene, gli accessori, i personaggi e i sentimenti (qualcuno ha parlato di una “estetica della mobilità”), tutto questo rende il film una «allegoria turbinosa», secondo le parole di Georges Annenkov. Al centro di una vetrata multicolore, attorniata da pannelli che narrano la sua leggenda, il volto di Lola scompare poco a poco sotto il luccichio delle decorazioni e la moltiplicazione delle maschere. E tuttavia lo distinguiamo bene, segnato dall’angoscia, dietro il tumulto delle forme, amari simulacri di una vulnerabilità verso la quale il mondo dello spettacolo non mostra alcun rispetto.
Dopo otto anni di vagabondaggi europei, Hollywood riaccetta — sia pur temporaneamente — Orson Welles e gli permette di realizzare Touch of Evil (titolo in italiano: ‘L’infernale Quinlan’), nel 1957. Il provvisorio perdono era dovuto all’iniziativa del protagonista del film, Charlton Heston. E, come ci si poteva aspettare, Welles trasformò una banale storia poliziesca (dal romanzo Contro tutti di With Masterson) facendone una favola convulsa e tenebrosa, che procede a un ritmo infernale e che pone esplicitamente un problema sociale di rilievo: quello dell’abuso del potere poliziesco, porta aperta all’intolleranza e alla dittatura. Il liberale Vargas si oppone duramente al corrotto Quinlan. Tutto questo non senza ambiguità, poiché Vargas si trova a dover derogare a molti suoi principî, ma soprattutto poiché è lo stesso Welles a dare corpo, con convinzione mostruosa e affascinante, al personaggio del cattivo (da ricordare anche Marlene Dietrich nel ruolo della zingara Tanya). Dal famoso piano-sequenza di apertura, realizzato con la gru, che gioca sull’intera gamma dell’illusione cinematografica (uso del grandangolo, distorsione della profondità di campo, deformazione dello spazio), fino alla conclusione del dramma nella strana scenografia di un terrapieno, tra travi e pozze d’acqua stagnante, ci si trova immersi in un mondo di incubo, descritto con grande efficacia dal bianco e nero della fotografia e da una cinepresa onnipresente, di agilità sorprendente, senza un attimo di tregua, con una morale di fondo di ispirazione shakespeariana.
Dei cosiddetti ‘kolossal’ che tanta attenzione suscitarono nei primi anni Sessanta, abbiamo deciso di salvarne almeno uno:Lawrence of Arabia (Lawrence d’Arabia, 1962) di David Lean. Il film è incentrato sull’impegno di T.E. Lawrence che, nel corso dei due anni trascorsi in Arabia durante la prima guerra mondiale, riuscì a riunire le tribù arabe contro i turchi diventando la leggenda del suo tempo. Le scene spettacolari sono rappresentate con vigore e immaginazione, la fotografia è tuttora eccellente e il cast comprende grandi attori cinematografici: Peter O’Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn, Alec Guinness, Jack Hawkins, Jose Ferrer, Claude Rains, Anthony Quayle, Arthur Kennedy. La sceneggiatura di Robert Bolt è lievemente romanzata, sebbene tutte le vicende più salienti siano comprese. Ufficiale, archeologo e scrittore inglese, Lawrence partecipò all’insurrezione araba contro i Turchi, capitanata da Feisal, già sceicco della Mecca, proclamatosi re del Higiaz nel 1916. La padronanza dei costumi e della lingua araba permise a Lawrence di condurre abilmente la guerriglia e, dopo, di sostenere le rivendicazioni di Feisal, in qualità di membro della delegazione inglese alla conferenza della pace. Deluso delle decisioni delle grandi potenze, si dimise da ufficiale (il film si conclude a questo punto, mentre la storia ci dice che si arruolò sotto falso nome come semplice aviere nella RAF; riconosciuto, passò nell’esercito e, riammesso nell’aviazione, fu inviato in India). Lasciò il servizio nel 1935 e nello stesso anno morì in un incidente motociclistico, che nel film viene evocato all’inizio, cosicché l’intera storia appare come un flash-back.
Robert Bresson (regista esemplare, lontano da mode e spettacolarismi ammiccanti, laureato in filosofia e profondo amante della grande letteratura) effettua una straordinaria ricostruzione della tragica vicenda giudiziaria svoltasi nel 1431 ai danni di Giovanna d’Arco. Basandosi con grande scrupolo sulle minute del processo, nel 1962 realizza infatti Procès à Jeanne d’Arc (“Il processo a Giovanna d’Arco”). La Pulzella d’Orléans viene tratteggiata in modo forte e convincente, grazie anche alla bravura dell’interprete (Florence Carrez, una straordinaria sconosciuta, come quasi tutti gli attori scelti da questo regista), rifiutando ogni deriva spettacolare e qualunque coloritura fuori luogo. Bresson aveva già raggiunto la perfezione stilistica del suo cinema (o, meglio, del suo “cinematografo”, come lui preferiva definirlo, per liberarsi da un’estetica chiassosa e, all’epoca, per buona parte ancora schiava del “teatro filmato”), che si esplica in una ricerca espressiva che è anzitutto ricerca interiore, ricerca di quella verità che trascende i risibili simulacri del mondo visibile. Questa pellicola permette insomma a Bresson di mostrare che, per utilizzare le sue stesse parole, «il cinema non è uno spettacolo, è una scrittura»; non ci troviamo infatti di fronte a un regista “cha fa cinema”, quanto piuttosto a un pittore che mette in ordine frammenti sparsi di realtà, registrando con rigore e senza sentimentalismi i battiti del cuore, in una andatura austera, essenziale, pura. L’impressione non è quello di guardare un film, ma quasi di assistere dal vivo al vergognoso processo intentato dalla Chiesa a questa straordinaria mistica, straordinaria guerriera, straordinaria eroina: in una parola, a questa autentica Donna.
Tra le mega-produzioni italiane dell’epoca, si staglia su tutte Il gattopardo di Luchino Visconti (1963), basato sul celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Realizzato con il sistema di ripresa Technirama, messo a punto dalla Technicolor negli anni ’50 ma presto abbandonato, il film presenta qualche difficoltà tecnica di riproduzione — perciò, da anni le copie positive della pellicola venivano stampate da normali internegativi, al limite dell’usura, con conseguente riduzione del formato del fotogramma e con definizione, densità e contrasto dei colori sempre più approssimativi. Il ricupero effettuato sul negativo originale da Peppino Rotunno (figlio di quel Giuseppe Rotunno che nel film fu il bravo direttore della fotografia) restituisce al film la sua autentica bellezza. Per il suo capolavoro, Luchino Visconti ha voluto un cast internazionale, composto dall’ultimo e intensissimo Burt Lancaster, dalla splendida Claudia Cardinale, da Alain Delon, e da alcuni ottimi attori di teatro italiani (Serge Reggiani, Rina Morelli, Paolo Stoppa, Romolo Valli). La cura dei dettagli è di una meticolosità che rasenta il maniacale (la celebre scena del ballo è esemplare in tal senso, con milioni di candele sparse per tutta la sala che venivano rimpiazzate a ogni ciak), e il risultato è di grande fascino.
Nel 1963 Federico Fellini svela le proprie inquietudini di uomo e di cineasta in Otto e mezzo (il titolo deriva dal fatto che Fellini aveva girato fino a quel momento otto film e uno sketch inserito in un film a episodi). Un regista guarda dentro se stesso, e il cinema guarda dentro la propria casa. Raccontando se stesso, e i suoi crucci di regista che non riesce a realizzare il film che vorrebbe, Fellini affronta i meccanismi — mentali, professionali, tecnici, economici — sui quali si impernia la produzione cinematografica. Guido, regista in crisi (alter-ego di Fellini, impersonato da Marcello Mastroianni), intrappolato in un ingorgo automobilistico, sogna di fuggire verso le Terme, luogo di riposo e di evasione. Sta progettando un film difficile. Pensieri, memorie, fatti reali e sognati si mescolano fino a creare un film nel film. Le Terme diventano luogo di raccolta di tutto ciò che compone come in un mosaico la sua vita: amici, colleghi, la formosa amante, la moglie che mal sopporta il loro caotico ménage matrimoniale, Claudia, attrice e simbolo di purezza. I dialoghi con i frequentatori della stazione termale aumentano la sua confusione e scatenano vecchi ricordi: l’infanzia, i genitori, le repressioni religiose in collegio. Un’astronave sembra pronta a partire ma a Guido non resta che fuggire da una penosa conferenza stampa. È notte: come per miracolo, sul set del film, deserto, appaiono tutti i personaggi ai quali Guido si unisce in un girotondo ritmato da una musica circense (firmata da Nino Rota).
Il 1968, anno-chiave della storia contemporanea, vede l’uscita di quel grande film visionario qual è 2001: A Space Odissey (‘2001, Odissea nello spazio’) a opera di Stanley Kubrick. Nella grande tradizione delle utopie di Verne, questa film fa della fantascienza cinematografica un genere adulto. Un anno dopo, nel luglio del 1969, il primo uomo sbarcherà sulla luna. Cineasta completo, estraneo alle mode, Kubrick ha scelto per questo film un approccio quasi documentario. Una nozione complessa come quella dell’immortalità biologica è sviluppata nel film con un minimo di ricorso alla finzione. Ne risulta una sorta di fiaba del XX secolo che può sembrare anche un resoconto scientifico di assoluto rigore. Bellissimo il passaggio iniziale dalla clava del macaco all’astronave in volo verso lo spazio: una straordinaria metafora dell’evoluzione umana, volta a migliorare sempre più l’utensile. E molto si è discusso sul senso della sequenza finale, il cui arcaico romanticismo rompe decisamente con la tecnologica freddezza del contesto… È forse il simbolo della fine dell’umanità e dell’inizio di una nuova èra? «Ognuno è libero di speculare a suo gusto sul significato filosofico e allegorico del film — ha dichiarato Kubrick —. Io ho cercato di creare un’esperienza visiva, che aggiri la comprensione per penetrare con il suo contenuto emotivo direttamente nell’inconscio». Certo è che l’attacco alle Torri Gemelle sembra riprodurre la sequenza iniziale del film proiettata al contrario: nel film, l’anno 2001 fu rappresentato dalla trasformazione di un osso in una navicella spaziale. L’anno 2001 reale fu rappresentato con la trasformazione di una nave spaziale (un aereo) in un’arma di guerra. E il vociare umano nell’ anno 2001 non era molto differente dalle emissioni sonore dei macachi che all’inizio della civilizzazione si sono imbattuti nel monolito. In quel momento si trattava del passaggio dalla scimmia all’uomo. E se adesso ci trovassimo in un passaggio almeno altrettanto cruciale, dall’uomo a…qualcos’altro? Il ritrovamento del monolito nell’anno 2001 e l’immagine finale del film sembrano indicare in questa direzione.
Dopo tante pellicole western più o meno insopportabilmente schierate dalla parte dei bianchi, nel 1970 viene realizzato da Arthur Penn il film Little Big Man (‘Il piccolo grande uomo’) che non trascura il punto di vista degli indiani in una miscela di mito e realtà, verità e fantasia, sempre in bilico tra il serio e il grottesco. Jack Crabb, ultracentenario avventuriero (interpretato da Dustin Hoffman), racconta a un giornalista la sua vita incredibile: rapito e allevato dai Cheyenne, poi costretto a ritornare tra i bianchi, diventa pistolero e più tardi soldato. Conosce Buffalo Bill, è testimone della fiera ma tragica lotta dei nativi d’America per la propria indipendenza, e finisce con il generale Custer nella battaglia di Little Big Horn, di cui sarà l’unico superstite. Ne viene fuori una saga insolita, un racconto insieme amaro e brillante di una delle pagine più drammatiche e tristi della storia contemporanea. Finalmente, e per la prima volta al cinema, si usa la parola genocidio per identificare il massacro degli indiani da parte dei bianchi.
Stanley Kubrick cerca di esorcizzare la violenza in A Clockwork Orange (‘Arancia Meccanica’, ispirato al romanzo di Anthony Burgess Un’arancia a orologeria), film del 1971, con un atteggiamento diametralmente opposto a quello che anni dopo un certo cinema (e una certa televisione) assunsero, prestandosi a una disgustosa celebrazione della violenza. Il protagonista del film, Alex, è la violenza allo stato puro. Teppista, minorenne in una Londra di un futuro non troppo lontano, ruba, uccide, incendia senza paure, senza esitazione, senza rimorsi. Lo vediamo nella prima sequenza mascherato da giocatore di cricket mettere a soqquadro l’abitazione di due coniugi borghesi e violentare la padrona di casa. Ma un giorno la polizia lo cattura, lo mette nelle mani di uno scienziato che lo sottopone a uno speciale trattamento. Dopo la cura Alex è una tigre senza zanne, incapace della minima reazione violenta. Ma non è per questo guarito o redento; è solo la vittima inerme di un mondo che rimane comunque violento. Finché Alex non capisce come tornare redento e impunito. Si arruola nella polizia dove potrà commettere le efferatezze di prima, protetto però dal potere di cui sarà strumento.
Grande affresco della mafia italo-americana, The Godfather (‘Il padrino’) di Francis Ford Coppola (1972) ebbe un enorme successo di critica e di pubblico. Una sceneggiatura nervosa, ricerche plastiche originali, le musiche di Nino Rota, un cast in oro massiccio (guidato da Marlon Brando in una caratterizzazione memorabile e sublime) — tutto (compresa la mirabile fotografia di Gordon Willis e le scenografie di Dean Tavoularis) ha contribuito al successo di questa saga roboante, ambientata negli Stati Uniti degli anni ’40. Il boss siciliano don Vito Corleone (Marlon Brando), legato ai codici d’onore della vecchia cultura mafiosa, rifiuta l’alleanza di un’altra famiglia mafiosa, i Tattaglia, che lo coinvolgerebbe nel nascente e redditizio traffico di droga. Da questo sgarbo prende il via una crudele battaglia fra le due organizzazioni, nella quale si mette in luce Michael (Al Pacino), figlio di don Vito, che quest’ultimo designerà suo successore. Coppola, sulla scia del successo di questo film, ha voluto realizzare altre due pellicole di pregio sul medesimo tema (uno che narra del regno di Michael Corleone, mentre l’altro torna indietro nel tempo per raccontare l’infanzia, la giovinezza e la prima maturità di don Vito, interpretato questa volta da Robert De Niro), senza tuttavia ritrovare quella stessa efficacia.
Il regista Conrad Rooks realizza nel 1972 la trasposizione cinematografica del più celebre romanzo di Hermann Hesse (pubblicato esattamente cinquant’anni prima): Siddharta. Alcune scelte rendono questo film particolarmente riuscito: avere avuto a disposizione i meravigliosi e immensi parchi privati di un Maharaja dello Uttar Pradesh per le locations, aver potuto contare sull’apporto creativo di una piccola ma eccellente troupe svedese comprendente uno dei migliori direttori della fotografia all’epoca disponibile (Sven Nikvist), avere scelto interpreti indiani (compresi alcuni sadhu di Rishikesh, ma anche un gruppo di monaci tibetani di un ashram indiano), fra i quali spicca il protagonista, Shashi Kapoor. Oltre, naturalmente, a un buon adattamento filmico del romanzo. Ne risulta un lungometraggio di rara bellezza visiva e dal racconto lineare e intenso. Si segue perciò con partecipazione il percorso di Siddharta, un uomo ‘in cerca’ che, anzitutto, cerca di vivere con interezza la propria vita, passando di esperienza in esperienza (dal misticismo alla sensualità, dalla meditazione filosofica agli affari) rifiutandosi dal considerare definitiva alcuna acquisizione, alcun maestro, alcun sentiero, perché ciò che va cercato è tutto. E, alla fine, quel tutto rifluirà dietro il sorriso di una completa consapevolezza, simile a un fiume in piena.
Basandosi sugli atti del processo custoditi dal tribunale dell’Inquisizione, nel 1974 Giuliano Montaldo ha realizzato un film su una delle figure più affascinanti della storia: Giordano Bruno. Le intimidazioni, le torture atroci, infine il rogo: il potere non esitò a usare ogni mezzo, pur di soffocare questa voce di libertà. Ma la forza delle idee non si spense insieme a quelle fiamme orrende accese il 17 febbraio 1600. Prendendo come pretesto una processione commemorativa della vittoria di Lepanto, il film inizia dal punto in cui Giordano Bruno rientra in Italia (a Venezia) dopo varie peregrinazione europee e si scaglia contro una religione che fa uso della violenza. Il suo stile di vita non è molto comune: è spregiudicato nel linguaggio e nei costumi, e presto viene denunciato all’Inquisizione. Affronta il processo con dignità, pur se ridotto ai limiti della sopportazione umana. La presenza intensa e partecipata di Gian Maria Volontè nella parte del Nolano è determinante nella riuscita del film, che si avvale anche di ottimi caratteristi e della mirabile fotografia di Vittorio Storaro (bellissimi sia gli interni sia gli esterni), oltre che delle musiche di Ennio Morricone. Ne risulta un film che non fa concessioni a esigenze commerciali, e tuttavia è fortemente spettacolare.
Nel 1975 Stanley Kubrick realizza un mirabile film in costume, ricco di fascino e di ironia: Barry Lyndon, incentrato sulla figura di Redmond Barry, tratta dal romanzo di Thackeray. Forse, stilisticamente parlando, è il film più classico della produzione di Kubrick: mai come in questa pellicola infatti il regista era stato così attento alle simmetrie (precise al millimetro), ai gesti, agli sguardi e alle sequenze (chiuse geometricamente). E i personaggi assumono il ruolo di manichini, aiutati dal comportamento e dalle maniere dell’epoca: si mostrano, si guardano, si mettono in posa in tutto, dalla semplice partita a carte fino al duello. Nonostante ciò il senso di vuoto interiore mascherato dalla potenza dell’estetica pervade tutto e tutti. A conferma di questa scelta espressiva, sono numerose le scene riprese magistralmente a lume di candela, nella tenue illuminazione che solo una fiamma può dare, il cui tremolio rappresenta la precarietà di Barry che è anche, più in generale, la precarietà dell’uomo.
L’amicizia e il rapporto dell’uomo con la natura sono i due fulcri sui quali Akira Kurosawa impernia il film Dersu Uzala, realizzato nel 1975 e ispirato ai due libri di viaggio di Vladimir K. Arseniev. All’inizio del XX secolo, il capitano Arseniev conduce una spedizione di ricognizioni geografiche ai confini della Cina, nella vasta e inesplorata zona del fiume Ussuri. Una sera, mentre gli uomini riposano accanto al fuoco, si presenta un cacciatore anziano della tribù dei Gold. Invitato a fungere da guida, Dersu si dimostra un uomo di grande semplicità e saggezza. Separatisi con dispiacere, i due amici si ritrovano nel corso di una seconda spedizione. Con un uso pittorico della macchina da presa, Kurosawa dipinge un affresco avvincente dell’amicizia che nasce tra i due. Il finale drammatico permette allo spettatore di riflettere sull’approccio quasi da conquistatore dell’uomo nei confronti della natura, un approccio che viene processato dallo stesso regista giapponese.
Basandosi su un romanzo di Joan Lindsey, Peter Weir realizza nel 1977 Picnic at Hanging-Rock, film raro nel suo genere, pervaso da un senso d’inquietante sensualità in una suggestiva atmosfera di mistero. Incidente, delitto o magia? Dietro questi irrisolvibili quesiti si svolge con sinistra e raffinata maestria la storia che racconta l’enigmatica scomparsa di un gruppo di studentesse ai piedi di Hanging Rock, imponente formazione vulcanica australiana, nel giorno di San Valentino. La descrizione della vita del collegio di Appleyard è intrigante, ma ancora più avvincente la vicenda della scomparsa misteriosa delle ragazze, giocata sull’associazione fra abbandono femminile e fascinazione della natura. Di fronte al roccioso deserto che si era aperto al loro sguardo, durante una passeggiata, tre giovani allieve e una istitutrice spariscono improvvisamente senza alcun motivo apparente, dopo aver oltrepassato un varco. Cominciano le ricerche. Le vicende delle donne scomparse si intrecciano con quelle di due ragazzi che si ostinano a cercarle. Il ritorno di alcune di esse però è privo di memoria e carico di choc. Non c’è spiegazione, non c’è soluzione, il mistero della natura ancora una volta disgrega il perbenismo e la razionalità opprimente della cultura.
Ispirandosi molto liberamente alla bella autobiografia di Giacomo Casanova (“Storia della mia vita”), Fellini nel 1977 realizza magistralmente il film Il Casanova di Federico Fellini (facendo trasparire fin al titolo che si tratta di una lettura tutta personale). Vecchio e malandato, Giacomo Casanova, bibliotecario nel castello di Dux in Boemia, rievoca la sua vita densa di amori e di avventure. Prima, da giovane, a Venezia dove, incarcerato per le sue sregolatezze, evade dai Piombi e comincia a vagare per le corti europee conducendo una vita brillante, ricca di amori, di truffe, di onori. Con il passare del tempo però il suo successo si va appannando; molte porte gli si chiudono in faccia, la degradazione fisica e morale va accentuandosi con sempre maggiore celerità. Trova infine rifugio presso un nobile boemo, che però lo esibisce come un ridicolo fantasma del passato. Ma lo spirito di Casanova è irriducibile ed egli lo fa rivivere e perpetuare scrivendo di notte le sue memorie. È probabilmente il film più bello di Fellini, quello che più di tutti resta attuale. Alcune scene sono un capolavoro di inventiva e di grazia estetica (il mare in tempesta finto, fatto con onde di plastica, per esempio, lascia a bocca aperta — e c'è chi non si è nemmeno accorto del trucco, tanto è verosimile).
Francis Ford Coppola realizza, con Apocalypse Now (1979), un film sull’intervento americano in Vietnam. Ma la follia del Vietnam appare come un semplice pretesto per tentare di dare un messaggio molto più complesso, ispirato in buona parte da un romanzo seminale della cultura occidentale: Cuore di tenebra di Joseph Conrad (sceneggiato da John Milius). Nel corso di una spedizione lungo il fiume («un cavo elettrico che corre attraverso la guerra») alla ricerca di un avamposto disperso, guidato dal colonnello Kurtz (un ineffabile ma più che mai carismatico Marlon Brando, che compare nell’ultima parte del film e che interpreta il ruolo di un disertore che fuoriuscito in Cambogia ha creato un suo regno in mezzo alla giungla dove è adorato come un dio), il tenente Martin Sheen cerca di condurci alla scoperta dell’aspetto più torvo dell’animo umano, come in una discesa visionaria nel cuore delle tenebre. Esiste anche una versione (Apocalypse Now Redux), messa in circolazione più di venti anni dopo (2001), in cui Coppola reintegra nel montaggio alcune scene che all’epoca erano state omesse (per un totale di ben 40 minuti di girato). Stupenda la fotografia di Vittorio Storaro.
Nel 1980 il geniale regista David Cronenberg scrive e dirige il film Scanners. Girato con la consueta bravura di questo regista, il film è incentrato sul personaggio di Cameron Vale, un giovane disadattato che vive ai margini della società, il quale viene prelevato contro la sua volontà e portato al cospetto del dottor Ruth, che gli fa scoprire di essere uno ‘scanner’, un individuo dotato di poteri telepatici — l’ultimo rimasto capace di contrastare Darryl Revok, anche lui dotato degli stessi poteri, che sta attuando un progetto mirato a creare una razza di scanners e ridurre in questo modo l’intera società in schiavitù sotto il suo dominio. Accettato l’incarico, Cameron prende progressivamente coscienza delle proprie capacità e si troverà presto immerso in una rete fitta di intrighi, scoprendo tra le altre cose di essere frutto di un esperimento portato avanti ancora oggi. Il film sembra una rievocazione in chiave moderna della parabola di Caino e Abele, con un finale inaspettato e molte interessanti intuizioni disseminate nell’intera pellicola.
Ridley Scott, regista di lunga esperienza pubblicitaria, ispirandosi a un raffinato scrittore di fantascienza quale Philip Dick, realizza, nel 1982, Blade Runner, ambientato in una Los Angeles del 2019 caotica, flagellata ininterrottamente dalla pioggia, minacciata dalla rivolta di un gruppo di replicanti (i ‘Nexus 6’), fabbricati da uno scienziato-manager, i quali non accettato di “spirare” dopo i quattro anni di vita che sono stati loro assegnati. Per rintracciarli e distruggerli, le autorità incaricano un “blade runner” abile e disincantato, Rick Deckard (la faccia di Harrison Ford è perfetta) e gli forniscono gli strumenti per agire. Molto liberamente tratto dal romanzo Il cacciatore di androidi di Philip Dick, il film conserva una grande forza visiva, enfatizzata dall’uso sistematico del controluce in funzione antinaturalistica. I panorama che il regista allestisce, grazie alla scenografia di Laurence Paull e agli effetti speciali, crea angoscia: colori cupi, controluci livide, esplosioni e agguati. Il sospetto del kitsch incombe, ovviamente, ma la suggestione resta. Nella riedizione del 1991 con il ‘director’s cut’, Ridley Scott, respingendo le precedenti imposizioni del produttore, presenta un finale meno aperto e ottimistico, e il film ci guadagna notevolmente.
Molto diverso dalle sue consuete commedie, Woody Allen realizza Zelig (1983) è forse il suo film più geniale, con uno humour particolarmente sferzante e cupo. Imitando alla perfezione il taglio del documentario, il regista interpreta in modo assolutamente convincente un ometto americano che ha avuto un’infanzia particolarmente traumatica e che, nella sua smania di essere accettato dagli altri, ha sviluppato camaleontiche capacità di assumere le caratteristiche di chiunque gli capiti di incontrare. Una dottoressa ambiziosa e desiderosa di fare carriera, si mette in testa di analizzarlo e curarlo, per raggiungere la fama. A poco a poco, però, si innamora del suo paziente e arriva a sposarlo. Ma qualcosa si mette di traverso e Zelig cade di nuovo nelle sue vecchie fobie. Cercando a tutti i costi di essere normale e sentirsi accettato, sente il bisogno gregario di unirsi a un gruppo potente, una istituzione che gli dia quella sicurezza che cerca. Si confonde quindi tra i vescovi del Vaticano e, una volta scoperto, diventa un membro del Reich. Ma non sarà nemmeno questa la conclusione del suo itinerario. Un vero cammeo.
Il regista del western all’italiana Sergio Leone conclude in bellezza (nel 1984) la sua carriera con un monumentale affresco (che gli ha richiesto dodici anni di lavoro) sull’America di ieri (che non è poi così diversa da quella di oggi): C’era una volta in America. L’autobiografia di un piccolo gangster (dal libro “A mano armata” di Harry Grey, abilmente rimaneggiato da sei ottimi sceneggiatori fra i quali lo stesso regista — e interpretato con la consueta bravura da Robert De Niro) serve da filo conduttore a una cronaca romanzata dell’evoluzione della società americana. Fiaba piena di umori forti e di crudeltà, il film presenta zone nere ben calcolate e una tenerezza fasciata di truculenza. Una ganster-story all’insegna di Proust — ma per struttura è un labirinto alla Borges — su un arco di mezzo secolo di storia, a partire dai “ruggenti anni Venti”. Ne viene fuori una saga di morte e iniquità, sesso e violenta, cupidigia e tradimento, che è rabbiosa e struggente.
Il gruppo inglese dei Monthy Python si è rivelato negli anni Settanta come portatore di una comicità surreale e sfrenata. E ha dato al cinema almeno un capolavoro: Brazil, realizzato nel 1985 da Terry Gilliam. Il film è una sorta di trasposizione aggiornata, geniale e molto libera del romanzo 1984 di Orwell. Burocrazia, polizia segreta e palese, mondo dei ricchi privilegiati e mondo dei reietti vengono attraversati da Sam Lowry, il protagonista, un qualsiasi giovane cui l’amore cambia la vita. La musichetta brasiliana di commento è nostalgia ed evasione rispetto a una realtà crudele e assurda, appena un po’ più assurda della nostra. Orwell non avrebbe potuto trovare adattatore di Terry Gilliam, il quale costruisce blocchi narrativi spesso caotici, girati con uno stile deformante, mescolando il più cupo pessimismo a scene più lievi, alternando momenti ora sprezzanti ora comici, ora angosciosi, ora di humour aereo e svagato come nel bel personaggio di Robert De Niro, un “guastatore” alla rovescia che ripara gli impianti disastrati che la logica del consumismo e del degrado cara al potere vota all’abbandono. Alla fine, Sam riesce a fuggire con Jill, la ragazza che ama, verso un paese libero, ma l’ultima parte della sua storia è solo un sogno da cui è duro ridestarsi: Jill è stata uccisa, e il giovane è legato alla sedia della tortura.
Ispirato a una storia vera, The Mission (1986) di Roland Joffé narra la storia di un gruppo di coraggiosi missionari che, fra il 1608 e il 1767, riuscirono a dare vita — in una vastissima plaga incuneata fra i fiumi Paranà e Uruguay (nell’attuale Argentina) — a un grande sogno, realizzando una sorta di paradiso terrestre, in collaborazione con le tribù dei Guarany, evitando così a questi indigeni umiliazioni e razzie di spagnoli e portoghesi. Tra foreste e corsi d’acqua imponenti, gli indigeni appresero a vivere pacificamente in un sistema comunitario. Ma i regni di Spagna e Portogallo presto lottarono per cancellare quel grandioso esperimento (che impediva di commerciare schiavi); così, con la ‘mediazione’ di papa Clemente XIII (il quale invia in sua vece il cardinale Altamirano), venne imposto ai missionari di abbandonare quelle tribù, pena l’espulsione non solo dall’America del Sud, ma anche dall’Europa. Una spedizione militare verrà inviata contro la missione di padre Gabriel (Jeremy Irons), di Rodrigo (Robert De Niro) e degli altri confratelli, perpetrando l’ennesimo genocidio della storia.
Lo sguardo mordace e impietoso di Stanley Kubrick mette a nudo tutta l’insensatezza e la follia della guerra con Full Metal Jacket (1987), prima mettendo alla berlina il disumano addestramento delle reclute, poi — nella seconda parte del film — mostrando la crudeltà e l’insensatezza della guerra (nella fattispecie, il Vietnam). La prima parte ha un ritmo serrato e mostra quanto possa essere aberrante il lavaggio del cervello cui vengono sottoposti un gruppo di giovani reclute, i piú deboli dei quali vengono schiacciati e annientati oppure, in una sorta di meccanismo di autodifesa, diventano squilibrate macchine da guerra che possono ritorcersi contro i loro stessi creatori. La seconda parte è più aspra e cruda, giacché le reclute, finito l’addestramento, si trovano da un giorno all’altro sprofondati nell’orrore della guerra. Kubrick ha una sorta di ossessione nei confronti della violenza, che tenta in vario modo di esorcizzare, mettendo a nudo tutta l’umana follia.
Grande affresco di un’èra al tramonto, L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, realizzato nel 1987, è tratto dall’autobiografia dell’ultimo imperatore della Cina Aisin Gyoro Pu Yi della dinastia dei Ching, che fu incoronato nel 1908 all’età di tre anni. Il passaggio da una condizione di “drago” a quella di essere umano, da imperatore a cittadino comune, porterà il protagonista a essere prima un fantoccio nelle mani dei giapponesi che lo insediano sul trono della Manciuria e poi un prigioniero dei sovietici nel 1946. Ritornato in Cina viene sottoposto a un lungo periodo di rieducazione. Pu Yi morirà nel 1967 dopo che fu nominato capo giardiniere dell’orto botanico di Pechino. La fotografia di Vittorio Storaro contribuisce alla bellezza del film, ma anche il montaggio e la colonna sonora hanno un loro peso nel presentare la caduta della monarchia e lo smarrimento di un imperatore costretto a confrontarsi con la ‘normalità’.
A metà tra il poetico e il didascalico Der Himmel über Berlin (‘Il cielo sopra Berlino’, 1987) di Wim Wenders, affascina ma lascia anche un po' titubanti. Affascina l’incastro nella città (ancora divisa dal muro) di una fiaba — metà in bianco e nero, metà a colori — che narra di angeli stanchi di essere angeli (il Damiel che si innamora di una trapezista), di angeli che resistono nella loro missione (il biondo Cassiel) e di ex angeli che sentono la nostalgia del passato (l’attore americano Peter Falk venuto in Europa per un film sul nazismo). Dall’alto dei due monumenti simboli di una città (il rudere della Gedächtniskirche e la Siegessäule, la “colonna della vittoria”), Damiel e Cassiel guardano le strade e i passanti. Poi affrontano la realtà: la biblioteca nazionale, un piccolo circo, il grande spiazzo che un tempo era la Postdamerplatz, il set dove gira Peter Falk, una discoteca. Quando angeli non sono più, come Damiel che getta via la sua corazza, diventano grevi, ma appassionati come gli uomini possono essere. Wenders comunica lievemente una sensazione di attesa che si trasforma in una sorta di fiducia nell’uomo.
Dal breve racconto Eight O'Clock in the Morning di Ray Nelson (del 1963), il regista John Carpenter realizza, nel 1988, il film They live (Essi vivono). Si narra di uno statunitense, John Nada, che si trasferisce a Los Angeles in cerca di lavoro. Viene assunto come operaio in un cantiere edile e grazie a un collega trova alloggio in un campo di baracche nella periferia della città. Ma dopo pochi giorni la polizia sgombera il campo e Nada ritrova una scatola piena di strani occhiali da sole. Provandoli, Nada scopre una realtà diversa, in bianco e nero: i cartelloni pubblicitari contengono messaggi subliminali e in giro ci sono moltissime persone dall’aspetto simile a zombi. Il fulcro del discorso critico del film è che la società consumistica e i media dominano la mente degli esseri umani e ne condizionano lo stile di vita senza che questi se ne rendano conto.
Ci furono tempi in cui la preparazione e la consumazione del tè costituivano un rito basato sull’ordine, la disciplina e l’armonia. L’arte del tè, in Giappone, era praticata da maestri zen, che durante la cerimonia tendevano verso le massime vette della perfezione e della bellezza. La bevanda era un pretesto per praticare il culto della purezza e della raffinatezza, una funzione durante la quale il maestro e gli invitati si univano per vivere un momento di serena beatitudine nel cuore dell’esistenza fenomenica. E proprio su questa cerimonia Key Kumay ha realizzato nel 1989 il film Sen No Rikyu (‘Morte di un maestro del tè’), caratterizzato da una curatissima e affascinante ambientazione e da una storia avvincente e complessa. Nessuna concessione allo spettatore: tutto è strettamente fedele alla tradizione nipponica. Alla fine del sedicesimo secolo, primo gran maestro del tè fu Sen No Rikyu (che prende il volto austero e imperioso di Toshiro Mifune). Per motivi rimasti ignoti il maestro fece hara-kiri nel 1591 e, qualche anno dopo, i due suoi maggiori discepoli scelsero la stessa sorte. Il film, la cui sceneggiatura è tratta dal romanzo “Il testamento di Honkabuko” di Inoue, parte dal 1618, nel momento in cui un terzo discepolo cerca di capire le ragioni del suicidio del maestro e dei suoi due allievi prediletti. Questo film è una vera delizia per gli intenditori, ammirevole sotto tutti gli aspetti.
Atmosfere romantiche si respirano in Impromptu (1991) di James Lapine, incentrato sulla relazione tra Frédéric Chopin e la scrittrice George Sand (pseudonimo di Aurore Dupin, celebre nei salotti letterari di Parigi per il suo acceso anticonformismo) intorno al 1836. George è molto amica di Franz Liszt e della sua amante, la contessa Marie d’Augoult. In casa loro la scrittrice ascolta un giorno, senza vederlo, Frédéric Chopin suonare una sua composizione, e, rimasta incantata dalla sua arte, vuole conoscere il pianista polacco. Perciò si auto-invita nella tenuta dei duchi d’Anatan, dove per qualche giorno saranno ospiti Chopin, Liszt, Marie e il pittore Delacroix, e qui si introduce nella stanza di Chopin, che, timido e schivo, la respinge. Quando tornano a Parigi, Chopin si convince della sincerità dei sentimenti di George e i due diventano amanti.
Piccolo miracolo di grazia, Why Has Bodhidharma left for the East? (‘Perché Bodhidharma è partito per l’Oriente?’) è un film pieno di allusioni e di silenzi firmato da Yong-Kyun Bae (pittore, prima che regista e sceneggiatore) e realizzato nel 1991. Con una lentezza descrittiva che rasenta l’estasi, si intrecciano le vite di tre personaggi appartenenti a tre diversi stadi della vita: un anziano monaco buddhista, un giovane adepto e un bambino orfano che il maestro ha preso con sé. Rari i dialoghi, tutto si basa sulla forza delle immagini della natura e l’espressività dei volti. Diventare illuminati significa risvegliarsi al senso dell’esistenza, vedere le cose per quello che sono, inserirsi nel grande Ritmo, all’unisono con pietre, fiumi, animali, fuoco, pioggia. E percepire il continuo mutare delle cose alla luce di quel Qualcosa che mai muta.
Una sorta di prosieguo de ‘Il cielo sopra Berlino’, In Weiter Ferne, So Nah! (‘Così lontano così vicino’) di Wim Wenders (realizzato sei anni dopo, nel 1993), condivide sostanzialmente gli stessi pregi e alcuni dei difetti del primo. Riprendendo il racconto della ‘caduta’ degli angeli, il film narra come Damiel, nonostante l’amore per Raphaela, si sente irresistibilmente attratto dal mondo, dalle storie degli uomini e dai loro pensieri. Altri angeli sono caduti per amore, come Peter Falk e Lou Reed, altri ancora seguiranno la stessa sorte — mentre il tempo trascorre inesorabile e non aspetta nessuno. Ci sono alcune intuizioni interessanti, altre forse un po’ banali e ripetitive, ma è soprattutto (e non poteva essere altrimenti, trattandosi di un film!) la forza di alcune immagini a imprimere tracce altamente suggestive.
Ritratto commovente della Shoah, Schindler’s List di Steven Spielberg (1994) è incentrato sulla storia di Oskar Schindler, realmente esistito e membro del partito nazista, affarista e profittatore di guerra che salva la vita a più di 1.100 ebrei. Durante l’evacuazione del ghetto di Cracovia Schindler si rende conto del massacro degli ebrei. E inizia a pensare di usare la sua fabbrica e i guadagni di questa per salvare veramente qualcuno. Infatti, quando gli viene fatta la richiesta di trasferimento della propria fabbrica all’interno di un lager, Schindler decide di acquistare la sua manodopera. Compila la famosa Lista, quella che ha reso Schindler un benefattore del popolo ebraico. Paga contanti per avere la sua gente. La fabbrica passa quindi alla produzione di materiale bellico, granate e quant’altro… volutamente non funzionanti! Il pagamento di tangenti e l’acquisto di materiale rivenduto come proprio corrode le finanze di Schindler, che alla fine della guerra si trova sul lastrico. Oskar Schindler è morto in miseria, ma viene tutt’ora ricordato dal popolo ebraico come un giusto.
Sopra le righe e a tratti sublime, con un esasperato gusto barocco, Underground di Emir Kusturica (1995) racconta in modo romanzato la storia contemporanea dell’ex-Jugoslavia, in bilico tra storia e leggenda, fra tristezza e gioia di vivere. Un’orchestrina di ottoni solleva gli animi dei rifugiati nel sotterraneo trasformato in officina per la costruzione di armi da guerra. Nero è sposato con Natalija, attricetta che passa con disinvoltura dalle braccia del marito a quelle del miglior amico di lui, Marko, a quelle di un ufficiale nemico. Marko nasconde la fine della guerra agli abitanti del sottosuolo, così li sfrutta per produrre e vendere armi a delinquenti e partigiani titoisti. Sottrae la moglie all’amico e la porta con sé in superficie. Qui regna Tito, di cui Marko diventa il braccio destro. I registi di regime intanto dedicano film epici alla lotta partigiana di Nero, che Marko ha spacciato per morto, caduto con onore sui campi di battaglia. Il tempo passa, e un’altra guerra insanguina la Jugoslavia: quella del dopo Tito.
Nel 1996 Richard Loncraine realizza una versione cinematografica del Richard III (‘Riccardo III’) di Shakespeare su una sceneggiatura curata dall’attore Ian McKellen, che ricopre con impareggiabile bravura il personaggio principale. Circondato da truppe in uniforme e esaltato da cerimoniali del terzo Reich, il duca di Gloucester costringe i nobili a incoronarlo, diventando così Riccardo III. L’accordo voluttuoso del liuto che Gloucester evoca sdegnosamente nel primo monologo per dileggiarne le associazioni cortesi e languide, è posto in acuto contrasto con la scena di apertura, in cui un carro armato penetra sventrando la stanza del quartier generale; e, in seguito, con le aspre note del cupo stridulio delle porte della Torre che si aprono e chiudono su Hastings, Clarence, e sui principi ereditari della corona regia; fino agli strepiti degli ordigni da guerra della battaglia finale. Riccardo, dall’inizio alla fine, appare monolitico (seppure tutt’altro che statico) nella sua radicale malvagità. Un solo momento di “codarda coscienza”, sembra fargli riconoscere la propria natura scellerata. Ma da ciò non nasce alcun ravvedimento, ed egli avanza deciso e diabolico verso la propria disfatta.
Nell’adattare per il grande schermo Sense and Sensibility (‘Ragione e sentimento’), il primo romanzo pubblicato da Jane Austen, l’attrice Emma Thompson (qui anche doviziosa sceneggiatrice) e il regista Ang Lee sono riusciti a evocare il piccolo mondo ipocrita e capriccioso che la scrittrice inglese, cresciuta fra i ricevimenti e i pettegolezzi della piccola nobiltà agraria tra Settecento e Ottocento, ci ha lasciato nei suoi libri. Le due protagoniste, Elinor e Marianne (rispettivamente Emma Thompson e Kate Winslet), sono entrambe giovani donne brillanti e colte, cui gli schemi, i doveri, le aspettative in cui s’inquadra il loro sesso stanno stretti; ma mentre Elinor, la maggiore, si rassegna al sacrificio dei suoi sentimenti e delle sue aspirazioni, Marianne sceglie di seguire sempre e comunque le ragioni del suo cuore impetuoso. Inaspettatamente, è Elinor a conquistare le simpatie dello spettatore, per la sua sensibilità ricca ma per nulla impulsiva, la sua generosità mai ostentata, la sua attenzione per quanti gli stanno intorno. E, a dispetto del finale, resta l’amarezza per la perdita della straordinaria vitalità di Marianne, vittima di un mondo che nega alle donne la possibilità di esprimere se stesse e non offre loro altro che una scelta: il matrimonio o l’ostracismo.
Considerata universalmente come esempio perfetto di commedia rinascimentale, Twelfth Night (‘La dodicesima notte’) è stata magistralmente trasformata in film nel 1996 da di Trevor Nunn, che ha saputo mantenere la freschezza e l’inesauribile inventiva dell’azione e dei caratteri della materia comica anche grazie alla bravura corale degli attori. Opera esemplare del genio comico di Shakespeare, anticipa anche sotto il profilo scenico il migliore Molière, lasciando trasparire nelle celebri arie musicali condiscendenza e lirica simpatia per le stravaganze e le ingenue follie degli uomini. Il sottotitolo dato da Shakespeare alla commedia, What you Will (‘Quel che volete’), è una sorta di invito allo spettatore a trovare un titolo da per sé, ove quello della dodicesima notte non lo soddisfi (l’anno prima, sulla medesima linea, Shakespeare aveva scritto la commedia intitolata As You Like It, ‘Come vi piace’), e ricorre piuttosto di frequente, nel Bardo, l’abitudine a dare dei titoli che pare non dicano nulla ma che, in realtà, spesso lasciano trapelare l’atmosfera dell’opera; nel titolo La dodicesima notte, infatti, per quel ricorrervi d’un numero pari e di un’ombra notturna, traspare una indicazione di equilibrio (è considerata la commedia più sapientemente bilanciata di Shakespeare) e di pacato distacco. E il film riesce a restituirne con rara sensibilità e maestria tutta la compostezza e la bellezza.
La cinematografia shakespeariana arriva a un suo apogeo con il sublime Hamlet (‘Amleto’) di Kenneth Branagh, realizzato nel 1997. Questo grandioso evento cinematografico si avvale di un prestigiosissimo cast internazionale, tra cui spiccano Charlton Heston, Julie Christie, Jack Lemmon, Billy Crystal, Kate Winslet, Derek Jacobi, Rufuss Sewell, e dove compaiono quasi di sfuggita (difficile però non notarli!) Gerard Depardieu, Robin Williams, e perfino sir John Gieguld nel ruolo-cammeo di Priamo evocato dal capocomico della compagnia degli attori che Amleto accoglie a Palazzo. Kenneth Branagh, nel ruolo principale, mostra con sorprendente disinvoltura e con una bravura che sfiora il sublime gli ampi registri espressivi di Amleto, le sue intramontabili riflessioni esistenziali, i suoi sdegni e le sue rivolte. Kenneth Branagh è riuscito a risolvere al meglio tutte le insidie che una trasposizione cinematografica poteva presentare, consegnandoci un film coinvolgente, ricchissimo ma mai eccessivo, dove la cura meticolosa dei costumi, delle scenografie sfavillati, delle musiche, dell’agilità della macchina da presa e tutto il resto viene sempre messo al servizio della poesia, e mai utilizzato come fine a se stesso.
Film sulla guerra più che un film di guerra, The thin red line (‘La sottile linea rossa’), ispirato all’omonimo romanzo di James Jones che narra le vicende di una compagnia di soldati statunitensi impegnati nella conquista dell’isola di Guadalcanal nel 1942, sceneggiato e diretto da Terrence Malick nel 1998, rappresenta una lunga meditazione sul disorientamento dell’uomo di fronte all’orrore da lui stesso creato, il tutto visto con un occhio disincantato e libero da sentimentalismi o moralismi. Ed è forse proprio per questo che la guerra appare in tutta la sua follia — non a caso, il titolo è preso a prestito da Rudyard Kipling: «tra la lucidità e la follia c’è solo una sottile linea rossa». Linea esilissima e drammatica che il film esplora con tutta la meticolosità riconosciuta a Terrence Malick. Inizialmente, la pellicola prodotta ammontava a sei ore, ma il lungo processo di montaggio l’ha dimezzata, riducendo drasticamente (o addirittura eliminando del tutto) la presenza di diversi attori di spicco pur di rendere la massima efficacia filmica. La fotografia è mirabile, sia quando riprende la selvaggia bellezza dei luoghi, sia quando mostra l’insensatezza della guerra (in acuto contrasto con l’incanto della natura circostante); le riflessioni sono sempre intense e di non comune levatura, rivolte a quell’Anima universale in cui tutto è uno.
Apologo della vita e feroce critica alla cinica volgarità televisiva che mette le sue grinfie su qualunque sentimento pur di fare ‘audience’, The Truman Show di Peter Weir (1998) è un film geniale e provocatorio. Il protagonista del film è la star di uno show televisivo, ma lui non lo sa! Truman Burbank (interpretato da Jim Carrey) infatti non immagina minimamente che la tranquilla cittadina in cui vive è un gigantesco palcoscenico controllato da un visionario produttore-regista-creatore, che le persone che vi vivono e lavorano sono attori e comparse di Hollywood e che perfino la sua effervescente mogliettina è un’artista sotto contratto. Ma il meccanismo ogni tanto s’inceppa, e gradualmente Truman si renderà conto che qualcosa non quadra, e cercherà di capire come stanno realmente le cose. Fra il comico e il drammatico, il film è un’audace e originale riflessione a più piani sovrapposti, con un finale di grande effetto.
Riuscitissimo ritratto d’artista, Goya di Saura Carlos (del 1999) rievoca l’arte, gli amori, le invidie e la passione politica del grande artista aragonese con un approccio onirico-visionario, prestando ovviamente molta attenzione alla pastosità dei colori, delle linee, delle ombre e delle luci (la fotografia è di Vittorio Storaro). Il risultato è un affresco sontuoso e cupo che valorizza la sua personalità turbolenta ma anche i grandi avvenimenti storici spagnoli. Francisco de Goya vive in esilio a Bordeaux insieme all’ultima delle sue amanti, Leocadia Zorrilla De Weiss. Ha 82 anni e una figlia adolescente di nome Rosario. Stanco e affaticato, Goya rievoca alla figlia alcuni dei momenti più significativi della propria vita, contraddistinta da una incessante ricerca di ricchi mecenati che gli permettessero di dedicarsi alla propria arte e passata attraverso turbolente fasi storiche: sconvolgimenti politici, passioni, invidie si sono avvicendati con alterne fortune. Forte l’impatto visivo.
Nel 1999 Oliver Parker firma un memorabile adattamento della intricata e bellissima commedia di Oscar Wilde An Ideal Husband (‘Il marito ideale’). Scritta nel 1893, andata in scena per la prima volta nel 1995 e pubblicata in forma di volume nel 1999, la commedia ricevette grandi favori da parte di George Bernard Shaw, nelle vesti di critico teatrale. Il testo appartiene a quelli meno inconsistenti di Wilde, che qui si preoccupa tra le altre cose di creare un intreccio di notevole consistenza, fra un marito molto rispettato ma con un passato segreto, una moglie troppo intransigente, un’avventuriera spregiudicata e opportunista in cerca di ricchezza, uno scapolo impenitente in procinto di capitolare davanti a una donna innamoratissima di lui. Il cast è perfettamente a proprio agio (da notare in particolare la singolare bravura di Rupert Everett nel dare vita al personaggio dello scapolo) e le ambientazioni sono state realizzate con cura davvero ammirevole.
Tanto grande e geniale quanto pasticciati e banali i due sequels, Matrix dei fratelli Wachowski (1999) è un vero capolavoro. Da un punto di vista strettamente tecnico, il cinema non è più lo stesso dopo questo film — troppe sono le innovazioni che ha saputo introdurre, dal “bullet-time” all’uso dei sospensori che permettono al corpo di liberarsi dalla gravitazione e da ogni pesantezza. Da un punto di vista più globale, mai si era visto al cinema rappresentare la crisi evolutiva in cui l’umanità è immersa. Ogni essere umano è uno schiavo, totalmente ignaro della menzogna che lo circonda e nella quali vive una vita fasulla, immerso in una falsa realtà materiale che copre e deforma la vera Materia e il vero mondo. Perché, al di fuori di questa sorta di trappola nella quali siamo tutti prigionieri, esiste la vera realtà terrestre, la vera condizione dell’essere in cui TUTTO È POSSIBILE, come Neo, il protagonista, giunge a comprendere alla fine di un percorso brutale cui viene sottoposto grazie all’aiuto di Morpheus. Ma occorre, innanzitutto, liberarsi da tutti i vecchi meccanismi interiori che costituiscono la cosiddetta ‘vita’, per imparare a vivere in modo nuovo — nel mondo vero. Perché, ci dice il film, esistono delle forze ostili che si sono impossessate dell’umanità e che hanno interesse a tenerla in schiavitù. Ecco allora che per Neo diventa imperativo combattere queste forze e vincerle. Difficile immaginare qualcosa di più pregnante nel descrivere la Battaglia realmente in atto e la resistenza che il mondo attuale, falso e distorto, oppone alla sua stessa trasformazione nella propria realtà leggera e libera. Non c’è un solo dettaglio che stride: tutto è perfetto. È un vero peccato che i registi si siano lasciati essi stessi intrappolare nella banalità del vecchio mondo, offrendoci — come dicevamo — due sequels di pessimo gusto conditi nella peggiore salsa new-age.
La storia di un vecchio capo è il pretesto per realizzare un film di intenso lirismo, Himalaya, the rearing of a chief (‘Himalaya, l’infanzia di un capo’, 2001), regia di Éric Valli, con attori tibetani molto bravi anche se poco famosi (Gurgon Kyap, Thilen Lhondup, Lhakpa Tsamchoe), taluni non professionisti. L’intensità dei paesaggi e delle musiche struggenti fanno da mirabile sfondo alla vicenda, semplice e commovente, ricca di metafore e di saggezza. In un remoto villaggio nel Dolpo, nel cuore dello Himalaya, a una altezza di cinquemila metri, Tinlé, un carismatico vecchio capo il cui figlio maggiore è appena morto, rifiuta di permettere al giovane Karma, che egli accusa di essere stato responsabile della morte del bimbo, di condurre la carovana di yak per l’annuale trasporto del sale da barattare con il cibo. Karma si pone allora contro l’oracolo e le decisioni del capo, conducendo la carovana. Il giorno stabilito dagli dèi, Tinlé, assistito dal suo secondo figlio, Norbu (che è un lama), decide anch’egli di mettersi in cammino, in questa sorta di iniziazione di un nuovo capo che prende la forma di un confronto fra l’uomo e la natura selvaggia delle montagne più alte del mondo.
Ang Lee nel 2001 realizza Crouching Tiger, Hidden Dragon (‘La tigre e il dragone’). In una terra di infinita bellezza e di leggende, una spada antichissima e preziosa — chiamata ‘Destino verde’ — fa incrociare i destini di un guerriero taoista, della donna che lo ama, di un fuorilegge e di una principessa che sogna di diventare un guerriero ma che i genitori avrebbero destinato a una banale e agiata vita coniugale. Eroi e antagonisti, amori e vendette, duelli in volo che immergono lo spettatore in un’atmosfera da fiaba, nati dalla fantasia e dalla tecnica del coreografo di Matrix, per una bella avventura diretta con perizia e recitata con convinzione, tratta da un romanzo di Wang Du Lu. La fotografia e la colonna sonora (con gli assoli di violoncello eseguiti da Yo-Yo Ma) fanno il resto. Indimenticabile il finale.
Grazia estetica e bravura emergono da Ying Xiong (‘Hero’), film di Zhang Yimou, del 2002. Vicenda storica di tirannia, guerra e acrobatici duelli d’arti marziali, il film — fotografato magnificamente da Cristopher Doyle — in una complessa costruzione a incastri racconta in modo del tutto fantastico la storia della Cina alla fine del “periodo dei regni combattenti” (481-221 a.C.), quando l’immenso paese era diviso in sette Stati impegnati in spietate guerre reciproche d’egemonia: un’epoca di morte e disperazione. Il re di Qin, tiranno aspramente battagliero, è ossessionato dal progetto di un immenso e possente impero unito sotto la sua sovranità; è bersaglio di costanti attentati commissionati dai suoi avversari, ma teme soltanto tre guerrieri e ha promesso immensi doni a chi li eliminerà. Ne emerge un film di grande cura, animato da un messaggio altamente cavalleresco dove, in ultimo, l’autentico eroe risulta essere colui che riesce a disarmarsi e a sostituire la pace alla guerra.
Una trilogia di nove ore complessive costituisce la fedele e riuscitissima trasposizione del romanzo-fiume di Tolkien The Lord of Rings (‘Il Signore degli Anelli’), per la regia di Peter Jackson, portata a compimento nel 2002. Molto tempo fa, nella seconda èra della Terra di Mezzo, furono forgiati diciannove grandi Anelli, ciascuno dei quali accordava lunga vita e poteri magici a chi lo portasse. Ma Sauron, l’oscuro Signore di Mordor, forgiò un Anello sovrano, amalgamando al suo oro fuso il proprio sangue e la linfa vitale. Con esso intendeva portare tutti gli altri Anelli sotto il suo dominio. Lo forgiò nelle viscere del monte Fato e su di esso pronunciò l’incantesimo che gli avrebbe conferito il potere. Ora il futuro della civiltà dipende dal destino dell’Anello, che il fato ha deposto nelle mani di un giovane hobbit di nome Frodo Baggins, che organizza — guidato dal mago Gandalf — una Compagnia (è la prima parte, ‘La Compagnia dell’Anello’) diretta verso i fuochi del monte Fato per distruggere l’Anello. Ma la Compagnia presto è costretta a dividersi (seconda parte, ‘Le due Torri’). Frodo e il suo amico Sam devono affidare le loro vite a Gollum (un ex-hobbit), se vogliono trovare la strada per Mordor. L’esercito di Saruman si avvicina e i sopravvissuti della Compagnia, insieme ai popoli e alle creature della Terra di Mezzo, si preparano alla battaglia (terza parte, ‘Il ritorno del Re’). Il difetto del romanzo, e di conseguenza del film, è una divisione manichea e troppo semplicista fra Bene e Male.
Nel 2002 Oliver Parker realizza una seconda pellicola basata su una celebre commedia di Oscar Wilde — questa volta si tratta di The Importance of Being Earnest (‘L’importanza di chiamarsi Ernest’). Dopo poco più di un secolo dalla stesura del testo (1894-1895) e di intensa vita sui palcoscenici di tutto il mondo. Ormai riconosciuta come un geniale, straordinario nonsense, anticipatore di tutte le più moderne risultanze del teatro dell’assurdo, la commedia ha una trasposizione filmica spumeggiante, fedele e convincente. È la storia di Jack Worthing, un gentiluomo inglese che vive in campagna, tutore della giovane e bella Cecily. Ma quando desidera concedersi qualche svago a Londra, si spaccia per un immaginario fratello di nome Earnest (che in inglese, come il nome proprio Franco, sta per Ernesto ma anche per persona onesta e sincera). I guai cominciano quando il suo amico Algernon, incuriosito dai racconti di Jack sulla giovane Cecily, si reca nella casa di campagna spacciandosi per il fantomatico Ernesto. Si scatena così una sarabanda di esilaranti equivoci e comici fraintendimenti. Una bella prova attoriale da parte di tutti gli interpreti, in questo film per forza di cose gustosamente teatrale.
Takeshi Kitano nel 2003 effettua una personalissima e spiazzante incursione nel cinema di genere, realizzando un film tratto dalla serie televisiva giapponese e ispirata al mondo dei samurai: Zatoichi. Lo stesso Kitano per l’occasione riveste i panni di un massaggiatore cieco maestro di arti marziali, diventato un personaggio di culto nell’emisfero asiatico: Zatoichi, per l’appunto (una sorta di Zorro). La bravura del regista giapponese era già nota da tempo, ma in questo caso si riscontra un salto di qualità dato dalla riuscitissima sceneggiatura, dall’equilibrio dell’insieme e, sopra tutto, dalla caratterizzazione memorabile e carismatica del personaggio principale. Implacabilmente divertente, come è stato giustamente detto, il film è un crescendo di calibrate e inaspettate vicende che si susseguono con estrema naturalezza, fino al gran finale che conclude egregiamente questa pellicola in cui il senso del tragico si accompagna sempre a un gusto irriverente verso l’assurdo e il grottesco. La battuta finale del film è una delle più riuscite in assoluto che il cinema abbia saputo offrire.
La semplicità di un apologo buddhista e l’essenziale bellezza di una storia che mescola tragedia e gentilezza, conoscenza delle cose umane e ascesi sono condensate in Bom Yeoreum Gaeul Gyeoul Guerigo Bom (‘Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera’) di Kim Ki-duk (2003). Il titolo si riferisce all’eterno ciclo delle stagioni e della vita, così come lo vive un monaco eremita dal ritiro del suo tempio galleggiante in mezzo a un lago in un paesaggio incantevole e fatato. Con lui, vive un bambino che, diventato grande, viene investito dalle passioni, dalla gioia, dell’ira, dal dolore e dal piacere. Le quattro stagioni raccontano altrettante fasi della crescita del bambino, che diventa ragazzo, quindi adulto, infine anziano. Una riflessione sulla caducità delle cose messa in scena con grande talento, capace di raccontare storie emotivamente complesse con immagini di una bellezza sconvolgente. Un’intensa parabola zen sul significato della vita.
Un puro godimento per l’occhio, senza tuttavia trascurare l’impianto narrativo che è avvincente e piacevole, Shi Mian Mai Fu (‘La foresta dei pugnali volanti’) (2004) di Zhang Yimou prosegue e approfondisce il percorso intrapreso con Hero. Il regista cinese mette ulteriormente a punto la sua bravura, imparando a calibrare ancora meglio gli effetti speciali e creando un racconto fascinoso e struggente. La fotografia e le coreografie (bellissima la danza iniziale) sono meravigliosi. Cina, anno 852. Per contrastare il corrotto potere centrale si formano eserciti di ribelli, e uno tra i più pericolosi è quello della ‘Casa dei Pugnali Volanti’. Due capitani preparano un piano per catturarne il leader: uno di loro, Jin, si fingerà un guerriero solitario e accompagnerà la bella rivoluzionaria cieca Mei proprio alla Casa dei pugnali volanti.
Nel 2005 il regista tunisino Nacer Khemir realizza Bab’Aziz (sottotitolo: “le prince qui contemplait son âme”), nome di un anziano derviscio che, con la sua nipotina Ishtar, attraversa il deserto per partecipare alla grande riunione dei dervisci che si tiene ogni trent'anni. Lungo il cammino incontrano diversi personaggi che rappresentano le antiche leggende e fiabe tramandate dal deserto dalla notte dei tempi. Tali racconti si intersecano l’uno dentro l’altro similmente alla trama delle Mille e una notte, che il regista ama particolarmente, al pari della poesia mistica persiana (particolarmente presente nel film). Alla forza dei messaggi veicolati, si aggiungono la suggestività delle immagini rese da inquadrature e da una fotografia avvincenti, una solida struttura della sceneggiatura (co-firmata da Tonino Guerra) e le atmosfere indimenticabili, in una genuina incursione nelle meraviglie del mondo arabo, in un esotismo genuino e calibrato. Ecco allora il ballo come liberazione, veicolo catartico e ponte verso il Divino, al pari del canto e della musica.
Ispirandosi al fortunato romanzo di Dan Brown, nel 2006 Ron Howard realizza il film The Da Vinci Code (“Il Codice Da Vinci”). Il protagonista, Robert Langdon, è un avventuriero con la giacca da professore universitario. Tutta la vicenda è incentrata sul rapporto che legherebbe Maria Maddalena, la Francia e il SANGREAL tramite l’ordine del “Priorato di Sion”, visto come il custode della discendenza di Gesù e della Maddalena, attraverso la loro presunta figlia Sara. Il film ha un cast di alto profilo (fra gli altri Tom Hanks, Ian McKellen, Jean Reno), locations prestigiosissime (prima fra tutte il Louvre), ricostruzioni meticolosissime, ambientazioni di grande fascino. Nonostante l’apparato fantasioso che sta alla base del romanzo di Dan Brown, questa pellicola scuote le fondamenta — sempre più fragili — della chiesa cristiana. Ed è, inoltre, un vibrante omaggio al femminino, che sempre più cerca di prendere la sua rivincita dopo millenni di maschilismo imperante.
Un buon esempio di pellicola che affronta l’argomento della morte in modo olistico senza troppe concessioni alla new-age, è il film The Fountain (“L’albero della vita”) diretto da Aron Aronofsky. Il protagonista, Thomas Creo, è un ricercatore in una clinica di studio del cancro al cervello. La sua ricerca ha una motivazione universale per la medicina, ma anche personale: la moglie malata. In continua lotta e relazione con la tematica della morte, la storia mescola realtà e fantasia psichedelica incrociando in maniera quasi speculare il romanzo scritto dalla moglie, l'ego razionale dello scienziato e la dura realtà. In un contesto dove la trama principale perde d'importanza nel prosieguo della vicenda, il personaggio del protagonista si scinde in tre per affrontare le sue sfide (per poi riunirsi nuovamente in uno): il romantico ‘conquistador’, partorito dal libro della moglie, pronto a sacrificare tutto e tutti per salvare la sua amata; lo yogi dedito alla ricerca della mitica bevanda dell’immortalità; il medico intenzionato a scoprire un rimedio contro il cancro. Questi tre si affrontano e si confrontano all'ombra dell'Albero della Vita: la mitica pianta opposta all'Albero della Conoscenza, di cui narrano le più antiche leggende mondiali. Durante il percorso, Thomas arriverà a comprendere che una eventuale vittoria sulla morte non va cercata come un desiderio morboso di un prolungamento dell’attuale (limitatissima) esistenza umana, ma va inserita in un contesto assai più ampio che riguarda il grande progetto di Madre Natura.
La visione futuristica ispirata a un celebre fumetto dalla trama spiccatamente eversiva di Alan Moore (illustrato da David Lloyd e pubblicato fra il 1982 e il 1985), è offerta dal film diretto nel 2006 da James McTeigue e intitolato V for Vendetta (‘V per Vendetta’). La sceneggiatura è realizzata dai fratelli Wachowski (prima di Matrix). In una futuristica e distopica Gran Bretagna, dominata da un regime totalitario (un partito unico di estrema destra che ha preso il potere eliminando il dissenso e le minoranze, costruendo campi di concentramento e operando un controllo totale delle attività dei cittadini — richiamando così il 1984 di Orwell), una giovane, Evey, viene salvata da un uomo, conosciuto come ‘V’, che cela il proprio volto dietro una maschera di Guy Fawkes, il protagonista della fallita “cospirazione della polvere da sparo” del 1605. Un detective conduce, nel corso della sua indagine, una caccia spietata per catturare V prima che faccia scoppiare una rivoluzione. Rispetto al testo di origine, il film propone diverse differenze; in particolare è stato aggiornato il contesto politico per renderlo più aderente alla situazione del primo decennio del XXI secolo. In entrambi i casi, sia pur con differenze talvolta rilevanti, la tematica mostra quali siano le conseguenze quando un popolo decide di barattare la propria libertà e i propri diritti in cambio di un presunto senso di sicurezza.
Nel 2007 esce Man cheng jin dai huang jin jia (‘La città proibita’ o, traducendo più letteralmente il titolo cinese, ‘La maledizione dei fiori d’oro’) di Zhang Yimou. Ambientato nella Cina della tarda dinastia Tang (decimo secolo), il film principia con il ritorno inaspettato dell’imperatore insieme al principe Jai, il suo secondogenito, alla vigilia delle festività del Chong Yang. La ragione ufficiale del rientro improvviso è quella di celebrare la festività con la famiglia, ma considerando i rapporti freddi che intercorrono tra lui e la sofferente imperatrice, questa sembra soltanto una scusa. Tra lo sfarzo e l’imponenza delle celebrazioni, vengono a galla dei terribili segreti. Mentre la famiglia imperiale continua nella sua elaborata sciarada all’interno di questa magnifica ambientazione, migliaia di guerrieri dall’armatura dorata attaccano il palazzo. Chi c’è dietro a questa terribile ribellione? In una notte illuminata dalla luna, migliaia di crisantemi vengono calpestati, mentre il sangue sgorga nel palazzo imperiale. In un tripudio di ori, questo bel film dal gusto estetico fortemente orientale (che taluni occidentali giudicano kitch) è, tra le altre cose, la benvenuta ripresa della collaborazione fra il regista e la grande attrice Gong Li, che qui interpreta con la sua consueta intensità il ruolo della bellissima e sventurata imperatrice.
Il regista bhutanese Neten Chokling nel 2007 dirige con gusto e sapienza visiva un film riguardante la prima parte della vita del mistico tibetano Milarepa. Si narra di come il proprio padre morì quando egli aveva sette anni e, da quel momento, tutte le proprietà di famiglia caddero sotto il controllo degli avidi zii, che trattano Mila e la madre come schiavi. Il giovane Mila, spinto dalla madre, decise quindi di apprendere le arti magiche e, sotto la guida di lama Yongtun Trogyal, ne apprese rapidamente i segreti, che gli permisero di evocare spiriti maligni che apportarono svariate catastrofi e condussero alla rovina il villaggio dove gli zii vivevano. Qui si conclude il film, ma il regista ha in progetto di realizzare il sequel, incentrato sulla seconda parte della vita di Marpa, ove il suo maestro, vedendo con orrore quali effetti il proprio insegnamento avesse causato, inviò Marpa da lama Lotsawa che, per sei anni, lo sottopose a fatiche che misero a dura prova il suo stesso corpo (gli fu ad esempio ordinato di costruire e distruggere ripetutamente una torre di nove piani — l’ultima costruzione della quale svetta tuttora in Tibet). Esauritosi il karma negativo, Marpa poté finalmente iniziare una vita di meditazione e, ritiratosi per un anno nelle caverne d’alta montagna, raggiunse la completa illuminazione; al suo ritorno raccolse un gruppo di ventuno discepoli, a otto dei quali impartì uno degli insegnamenti ricevuti dal suo maestro Naropa. A Mila venne trasmesso il potere del fuoco interiore che consente di non usare vesti di lana: da quel giorno gli fu dato il soprannome di repa (“vestito di tela”) e divenne il Milarepa a noi noto. La sua fama si diffuse mentre egli era ancora in vita e molta gente iniziò a cercarlo per ascoltare i sublimi canti per mezzo dei quali esprimeva la propri realizzazione. Continuò a condurre una vita molto semplice e lasciò il corpo all’età di 84 anni, nel 1135 d.C.
Un altro colossale film cinese, questa volta del regista John Woo, dal titolo Chi bi (‘La battaglia dei tre regni’) è stato realizzato nel 2008 con perizia davvero titanica. Basato sul romanzo di Luo Guanzhong, scritto nel XIV secolo, il film è ambientato durante l’era dei tre regni nell’antica Cina e racconta la storica battaglia di Red Cliffs, dove avvenne la leggendaria vittoria di cinquemila guerrieri contro un esercito di un milione di soldati. Un film mozzafiato con scene di rara maestria, tutto giocato sull’astuzia di uno stratega che riesce a sconfiggere un potentissimo esercito con la forza della propria paziente e lucida sagacia. Unico neo: l’eccessiva lunghezza della narrazione filmica, che ha portato i distributori occidentali a dividerlo in due parti.
Sappiamo ormai quanto il regista Oliver Parker ami l’arte di Oscar Wilde. C’era quindi da aspettarsi una trasposizione del romanzo più celebre di questo raffinatissimo scrittore inglese:Il ritratto di Dorian Gray. Nel 2009 nasce così il film Dorian Gray, con atmosfere barocche e una lieve rilettura in chiave horror. Lord Henry Watton (Colin Firth) plagia il bellissimo Dorian Gray (Ben Barnes) e lo inizia al culto del piacere. L’amico di Henry, il pittore Basil Hallward (Ben Chaplin), dipinge un ritratto di Dorian che cattura appieno la sua straordinaria avvenenza. E Dorian, a quel punto, esprime un desiderio: vorrebbe che a invecchiare al suo posto fosse il ritratto. Sorprendentemente, il patto con il diavolo si realizza e il quadro porta i segni della progressiva decadenza fisica e morale di Dorian, il quale uccide chiunque tenti di persuaderlo a cambiare. Ma sarà proprio il quadro a trascinare l’eterno giovane verso la sua condanna.
La cinematografia cinese si impone ormai sul panorama internazionale, producendo imponenti ricostruzioni storiche. Su questa corrente, la regista Mei Hu realizza il film Kunfutzu (‘Confucio’), nel 2009, anno in cui si celebra il 60° anniversario della repubblica popolare cinese e, insieme, il 2560° anniversario della nascita dell’omonimo filosofo e politico. Di umili origini (la famiglia era nobile ma caduta in povertà), Confucio giunge a ricoprire, per un certo periodo, la carica di Ministro della Giustizia del ducato di Lu e si impone in seguito come maestro di saggezza. I suoi discepoli raccolgono le sue massime (aforismi e frammenti di discorsi) in un libro famosissimo — i Dialoghi — che ancora oggi esercita un certo influsso in Estremo Oriente (Cina, Corea, Giappone, Vietnam). Il film unisce la cura delle riprese (bellezza delle ambientazioni, recitazione convincente, montaggio efficace) a una sceneggiatura tesa a mettere in risalto il valore morale e umano di un uomo vissuto in un’epoca di grande instabilità politica e di forte corruzione sociale, dominata da guerre tra stati feudali.
Gli ultimi tre anni della breve vita del poeta inglese John Keats (morto di tisi a soli 25 anni, nel 1821), vengono raccontati con sensibilità e delicatezza da Jane Campion nel film Brigh Star. Il titolo allude all’incipit di una poesia dello stesso Keats, dedicata a Fanny Brawne, sua musa ispiratrice e suo unico amore. Ne scaturisce un film che è una dichiarazione d’amore alla poesia e che tenta di iniziare lo spettatore al godimento di quest’arte ancora così poco frequentata e compresa. La scommessa non era certo vinta in partenza: la vita di questo ispirato poeta romantico, così breve e spoglia di eventi, si è celebrata (come nel caso della maggior parte dei poeti) tutta nell’intimo, in quella sfera interiore nella quale ogni vero poeta ama immergersi e, se possibile, trarre in superficie quante più perle di bellezza gli risulta possibile. Il film si dipana perciò fra la passione d’amore e la contemplazione della bellezza della campagna inglese da parte di Keats, per concludersi in Italia (a Roma) dove il poeta — recatosi per cercare un sia pur fuggevole sollievo alla sua malattia — trova la morte.