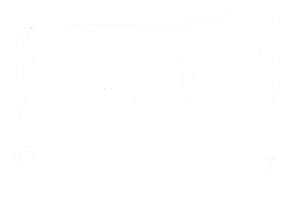LA RIDUZIONE DEL “TEMPO”
A OGGETTO DI BANALITÀ
di Lucio Garofalo
«La durata delle cose, misurata a periodi, specialmente secondo il corso apparente del sole»: questa è la definizione generica del concetto di “tempo” fornita da un comune dizionario della lingua italiana. Eppure, proprio attorno a tale categoria e ai suoi molteplici significati (di ordine storico, filosofico, o di natura astronomica), si è come addensata una coltre di fumo accecante, densa di luoghi comuni e di rozze ovvietà, che sono persuasioni assai diffuse nella vita quotidiana di noi tutti.
Gli stereotipi sul “tempo” paiono proliferare senza soluzione di continuità, e quasi tutti, eccezion fatta per quei fenomenali campioni della lingua e del sapere umano, se ne servono abitualmente, forse inavvertitamente, magari per riempire il vuoto raccapricciante di certe conversazioni, in altre parole per coprire i "tempi morti" della nostra esistenza. Sovente infatti, ci capita di ascoltare asserzioni totalmente insensate, che farebbero inorridire le nostre menti qualora fossimo soltanto un po' più attenti e riflessivi, meno pigri o distratti. “Ammazzare il tempo”, tanto per citare uno dei casi più dozzinali, è un modo di dire quantomeno sciocco perché non significa nulla se non che si uccide la propria esistenza. La persona che “ammazza il tempo”, cioè che impiega malamente il proprio tempo vitale, non sapendo cosa fare, non avendo interessi gratificanti, né occupazioni di tipo mentale (come leggere e scrivere) o di carattere fisico (come gli sport), tali da motivare il vivere quotidiano, non coltivando passioni che potrebbero impreziosire la qualità del proprio tempo esistenziale, finisce (appunto) per annichilire se stessa, divenendo un essere ansioso, depresso, accidioso, ma non ozioso. Invero, l’“otium” dei latini (che per il cristianesimo più bigotto, influenzato dallo stoicismo più volgare, rappresenta il "padre dei vizi": infatti, l'accidia è compresa tra i “vizi capitali” osteggiati dalla tradizione giudaico-cristiana), che era l’ideale di vita proprio della cultura classica greco-romana (ispirata, invece, da una concezione epicurea, nutrita da orientamenti filosofico-esistenziali che privilegiavano la ricerca della felicità e del piacere quali finalità supreme da perseguire in quanto capaci di liberare l'intrinseca natura dell'uomo ), era ed è la condizione dell'individuo privilegiato, del ricco padrone di schiavi, padrone della propria e dell’altrui vita, della persona che non è costretta a lavorare per sopravvivere, che non deve travagliare e può dunque sottrarsi alle fatiche materiali necessarie al procacciamento del vitto e dell'alloggio, non ha bisogno di stancarsi fisicamente perché c'è chi si affanna per lui, e può dunque godersi le bellezze, il lusso e quanto di piacevole la vita può offrire. L’“otium”, in altre parole, è il modus vivendi del padrone aristocratico, del patrizio romano, del parassita sfruttatore del lavoro servile, che non fa nulla ed ha a sua disposizione tutto il tempo per poterlo occupare nella “bella vita”, ovvero in un'esistenza amabile e gaudente per sé, quanto detestabile e dolorosa per i miseri che nulla posseggono, neanche il proprio tempo, sprecato per ingrassare e servire i propri simili! Tutto ciò è vero, purtroppo. È vero, infatti, che non tutti detengono il privilegio o la fortuna (che dir si voglia) di disporre di tanto tempo libero da spendere in diverse e divertenti attività (la radice etimologica dei vocaboli “diverso” e “divertente”, è la medesima: entrambi derivano dal latino “di-vertere” che sta per “deviare”, ossia “variare”). Anzi, la grande maggioranza degli individui sulla Terra, ancora oggi è costretta a travagliare, a patire, a lavorare per sopravvivere, chi cacciando e vivendo primitivamente, chi coltivando la terra, chi sprecando otto, nove ore a sgobbare in fabbrica, o ad annoiarsi in ufficio, chi occupandosi inutilmente di “affari”, ossia di faccende non gratificanti ma stressanti e frustranti, al solo scopo di lucrare, ingrassare, accumulare denaro. È d'uopo invece comprendere che il tempo (quello vitale) degli individui, dell'esistenza quotidiana di ciascuno di noi, rappresenta una risorsa di valore inestimabile, non sul piano materiale, o venale (un altro detestabile luogo comune recita: “il tempo è denaro”, ed è abitualmente pronunciato dai cosiddetti “uomini di affari”, i signori del denaro e della finanza, i paperon de’ paperoni, ovvero i parassiti e i nullafacenti della società odierna, gli arrivisti e i carrieristi, gli approfittatori dell'altrui tempo, dell’altrui denaro e dell'altrui ingenuità, gli sfruttatori del lavoro sociale e dell’esistenza dei più miserabili), bensì da un punto di vista estetico-spirituale, che comprende la sfera del piacere, della bellezza, del godimento, dell'intelligenza, della cultura, dell'arte, dell'amore, della fantasia, cioè la dimensione creativa, ludica, libidinosa, della vita.
Il tempo, nella maggioranza delle esistenze individuali, viene sprecato e speso male, se non malissimo, cioè viene ammazzato e svuotato di ogni senso proprio, sicché è la propria vita ad essere abbruttita, e la persona umana si sente avvilita, inutile, quasi disperata, priva di stimoli, di entusiasmo, di voglia di vivere. Il “tempo”, nella fattispecie quello climatico, è frequentemente citato quale insulso e comodo oggetto di conversazione, nel desolante vuoto dell'alienazione moderna, quando con sgomento si scopre di non sapere cosa dire con un interlocutore qualsiasi o con un compagno d'occasione, o magari con una personalità, la cui ingombrante presenza ci imbarazza e ci infonde soggezione. Oppure quando ci si sente mentalmente affaticati e non si è in grado di elaborare idee originali, o perché non si è molto abili o educati all’arte della conversazione. Il “tempo atmosferico”, come tema di dialogo, risulta perciò una sorta di via di scampo dall’imbarazzo, dalla stanchezza e dal precipizio dell’incomunicabilità, dalla povertà intellettuale, ma in realtà conduce all'abisso della noia, allo squallore dell'ipocrisia e dell'ignoranza più becera. Frasi trite e ritrite del tipo “che tempo fa oggi?” o “il tempo minaccia...” ecc., talvolta sono spie inequivocabili che tradiscono la soggezione emotiva, la goffaggine personale, l'incapacità di comunicare, il conformismo esistenziale e culturale, oppure indicano atteggiamenti di astuzia, di falsità, di temporeggiamento, cioè nascondono il desiderio di indugiare oltre e guadagnar tempo (appunto!), magari perché si tenta di approfittare di qualcosa o di qualcuno. Da questo punto di vista, i luoghi comuni e le convenzioni sul "tempo", inteso nella più comune accezione meteorologica, si sprecano a dismisura, e quel concetto, tanto nobile e complesso, finisce per essere involgarito e banalizzato come in nessun altro caso, al solo fine di camuffare un pauroso vuoto di idee, per dissimulare propositi malvagi, per mascherare, in modo maldestro, emozioni e stati d’animo che sono spesso indice di vulnerabilità.
Dietro il facile espediente del “tempo” quale argomento di ordinaria conversazione, sovente si annidano secondi fini o cattive intenzioni, oppure motivi di timidezza ed ingenuità, magari anche un'indolenza mentale, un’abitudine al conformismo, una carenza di idee originali, uno stato di profonda immaturità culturale. Si potrebbe ironicamente osservare che, in questi casi, il “tempo” (vale a dire il “clima”, quale banalissimo oggetto di conversazione) può annebbiare la mente e ottenebrare lo spirito, nella misura in cui ci si abitua (sciaguratamente) alla più deteriore condizione esistenziale, ossia alla pigrizia intellettuale, che è l'esatto contrario dell’“otium” di cui si è già spiegato il senso vero e più nobile, che non è sfaccendare o non fare nulla (ossia oziare nel senso capitalistico-borghese di non esercitare “negotium”, che è l’attività per accumulare denaro, intraprendere imprese lucrose, e via discorrendo). L’“otium” non è propriamente lo stato del fannullone, quantunque si sia già spiegato chiaramente che esso rappresenta una condizione privilegiata, appartenente ad un'élite aristocratico-classista che non deve fronteggiare le difficoltà quotidiane della sopravvivenza materiale. In un certo senso, l’“otium” (in quanto negazione del “negotium”) è una virtù, un talento, che presuppone diverse qualità creative, anzitutto la capacità di impiegare il proprio tempo libero realmente disponibile, per migliorare e valorizzare progressivamente la qualità della propria esistenza, grazie ad una serie di impegni qualificanti quali la lettura di bei libri, la visione di bei film, l’ascolto di buona musica, l’amore (in tutte le sue dimensioni, compresa quella carnale), le buone amicizie, la buona gastronomia, le belle arti, il godimento delle bellezze naturali e di ogni altra gioia che la vita è in grado di offrirci, soltanto se lo volessimo, solamente se sapessimo organizzare il nostro tempo e se davvero ne avessimo la possibilità! In altri termini, non è per nulla banale pensare al “tempo” come al principio essenziale che riesce a conferire un senso alla nostra esistenza, individuale e collettiva, in qualità di singole persone e di genere umano.
Il “tempo” è stato e può essere concepito (nella storia del pensiero filosofico) in quanto “durata”, “successione”, in maniera “lineare” o “circolare”, come “finito” o “infinito”, “assoluto” oppure “relativo”, “oggettivo” e “soggettivo”, “unico” o “molteplice”, e via discorrendo, ma una cosa è certa: senza il “tempo” , non esisterebbe nulla. Difatti, se non ci fosse ciò che definiamo “tempo” o, per meglio dire, se noi non tenessimo più conto del flusso del tempo, dell'esperienza vissuta, dei cicli stagionali, della nascita e del tramonto solari, dell'età che avanza inesorabilmente, insomma se noi vivessimo a prescindere dal “tempo”, se noi fossimo ad esempio immortali, molto probabilmente non sapremmo che fare, ci annoieremmo a morte, non potremmo e non sapremmo affatto apprezzare i veri ed essenziali valori della vita e del mondo, dunque saremmo condannati ad un cieco destino senza fine.
Immaginiamo, per un momento, che la Terra fosse circondata da una sorta di gigantesco guscio astronomico che oscurasse il Sole, impedendo così la nostra percezione del divenire e dello scorrere del tempo, che fine faremmo? Oppure, cosa accadrebbe se, per ipotesi, noi abolissimo tutti gli orologi, i pendoli, le clessidre, i calendari ed ogni strumento di misurazione temporale (per quanto relativa, storica e terrestre possa essere, secondo la teoria einsteiniana della “relatività” del “tempo oggettivo”, matematicamente misurabile)? Probabilmente, non ci sarebbe progresso e noi non avremmo mai potuto realizzare tutto quanto l'umanità ha saputo compiere : l'invenzione della scrittura; la scoperta del fuoco e dell'agricoltura; la lavorazione dei metalli; la costruzione delle piramidi in Egitto, del Partenone, del Colosseo, dei grattacieli; l'invenzione dell'energia elettrica e dei calcolatori elettronici; la scoperta della matematica; la creazione di immensi capolavori nella pittura, nella scultura, nella poesia, nella musica, nel romanzo, nel teatro, nel cinema (perché no, anche nel fumetto) ecc. ecc.; l'invenzione della ruota , del motore a scoppio, dei sottomarini, degli aerei supersonici, delle astronavi spaziali, dei satelliti artificiali; l'invenzione del telegrafo, del telefono, della radio, della televisione, del fax, della trasmissione via Internet, di tutti quegli elettrodomestici che hanno alleviato e reso più comodo l'impegno quotidiano delle massaie e delle casalinghe (svolto sempre più anche dagli uomini); la scoperta dell'America, l'esplorazione degli oceani e degli spazi interstellari; la scoperta della penicillina e degli antibiotici, l'invenzione dei vaccini immunizzanti e tutti i grandi, preziosi sviluppi avvenuti nel campo medico-sanitario (legati non solo alla medicina farmacologica occidentale, ma anche ad altre scuole di medicina, di matrice orientale, in particolare quella araba, quella cinese e quella indiana); e così via, l'elenco non avrebbe termine. In altre parole, non esisterebbe alcuna traccia di civiltà, di cultura, di intelligenza dell'uomo, e non vi sarebbe alcun segno della nostra stessa presenza sulla Terra. Perciò, grazie di esistere al “tempo” (a ciò che convenzionalmente definiamo tale), alla vita ed alla morte, nella misura in cui senza la morte, ovvero senza il “tempo”, non potrebbe esserci nemmeno la vita, e noi non sapremmo riconoscere ed apprezzare i valori, i beni, le bellezze e le gioie che l'esistenza medesima è in grado di offrirci, proprio in virtù del fatto che possiamo e sappiamo riconoscere e disprezzare il male, la violenza, l'ingiustizia, la malvagità, il dolore, la morte.
Da quanto detto può discendere un'estrema (ma non conclusiva) valutazione. Ciò che conta veramente, non è tanto la durata, ossia la quantità del nostro tempo vissuto, bensì la sua qualità. A riguardo, mi sovviene un altro, diffusissimo luogo comune, il quale si può tradurre nella seguente formula: “Ho cinquanta anni, ma me ne sento venti”. In verità, potrebbe essere l'esatto contrario: “Ho venti anni, ma ne sento cinquanta”. Forse, la soluzione del dilemma risiede (banalmente?) nel mezzo, nel senso che le risposte ad ogni domanda dell'esistenza, richiedono una sintesi tra due opposti estremi, per sanarne le contraddizioni, anche per ricomporre le più irriducibili fra le antitesi. Questo ragionamento (di matrice hegeliana) ha sicuramente senso, quantomeno per il quesito posto in precedenza. Voglio dire che, indubbiamente, l'età anagrafica esiste, nella misura in cui il tempo scorre ed avanza in modo implacabile. Ma è altrettanto innegabile che non sempre l'età mentale e soggettiva (cioè il tempo interiore, qualitativo) corrisponde all'età anagrafica, vale a dire al tempo cronologico, esteriore, oggettivo, assoluto, matematicamente misurabile. Ed è altresì vero che tutto ciò che ha a che fare col “tempo”, è assolutamente relativo, personale, transitorio e mutevole, nel senso che io potrei avere (anagraficamente parlando) trent'anni e sentirmene, in un dato momento, appena diciotto, mentre in un altro contesto o in un altro frangente addirittura settanta. Tutto è assolutamente relativo e storicizzabile, soprattutto il “tempo”. Ciò che appare oggettivo e reale, può diventare soggettivo, grazie al “tempo”, ed è sempre il “tempo” che rende finito e mortale ciò che appare o crediamo infinito ed immortale, e viceversa.
Il “tempo” costituisce, dunque, la misura del valore che ha la nostra esistenza. Tuttavia, il “tempo”, quantunque possa apparire un problema oltremodo astratto e cerebrale, quasi incomprensibile per certi versi (pensiamo, ad esempio, all'analisi heideggeriana di “Essere e tempo”), non può assolutamente essere banalizzato, perché rischieremmo di banalizzare la nostra stessa esistenza, il che vuol dire rischiare di vivere inconsciamente, ciecamente, banalmente.
Maggio 2005