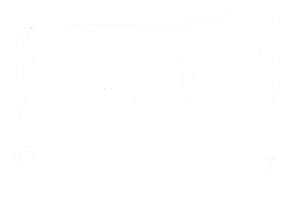Ramalingam
di Enriqueta Lucares Rojas
Ramalingam è un personaggio nato e vissuto — in pieno XIX secolo — in quel Tamil Nadu che abbonda di poeti-mistici dotati di una sorprendente conoscenza dei processi che governano il corpo fisico (basti pensare alla millenaria tradizione Siddha, composta da yogi molto avanzati in grado, pare, di dissolvere il loro corpo nella Luce).
Ramalingam è una personalità di maturazione assai precoce. Sebbene non si mostrò mai interessato a ricevere insegnamenti d’alcun tipo (il fratello maggiore era un ‘pandit’ che si guadagnava da vivere predicando, e per anni si ostinò invano nel tentativo di istruirlo), all’età di quindici anni aveva già attorno a lui alcuni discepoli, a causa delle esperienze spirituali che ebbe fin dalla più giovane età, come ci ricorda egli stesso in alcune sue liriche.
O Luce in sé effulgente, fiamma splendida
centro dell’universo, a nove anni
tu m’accogliesti in Te e nel tuo Regno,
dandomene le chiavi, sicché persi
in Te ogni bisogno di sapere
In un’altra poesia, accenna a un viaggio al grande tempio di Shiva Nataraja a Cidambaram:
Quando in tenera età, con la mia mamma
venni da Te a Cidambaram e il velo
scostandosi scoprì lo spazio vuoto,
Tu, Signore, mia gioia, i tuoi misteri
mi mostrasti, rendendomi maturo
prima che il seme si formasse in frutto.
Ramalingam possedeva inoltre una ipersensibilità davvero particolare —
Guardare il derelitto mendicare
di porta in porta inutilmente, fino
a che affamato lo vinceva il sonno,
mi riempiva d’angoscia. E ancora tremo
solo alla vista di chi porta i segni
d’atroci malattie. Chi, denutrito,
nulla chiedeva perché troppo fiero,
mi lacerava il cuore. O Bene eccelso,
o Dio splendente dell’etereo spazio,
quando sento parlare della fame
che spegne le creature, uno sgomento
m’assale, come un fuoco nella mente,
improvviso e il mio cuore ha un sussulto.
Quando le voci della gente s’alzano
nell’aspro alterco, le mie fibre soffrono.
Un bussare frenetico alla porta
mi percuote alle tempie. Tu sai bene,
che quando sento levarsi un lamento,
Signore, come ‘padre!’, ‘madre!’, ‘ahimè!’,
queste parole dentro mi devastano
come il ciclone che ogni cosa sradica.
Che io diventi pura compassione,
concedimelo, Signore e aiutami
a edificare un mondo senza morte.
Ed è proprio questa sua profonda ritrazione — per nulla riferita a se stesso — nei confronti della malattia, della sofferenza, della morte, l’elemento che lo spingerà a cercare un rimedio che non sia una evasione in un qualche Nirvana liberatorio. All’età di dodici anni un processo piuttosto radicale iniziò in lui — una profonda palingenesi interiore ed esteriore che lo triturò per quasi quarant’anni:
Ciò che dai dodici anni ho subito
basterebbe, o Signore, a far crollare
un’intera montagna e farne polvere.
Il destino serbato a questo misero,
dai dodici anni fino a questo giorno,
fonderebbe l’acciaio temperato.
Le energie e gli organi sottili del suo corpo subirono una progressiva trasformazione, giungendo parzialmente a modificare anche qualcosa della sostanza più materiale. Presto si iniziò a parlare di lui come dello “swami dal corpo d’oro” (sebbene egli aborrisse qualunque titolo onorifico, e quando qualcuno gli fece una statua onorifica lui la guardò e disse: «così il corpo d’oro è diventato un corpo di creta») a causa della luce che avvolgeva la sua forma fisica. Anche le dipendenze dai bisogni corporali si assottigliarono sempre più. I suoi discepoli dicevano che inizialmente egli dormiva tre ore per notte, poi due, quindi una sola ora; infine, negli ultimi tempi, pare che non dormisse affatto. Mangiava pochissimo; dapprima due volte al giorno, in modo frugale, poi una volta sola; nella maturità mangiava soltanto qualche boccone di cibo ogni due o tre giorni (talvolta restando per mesi senza mangiare, bevendo unicamente acqua zuccherata). E, nonostante si dica che vennero compiuti otto diversi tentativi, nessuno è mai riuscito a fotografarlo (tutto ciò che risultava dalle lastre era un’ombra vaga sotto la veste bianca). Il suo sguardo, per quanto dolce e pieno di compassione, era di un’intensità insostenibile, tanto che egli si asteneva dal guardare gli uomini negli occhi, cosa che ne aveva lasciati alcuni in trance per giorni. Predicava la compassione verso tutti gli esseri viventi e l’offerta di sé al Signore Supremo; attraverso la compassione e il dono di sé, egli sosteneva, il Signore avrebbe «preso in sé la nostra natura sostituendola con la propria», fatta di «conoscenza perfetta e di vita immortale»; l’essere umano in questa palingenesi avrebbe assunto tutti i caratteri divini, compreso «un corpo fisico indistruttibile e immortale». Per la precisione, tre sono i corpi divinizzati o divini cui Ramalingam fa riferimento nelle sue opere: un corpo fisico purificato (shuddha deha), un corpo sottile universalizzato (pranava deha) e un corpo della conoscenza causale (jñana deha).
Di tutte le sue composizioni poetiche, la massima espressione è costituita da un poemetto diviso in cinque canti per un totale di 1.576 distici (3.192 versi), intitolato Jyothi Agaval e composto in una sola notte, il 18 aprile 1872. In esso, Ramalingam descrive, con un linguaggio poetico estremamente sintetico e intuitivo, alcune delle sue esperienze (in particolare nel quinto e ultimo canto, che inizia dal verso 1.449). Eccone qualche estratto:
Vasta luce di Grazia, manifesta
nella Distesa della Conoscenza
ove risiede la suprema scienza
dell’immortalità del corpo fisico.
Vasta Luce di Grazia, per tua gioia
m’hai dato un corpo divino incarnato
della sillaba OM, allontanando
da me ogni afflizione e malattia.
Vasta Luce di Grazia, hai sigillato
i sentieri da cui la morte passa,
per me, quaggiù sulla terra, donandomi
modo di rendere il corpo immortale.
Vasta Luce di Grazia, m’hai parlato
dicendo: «Questo è lo stato immortale
del corpo fisico concesso a te;
prospera adesso, prospera per sempre».
Il poema prosegue descrivendo l’azione trasmutatrice della Luce di Grazia nelle ossa, nel sangue, nel liquido seminale, nel cervello. L’ambrosia divina (amrita) penetra dall’alto e fluisce in tutto il corpo, impregnandolo per intero.
Il 30 gennaio 1874, Ramalingam — cinquantenne — diede un ultimo saluto ai suoi discepoli, dopodiché si diresse nella sua stanza e si chiuse dentro, ordinando di chiavare il lucchetto esterno e di non disturbarlo più.
La notizia presto si diffuse, anche perché qualche tempo prima egli aveva detto di trovarsi alle soglie di una suprema trasformazione. «Ora sono in questo corpo», aveva detto in modo enigmatico, «presto entrerò in tutti i corpi». Molte persone gli credevano, convinte che la sua esistenza terrena fosse giunta a qualche misteriosa svolta. Egli aveva detto di avere raggiunto la liberazione fisica dalla morte, dalla malattia, dalla fame, dal sonno e dal dolore. Negli ultimi tempi non mangiava e non dormiva più e i miracoli che gli erano attribuiti (compreso un caso di resuscitazione della vittima di un incidente davanti a una folla di persone), erano ormai leggenda.
Tre mesi dopo, la notizia giunse alle autorità di Madras. Due funzionari inglesi dell’Indian Civil Service furono inviati a investigare. Imposero di aprire la serratura della camera, ma la stanza fu trovata vuota. I due ufficiali britannici la ispezionarono a dovere. Interrogarono i discepoli presenti che sembrarono loro persone semplici, incapaci di dire bugie o di fare del male. Donarono venti rupie per i poveri che, seguendo le istruzioni di Ramalingam, venivano nutriti nei paraggi e fecero ritorno a Madras.
Questa è la cronaca della scomparsa di Ramalingam.