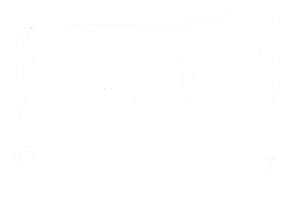MAFIA
“Mafia” è un termine diffuso ormai a livello mondiale con cui ci si riferisce a una particolare tipologia di organizzazioni criminali.
Il termine mafia venne inizialmente utilizzato per indicare una organizzazione criminale originaria della Sicilia, più precisamente definita come ‘cosa nostra’ (o, talvolta, ‘stidda’). In Campania si chiama ‘camorra’; ‘camorra barese’ in Puglia (o ‘sacra corona unita’, o ‘società foggiana’); ‘’ndrangheta’ in Calabria; ‘rancitelli’ in Abruzzo.
Ma la parola “mafia” assunse presto la valenza di termine generico che raggruppa le varie organizzazioni criminali operanti su fondamenti similari, comprese alcune organizzazioni malavitose come la ‘mala del brenta’ (in Veneto), ‘la banda della magliana’ (a Roma), i ‘basilischi’ in Basilicata (Potenza, Matera, Policoro) e, nel mondo, la mafia russa, la mafia cinese, la mafia giapponese (o ‘yakuza’), eccetera.
La mafia adotta comportamenti basati su un modello di economia statale, ma è parallela e sotterranea. L’organizzazione mafiosa trae profitti da numerosi tipi di attività criminali: traffico d’armi, contraffazione, contrabbando di sigarette tabacchi e altre merci, traffico di stupefacenti, droghe pesanti e leggere, traffico di profughi clandestini, gioco d’azzardo, prostituzione, sequestri di persona, racket delle estorsioni (pizzo), furti, appalti truccati, traffico di scafi, frodi agricole ai danni dell’UE e dell’AIMA, frodi telematiche (false carte sim), usura, abusivismo edilizio, traffico dei rifiuti (anche tossici), voto di scambio.
I capimafia (spesso a causa della latitanza) comunicano principalmente in modo scritto, con i ‘pizzini’, poiché non sempre sono in grado di comunicare di persona a tutti i loro sottoposti (capifamiglia, picciotti).
Uno dei capi-mafia più temibili dei nostri tempi è Salvatore Riina, meglio conosciuto come Totò Riina (Corleone, 16 novembre 1930), componente dei vertici di ‘cosa nostra’, detenuto dal 1993. Veniva chiamato anche “Zù Totò” oppure “Totò u Curtu”, per via della sua bassa statura (158 cm).
Insieme a Luciano Liggio e a Bernardo Provenzano, detto “Binnu u’ tratturi”, il giovane Riina iniziò col porsi al servizio di Michele Navarra, capomafia di Corleone. Successivamente, assetati di potere, decisero di eliminare Navarra per ottenere il predominio nel paese. Michele Navarra fu assassinato dai sicari di Liggio (2 agosto 1958) che assunse la guida del clan corleonese. Riina, Provenzano e Bagarella presero ad assassinare coloro che erano stati fedeli a Navarra (i cosiddetti “navarriani”). Intorno alla prima metà degli anni ’60, Riina, Liggio e Provenzano diedero inizio alla scalata criminale al potere di Palermo, dove contavano sull’appoggio dell’allora assessore Vito Ciancimino, pure lui di Corleone. Grazie a lui fecero un patto con Salvatore La Barbera per il controllo del mercato della carne e il traffico di sigarette. Liggio lasciò Riina e Provenzano a gestire gli affari a Palermo e si nascose a Corleone. Ma La Barbera venne rapito e ucciso dal boss mafioso Michele Cavataio che con l’inganno fece credere che il rapimento fosse opera della famiglia mafiosa dei Greco di Ciaculli e da lì scoppiò la cosiddetta “prima guerra di mafia”. I componenti del clan La Barbera fuggirono dal capoluogo siciliano e così fece Riina, che fu arrestato nel 1963: una notte, mentre si trovava in una stazione di servizio a Palermo, una pattuglia di Polizia gli chiese di favorire la patente e il libretto. Riina, che aveva una carta d’identità falsa e una pistola non regolarmente dichiarata, tentò di scappare ma venne braccato facilmente dalle forze dell'ordine.
Tuttavia, dopo aver scontato alcuni anni di carcere (dove conobbe Gaspare Mutolo), fu assolto nei due processi a suo carico — a causa delle forti minacce che ricevettero i giudici —, svoltisi a Catanzaro e a Bari (10 giugno 1969). Arrestato nuovamente il 17 giugno 1969 in un albergo di Bitonto mentre era in compagnia di Liggio, il 7 luglio 1969 la prima sezione del tribunale di Palermo lo condannò a quattro anni di confino a San Giovanni in Persiceto (provincia di Bologna). Ma Riina, con la scusa di ritornare per due giorni a Corleone per salutare i suoi parenti, si diede alla latitanza e non partì più per il confino.
Salvatore Riina fu tra gli esecutori della Strage di Viale Lazio, dove morirono Calogero Bagarella e il boss Michele Cavataio (1969). A Palermo si fece nemici il boss Giuseppe Di Cristina, Giuseppe Calderone, Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo che volevano impedire l’ascesa dei Corleonesi chiamati da loro viddani, cioè ‘contadini’. Fu invece appoggiato dai capi mafiosi Michele Greco e Pippo Calò. In questo periodo Riina prese il posto di Liggio, arrestato nel 1974, come ‘boss dei boss’ e sotto il suo comando i Corleonesi accrebbero notevolmente il proprio potere finanziario, grazie al traffico di droga e alle gare d’appalto a Palermo.
Al suo servizio troviamo tre dei più feroci killer: Pino Greco detto Scarpuzzedda, esecutore di vari ed efferati delitti, Mario Prestifilippo, Leoluca Bagarella (cognato dello stesso Riina). Siccome Di Cristina e Calderone lo stavano ostacolando, li fece assassinare barbaramente. Il boss Bontate invitò Riina nella sua villa per ucciderlo. Ma quest’ultimo venne avvisato da Michele Greco e alla villa mandò due suoi uomini: il piano omicida di Bontate era fallito.
Riina allora fece uccidere Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo: queste due uccisioni scatenarono una sanguinosa seconda guerra di mafia nei primi anni '80. Durante questa ‘guerra’ Riina fece uccidere i parenti del boss Tommaso Buscetta (che si salvò fuggendo in Brasile). In seguito Buscetta verrà estradato in Italia e comincerà a collaborare con il giudice Giovanni Falcone. Sconfitte le famiglie dei Bontate, degli Inzerillo, dei Di Cristina, dei Buscetta, dei Badalamenti e dei Calderone, Riina estese il suo potere su tutta Cosa Nostra e realizzò in questo periodo un’aggressiva campagna contro lo Stato, ordinando gli omicidi di tutti coloro che lo ostacolavano.
Le persone che Riina fece uccidere furono: il procuratore Pietro Scaglione (ucciso nel 1971), il tenente colonnello Giuseppe Russo (ucciso nel 1977), il giornalista Mario Francese (ucciso nel 1979), il politico Michele Reina (ucciso nel 1979), il capo della squadra mobile Boris Giuliano (ucciso nel 1979), il giudice Cesare Terranova (ucciso nel 1979), il presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella (ucciso nel 1980), il capitano dei carabinieri Emanuele Basile (ucciso nel 1980), l’onorevole Pio La Torre (ucciso nel 1982), il prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (ucciso nel 1982), il poliziotto Calogero Zucchetto (ucciso nel 1982), il giudice Rocco Chinnici (ucciso nel 1983), il capitano dei carabinieri Mario D’Aleo ucciso nel 1983, i commissari Beppe Montana e Ninni Cassarà (uccisi nel 1985), l’imprenditore Libero Grassi (ucciso nel 1991), i giudici Falcone e Borsellino (uccisi nel 1992), sebbene su questi Riina recentemente ha lasciato intendere verità più scottanti, come vedremo.
Il potente politico della DC Salvo Lima e l’esattore della famiglia di Salemi Ignazio Salvo avrebbero promesso a Riina che la sentenza del maxiprocesso (che lo condannava all’ergastolo in contumacia) sarebbe stata modificata grazie alle loro conoscenze negli ambienti della politica e della magistratura romana. Ciò, tuttavia, non avvenne e il 30 gennaio 1992 la Cassazione confermò gli ergastoli e sancì la validità delle dichiarazioni del pentito Buscetta. Riina reagì facendo uccidere prima Lima e pochi mesi dopo Ignazio Salvo.
Il 15 gennaio del 1993 fu catturato dal Crimor (squadra speciale dei ROS) sulle indicazioni del neopentito Baldassare Di Maggio. Riina, latitante dal 1969, venne arrestato al primo incrocio davanti alla sua villa in via Bernini n. 54, insieme al suo autista Salvatore Biondino, a Palermo, nella quale trascorse alcuni anni della sua latitanza insieme alla moglie Antonietta Bagarella e ai suoi figli. Secondo alcune fonti dietro il suo arresto c’è la mano del suo braccio destro, nonché amico d’infanzia Bernardo Provenzano, ansioso di divenire lui stesso capo dei capi di Cosa Nostra, e oltretutto in contrasto con Riina circa l’attacco a oltranza allo Stato (con i relativi massacri di personalità di spicco).
Fino al luglio del 1997 Riina è stato rinchiuso nel supercarcere dell’Asinara, in Sardegna. In seguito è stato trasferito al carcere di Marino del Tronto a Ascoli Piceno dove, per circa tre anni, fu sottoposto al carcere duro previsto per chi commette reati di mafia, il 41 bis, ma il 12 marzo del 2001 gli venne revocato l’isolamento, consentendogli di fatto la possibilità di vedere altre persone nell’ora di libertà. Nel 2003 gli è stata annullata tale revoca ed è costretto nuovamente al carcere duro.
Dal carcere di Opera, il 19 luglio 2009, esprime per la prima volta la sua convinzione secondo cui la strage di Via d’Amelio contro il giudice Borsellino sarebbe da imputare allo Stato e non alla mafia. Riina ha chiesto al suo avvocato di rendere nota la seguente dichiarazione (precisando che non intendeva ottenere favori di alcun tipo, proprio per ribadirne la genuinità): «Questa storia della “trattativa”, di un mio “patto” con lo Stato, di tutti gli impasti con carabinieri e servizi segreti legati al fatto di via d’Amelio, non sta proprio in piedi. Io della strage non ne so parlare. Borsellino l’ammazzarono loro». Dove “loro” «sono quelli che hanno fatto la trattativa, quelli che hanno scritto il “papello», come lo chiamano. Ma io della trattativa non posso saperne niente di niente. Perché io sono oggetto, non soggetto di trattativa. E la stessa cosa è per quel foglio con le richieste che qualcuno avrebbe presentato attraverso Vito Ciancimino. Mai scritto da me. Facciamo pure la perizia calligrafica e scopriremo che io non ho niente a che fare con questa vicenda. Andate a vedere là, al castello Utvegio, quella è roba vostra».[Castello Utvegio nei primi anni Novanta è stata la sede di alcuni irregolari del Sisde. Qui arrivarono, poco prima della strage di via D’Amelio, alcune telefonate di quel Gaetano Scotto, mafioso dell’Aquasanta, condannato per la strage. Il fratello, Pietro, lavorava per la ditta che si occupa di telefonia e che aveva lavorato agli impianti Sisde di castello Utvegio. Gaetano aveva messo sotto controllo le utenze di casa Borsellino. Un capitolo dell’inchiesta su cui aveva lavorato il consulente della polizia Gioacchino Genchi, mai del tutto chiarito. Pochi secondi dopo la strage, parte una telefonata a Bruno Contrada, all'epoca capo del Sisde a Palermo poi condannato per mafia, da un’utenza intestata a Paolo Borsellino.]
La moglie di Paolo Borsellino ha sentito di dover chiedere la verità su quanto accade in quel lontano 1992. Agnese Borsellino ha dichiarato che «se mi dicono perché l’hanno fatto, se confessano, se collaborano con la giustizia, perché se arrivi a una verità vera, io li perdono, devono avere il coraggio di dire chi glielo ha fatto fare, perché l’hanno fatto, se sono stati loro o altri, dirmi la verità, quello che sanno, con coraggio, con lo stesso coraggio con cui mio marito è andato a morire».
E, il 24 luglio 2009, davanti ai magistrati della procura di Caltanissetta che indagano sulle stragi di Capaci e di via D’Amelio, Riina (che non ha mai accettato di parlare con i magistrati in tutti questi anni di detenzione), ha conversato per tre ore. Ovviamente, gli atti sono stati tutti secretati; si sa solo che Riina ha promesso che consegnerà a breve un lungo memoriale: tutto quello che sa, e che non ha mai detto in sedici anni, lo metterà per iscritto. A patto che non si parli di lui come di un collaboratore con la giustizia e, ancor meno, di un pentito.
La prima volta che si parlò apertamente dei rapporti che legano la politica e la mafia fu in occasione dell’omicidio dell’ex sindaco di Palermo Notarbartolo. Coperto inizialmente sia dai suo agganci importanti che dallo stesso Parlamento Italiano, il mandante Raffaele Palizzolo, deputato e uomo di spicco della destra storica, fu prima processato e condannato, poi assolto. Il suo ruolo di tramite tra la mafia siciliana e politica fu provato ma non servì a farlo incarcerare.
Ma il caso forse più eclatante è quello di Giulio Andreotti. L’ex primo ministro è stato sottoposto a giudizio a Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa. In primo grado è stato assolto perché il fatto non sussiste. In appello si stabilì che Andreotti aveva «commesso» il «reato di partecipazione all’associazione per delinquere» (‘cosa nostra’), «concretamente ravvisabile fino alla primavera 1980», reato però «estinto per prescrizione» e fu assolto per i fatti posteriori al 1980. L’obiter dicta (parte di una sentenza che non “fa diritto”) della sentenza della Corte di Appello di Palermo del 2 maggio 2003, parla di «un’autentica, stabile e amichevole disponibilità dell’imputato verso i mafiosi fino alla primavera del 1980».
Altri nomi politici collusi con la mafia sono quelli di Vito Ciancimino e Salvo Lima, i quali hanno ricoperto la carica di sindaci di Palermo negli anni cinquanta-sessanta. Il primo è stato giudicato colpevole nel 2001 di favoreggiamento e concorso esterno in associazione mafiosa, il secondo è stato ucciso dalla stessa mafia con cui collaborava nel 1992. Sono considerati i maggiori protagonisti del cosiddetto ‘sacco di Palermo’, una speculazione edilizia che vide le ville liberty della città far posto a enormi palazzi.
Veniamo quindi a Silvio Berlusconi. Da giovane, iniziò alcune sue attività con fondi di origine ignota. Il padre Luigi lavorava nella Banca Rasini, indicata da alcuni pentiti come mezzo per il riciclaggio del denaro sporco di ‘cosa nostra’. Inoltre, negli anni settanta assunse Vittorio Mangano, uomo d’onore di ‘cosa nostra’, che abitò per anni nella villa di Arcore. Fu Marcello Dell’Utri (fondatore di Forza Italia) a far assumere Mangano da Berlusconi, pur conoscendo lo «spessore delinquenziale» di Mangano, e anzi, lo avrebbe scelto proprio per tale «qualità». Dell’Utri è stato condannato per estorsione (insieme al boss Francesco Virga), è stato trovato in compagnia del boss Gaetano Corallo, ed è stato anche condannato in primo grado a nove anni per concorso esterno in associazione di tipo mafioso nel 2004.
Anche Totò Cuffaro, presidente della regione Sicilia, è un personaggio da tempo indagato (ma non giudicato) come vicino alla mafia (gli si contestano la rivelazione di segreto istruttorio e concorso esterno in associazione mafiosa).
Collusione fra apparati deviati dello Stato e mafia starebbero emergendo anche dalle dichiarazioni del figlio di Ciancimino, dalle denunce incessanti di Salvatore Borsellino (fratello di Paolo), e dal nuovo processo a Marcello Dell’Utri in corso a Palermo.
Lo stesso Paolo Borsellino ha spiegato in una delle sue ultime interviste l’equivoco di fondo della politica italiana. Il politico colluso, amico, referente, compare di affari, testimone di nozze di un criminale non ha bisogno di una condanna per uscire dalla vita pubblica. Ecco le parole di Borsellino, risalenti al 26 gennaio 1989: «L’equivoco su cui spesso si gioca è questo, si dice: quel politico era vicino a un mafioso, quel politico è stato accusato di avere interessi convergenti con l’organizzazione mafiosa, però la magistratura non l’ha condannato, quindi quel politico è un uomo onesto. Eh no! Questo discorso non va perché la magistratura può fare soltanto un accertamento di carattere giudiziale. Può dire che ci sono sospetti, ci sono sospetti anche gravi, ma io non ho la certezza giuridica, giudiziaria che mi consente di dire che quest'uomo è mafioso. Però, siccome dalle indagini sono emersi tanti fatti del genere, altri organi, altri poteri, cioè i politici, cioè le organizzazioni disciplinari delle varie amministrazioni, cioè i consigli comunali, o quello che sia, dovevano già trarre le dovute conseguenze da queste vicinanze tra politici e mafiosi che non costituivano reato, ma rendevano comunque il politico inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Questi giudizi non sono stati tratti perché ci si è nascosti dietro lo schermo della sentenza. Si dice: questo tizio non è mai stato condannato, quindi è un uomo onesto... Ma dimmi un poco, tu non ne conosci gente disonesta che non è mai stata condannata perché non ci sono le prove per condannarla? C’è il forte sospetto che dovrebbe, quanto meno, indurre i partiti a fare grossa pulizia, a non soltanto essere onesti, ma apparire onesti facendo pulizia al loro interno di tutti coloro che sono raggiunti comunque da episodi e fatti inquietanti».
Dal 1996 sappiamo da Giovanni Brusca, poi confermato dagli interessati e da Massimo Ciancimino, che due ufficiali del Ros dei Carabinieri, il colonnello Mario Mori e il capitano Giuseppe De Donno, dopo la strage di Capaci andarono a «trattare» con Vito Ciancimino e, tramite lui, con i capi di ‘cosa nostra’: Riina e Provenzano.
Sappiamo che Paolo Borsellino, dopo la morte dell’amico Giovanni Falcone, lottò contro il tempo per individuare i mandanti di Capaci, e mentre interrogava uno dei primi pentiti, Gaspare Mutolo, il 1° luglio 1992, fu convocato d’urgenza al Viminale dove si era appena insediato il ministro Nicola Mancino, poi tornò da Mutolo letteralmente sconvolto. Pochi giorni dopo, saltò in aria anche lui in via D’Amelio. La trattativa del Ros con Ciancimino e i corleonesi proseguì, tant’è che i secondi fecero pervenire ai due ufficiali un “papello” con le richieste della mafia per interrompere le stragi.
Mancino nega da anni di aver incontrato Borsellino il 1° luglio ’92, esibendo come prova la propria agenda e smentendo così quella del giudice assassinato. Ma ora viene contraddetto dal giudice Ayala: «Mancino mi ha detto che ebbe un incontro con Borsellino il giorno in cui si insediò al Viminale (1° luglio ’92): glielo portò in ufficio il capo della polizia Parisi. Mi ha fatto vedere l’agenda con l’annotazione». E Mancino corregge la sua dichiarazione: «Non posso escludere di avergli stretto la mano nei corridoi o nell’ufficio… Non ho un preciso ricordo».
Dal racconto di Ciancimino jr., apprendiamo che suo padre ricevette tre lettere di Provenzano indirizzate a Berlusconi: una all’inizio del 1992, prima delle stragi; una nel dicembre ’92, dopo Capaci e via d’Amelio e prima delle bombe di Roma (via Fauro, contro Costanzo), Firenze, Milano e Roma (basiliche); una nel ’94, dopo l’entrata in politica di Berlusconi. Nell’ultima lo Zu’ Binnu prometteva all’attuale premier, che aveva appena fondato Forza Italia e vinto le elezioni, un sostanzioso «appoggio politico» in cambio della disponibilità di una delle sue tv, guardacaso protagoniste in seguito di feroci campagne contro i magistrati antimafia e in difesa di imputati eccellenti nei processi su mafia e politica.
Sappiamo infine che nei momenti topici delle stragi si agitavano misteriosi soggetti dei servizi segreti, tra i quali uno col volto mostruosamente sfregiato. Ci stanno lavorando le Procure di Palermo e Caltanissetta, accerchiate dal silenzio tombale della politica e delle istituzioni. Eppure protagonisti e comprimari di quella stagione dalla parte dello Stato sono vivi e vegeti, anzi han fatto carriera. Mancino, indicato da Brusca e Massimo Ciancimino come al corrente della trattativa, nega di aver mai visto o riconosciuto Borsellino nel fatidico incontro al Viminale, e attualmente ricopre la carica di vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Mori — imputato di favoreggiamento mafioso per la mancata cattura di Provenzano nel ’96 dopo essere stato assolto con motivazioni severe dall’accusa di aver favorito la mafia non perquisendo il covo di Riina dopo la sua cattura — è stato a lungo comandante del Sisde e ora è consulente per la sicurezza del sindaco Alemanno. Gli ex procuratori di Palermo, Grasso e Pignatone, che nel 2005 trovarono a casa Ciancimino l’ultima lettera di Provenzano a Berlusconi e non ne fecero un bel nulla, sono rispettivamente procuratore nazionale antimafia e procuratore di Reggio Calabria.