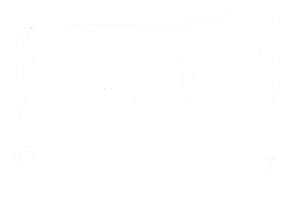Intervento del Prof. Gian Domenico Bua
Ringrazio il Prof. Cognetti che ci ha dato la possibilità di includere in un suo seminario di filosofia comparata la presentazione di questo libro di Sri Aurobindo, libro sicuramente importante, anche se non è considerato fra le sue opere fondamentali o più compiute. Grazie al carissimo amico Piergiorgio Solinas, col quale ci conosciamo e frequentiamo da ragazzini, quando ci sentivamo degli accesissimi rivoluzionari — come d’altronde è stato a suo tempo anche Sri Aurobindo. E grazie al prof. Squarcini per la sua gentile partecipazione.
Quella che vorrei è fornire una sorta di sintetica introduzione allo “svelamento del segreto”, che riferirò solo per sommi tratti, a volte operando dei veri e propri colpi d’ascia rispetto al testo scritto.
Curioso ritrovarci qui con un carissimo amico, a distanza di quasi quarant’anni da quel ’68 che ci vide militanti sullo stesso fronte a parlare di questioni che possono essere definite “mistiche”, proprio noi che allora ci riproponevamo di essere dei “rigorosi materialisti” — con riferimento a un materialismo non volgare ma per lo meno “dialettico”, rischiando di farne una sorta di religione, anche se nel senso nobile del termine e pur non considerandola, ovviamente, una religione.
È stato come un colpo di luce leggere in un passo del sesto tomo dei “Carnets d’une Apocalypse” di Satprem — uscito recentemente presso l’Istituto di Ricerche Evolutive di Parigi ma riferito al 1986-87 — un passo che recita: «I Rishi vedici e Sri Aurobindo sono gli sperimentatori più concreti del mondo, anche se c’è chi dice che si tratta di ‘poesia’ o di ‘filosofia’ o forse di miti... Certo, si può avere una visione ‘scientifica’ dell’Amazzonia mediante satelliti o fotometrie all’infra e al sopra-rosso. Ma camminarci dentro con un machete è un’altra cosa». Poco più avanti (pag. 19) - ricordando che non sappiamo niente della Realtà dell’universo, al di là della sua scorza, Satprem, che io considero il più coerente “discepolo” o continuatore dell’esperienza e del lavoro fatti da Sri Aurobindo e da Mère, dice — sorprendentemente — che «Sri Aurobindo è il più grande dei Materialisti (maiuscole sue). Egli ha cercato nella Materia la Legge che potrebbe disfare la sofferenza umana».
I Carnets di Satprem — come sa chi li conosce — sono una sorta di diario quotidiano della sua esperienza di uno yoga del corpo o delle cellule, che Mère aveva iniziato, grosso modo a partire dagli anni sessanta del secolo scorso. Il suo sforzo (o il suo destino) è quello di portarlo avanti. Non solo per sé — ribadisce spesso — ma per l’intero “corpo della Terra”. Quindi anche per noi, presumo. Satprem sostiene — e lo ha mirabilmente argomentato nel suo bel libro “La Tragédie de la Terre. De Sophocle à Sri Aurobindo” — che anche Sri Aurobindo era in un certo senso il continuatore dell’esperienza degli antichi o antichissimi rishi vedici, che possiamo considerare come nostri progenitori, come gli Antenati di questa umanità ancora presente sulla terra. Possiamo dire, quindi, che si tratta di esperienza “profondamente materialistica”. Anche se non è affatto fuori luogo chiamare i rishi vedici dei poeti mistici. E non mi pare quindi un caso che chiunque intenda essere un coerente ricercatore “materialista” possa incappare nella fortuna di poter leggere e condividere la portata e il senso profondo di un’esperienza come questa, cominciando, come spesso accade, dalla lettura dei libri che ne parlano. A me a esempio è capitata la fortuna di venire a conoscenza dei libri di Sri Aurobindo proprio grazie alla lettura di un interessante libro del promotore di questa iniziativa, il professor Cognetti, intitolato “L’arca perduta” — dedicato a una profonda analisi critica del pensiero di René Guénon e in particolare del suo libro “Il regno della Quantità e i segni dei tempi”. Nel quale Cognetti proponeva un fruttuoso e opportuno confronto o parallelo fra le tesi sostenute da Guénon e la concezione evolutiva di Sri Aurobindo esposta, in particolare, nella sua summa filosofica “La Vita divina” e nei due testi di carattere più propriamente socio-psicologico e storico (in senso lato) l’“Ideale dell'Unità umana” e “Il ciclo umano”.
Il mio contributo — dicevo — voleva essere un ri-percorso dei passaggi essenziali di un ragionamento che è di una logica stringente. E nel corso della prima traduzione di questo libro (poi opportunamente riveduta, corretta, perfezionata dall’intero team dei traduttori di aria nuova) quel che più mi affascinava era proprio il metodo rigoroso seguito e illustrato dall’Autore, di cui si dà conto esauriente nei capitoli iniziali del libro, dedicati rispettivamente al “problema e alla sua soluzione”, alla “retrospettiva della teoria vedica” e delle “teorie moderne”, quindi ai “fondamenti della teoria psicologica” e al “metodo filologico del Veda”. Gli ultimi due credo siano due capitoli fondamentali proprio per capire e afferrare il metodo stesso attraverso cui si procede allo “svelamento” del segreto del Veda. Essi dovrebbero quindi interessare e corroborare lo studioso che voglia accostarsi a questo libro, che Sri Aurobindo ha sempre considerato come incompiuto o incompleto, proprio perché non fece a tempo o non ritenne necessario rivederne la stesura e la composizione. Tant’è che l’ultima edizione delle Opere complete dedica all’argomento ben tre volumi che col tempo cercheremo di riuscire a pubblicare anche in italiano: un secondo volume dedicato alla traduzione, all’analisi e a un commento a tratti minuzioso, ricco di note, a un cospicuo numero di Inni del Rig-Veda, che Sri Aurobindo mostra di aver minuziosamente “studiato” e cercato di compenetrare; un terzo volume dedicato a una serie di scritti sulla lingua sanscrita e la sua origine, di cui è stata pubblicata solo qualche anticipazione, oltre a un saggio incluso nel primo volume di un’edizione precedente del “Segreto dei Veda”. Questo volume deve ancora uscire.
La sostanza dei Veda – scrive Sri Aurobindo – è un sistema di simboli e di immagini il cui significato deve essere scoperto: ci sono tuttavia chiare indicazioni nel linguaggio esplicito degli inni che ci guidano verso quel significato.
Poiché il significato dei simboli appare spesso “ambiguo”, occorre evitare di costruire — come è avvenuto nel corso di almeno duemila anni — un sistema basato sulle nostre fantasie e preferenze. In questo caso, per quanto ingegnosa, ogni teoria non può che essere una costruzione campata in aria: magari anche brillante, ma priva di realtà e solidità.
Perciò il primo compito, o passo dell’indagine è quello di individuare e chiarire quel “nucleo di nozioni psicologiche” che autorizzano a supporre nel Veda un significato molto più elevato di quello barbarico e primitivo. Il passo successivo consiste nella interpretazione di ogni simbolo e immagine e della loro funzione psicologica, trovando un senso fisso e non variabile, basato su una vera giustificazione filologica, che si adatti in modo naturale al contesto ogni volta che si presenta.
«Il linguaggio degli inni, infatti, è un linguaggio fisso e invariabile, lo stile è accuratamente conservato e scrupolosamente rispettato ed esprime in modo uniforme una credenza o un rituale, una dottrina tradizionale e una costante esperienza»… «C’è una relazione costante evidente fra le differenti nozioni e i termini preminenti della religione vedica", di fronte alla quale le eventuali incoerenze e incertezze di interpretazione provano non tanto che quella evidenza sia ingannevole, ma che l’interprete non è riuscito a scoprire le giuste relazioni»
(pp. 40-41 — IV. I fondamenti della teoria psicologica).
Poco più avanti Sri Aurobindo rivela che «il primo contatto col pensiero vedico era venuto indirettamente allorché perseguiva certe linee di sviluppo interiore sulla via dello yoga indiano»; queste linee rivelavano presto una convergenza con le vie antiche, ora abbandonate, seguite dagli antenati. Dice l’Autore: «A quel punto cominciò a sorgere nella mia mente un insieme di nomi simbolici connessi a certe esperienze psicologiche che cominciavano a organizzarsi». Fra queste c’erano le figure di tre energie femminili, chiamate rispettivamente Ilâ, Sarasvatî e Saramâ; esse rappresentavano separatamente tre delle quattro facoltà della ragione intuitiva: rivelazione, ispirazione e intuizione. Si trattava di nomi appartenenti a dee vediche, ricorrenti anche nella religione successiva e nella tradizione puranica: Sarasvatî dea del sapere, Ilâ, dea-madre della dinastia lunare, Saramâ, il segugio del cielo. Quest’ultima era associata (nella memoria dell’Autore) alla Elena argiva e rappresentava (allora) solo un’immagine dell’aurora fisica durante il suo inseguimento degli armenti scomparsi, di cui Saramâ va alla ricerca penetrando all’interno della caverna dei poteri dell’ombra. Mancava la chiave per capire l’identità del simbolo. La chiave era quella della “luce raffigurata in cattività” (della luce tenuta prigioniera). Trovata questa chiave fu facile «vedere come il segugio del cielo può essere l’intuizione che entra nell’oscura caverna della mente subcosciente, per preparare la liberazione e l’esplosione all’esterno delle brillanti illuminazioni della conoscenza che vi erano rimaste imprigionate».
Questa interpretazione simbolica — come Tommaso ha poc’anzi messo in evidenza — rappresenta il nucleo essenziale del “segreto” stesso dei Veda, svelato proprio grazie a questa sistematica e precisa “interpretazione psicologica” dei termini fondamentali, delle immagini, delle figure, dei simboli e dei miti o parabole che compaiono nell’intero tessuto degli Inni. Che bisognava evidentemente liberare dalle incrostazioni, dai fraintendimenti, a volte dalle vere e proprie falsificazioni a cui erano stati sottoposti nel corso di molti secoli. Escludendo decisamente l’indebita supposizione che «i rishi vedici, a differenza di tutti gli altri maestri di stile poetico, avessero utilizzato le parole alla rinfusa o a caso, senza percepire le loro giuste associazioni, senza dare loro la forza esatta e rigorosa nella combinazione verbale» (p.47).
Se invece si evitava di allontanarsi o scostarsi dal senso semplice, naturale e diretto delle parole e delle espressioni, appariva subito evidente «un insieme straordinariamente importante non solo di versi isolati ma di interi passi che modificavano completamente l’intero carattere del Veda» mettendo a nudo quella «vena ininterrotta dell’oro più puro del pensiero ed esperienza spirituale che l’attraversano da un capo all’altro». In particolare si trattava di cogliere il significato più profondo di molte parole che possiedono, accanto a un senso o valore esteriore e materiale, un valore interiore e psicologico - ad esempio: raye, rayi, radhas, ratna che possono voler dire prosperità e ricchezza materiali ma anche (o soprattutto) felicità e pienezza interiori; dhana, vaja, posha, che possono significare ricchezza, abbondanza e accrescimento materiali, ma anche le proprietà interiori o esteriori, la loro pienezza e la loro crescita nella vita dell’individuo.
«Il buon senso esige – come minimo – che l’impiego di queste parole con valore psicologico sia ammesso nel Veda».
Se questo assunto viene accettato e perseguito in modo coerente, «non solo alcuni versi, ma la totalità degli inni assume immediatamente il carattere psicologico». La condizione che rende completa questa trasformazione [di senso] – senza alterare nessuna parola o espressione – è quella di ammettere il carattere simbolico del sacrificio vedico.
Ci sono nel Veda inni dove chiaramente l’idea del sacrificio (yajña) o dell’offerta sacrificale è simbolica; altri nei quali il velo è del tutto trasparente.
Una difficoltà dell’interpretazione psicologica si presenta all’Autore allorché incontra elementi in cui «il significato superficiale doveva essere superato». E si tratta allora di un processo che suscita scrupoli in ogni mente critica e coscienziosa, dato che non si può mai essere certi, neppure quando si mette in atto una cura estrema, di aver afferrato la chiave corretta e la giusta interpretazione (p. 49)
Questa difficoltà di interpretazione riguarda l’insieme degli elementi costitutivi del sacrificio vedico.
Il sacrificio vedico consiste di tre elementi: le persone che offrono, l’offerta e i frutti dell’offerta, cui bisogna aggiungere un quarto e quinto elemento: il dio invocato e il mantra che lo invoca. Ma c’erano anche i sacerdoti officianti, chiamati con molti e differenti nomi. Quale era – si chiede Sri Aurobindo – il loro ruolo nel simbolismo? Se si dà un senso simbolico al sacrificio, infatti, bisogna attribuire un valore simbolico ad ogni aspetto della cerimonia.
Una volta scoperto che: 1) gli dèi sono continuamente menzionati come sacerdoti dell’offerta, con chiaro riferimento a un potere o a una energia non umani che presiedevano al sacrificio; 2) nell’intero Veda gli elementi della nostra personalità sono anch’essi continuamente personificati;
bisognava «applicare inversamente la regola», ovvero «supporre che la persona del sacerdote nell’immagine esteriore rappresentasse, nelle attività esteriori raffigurate, un potere o un’energia non umani, o un elemento della nostra personalità» (p. 50).
La chiave viene offerta, a questo proposito, da alcune indicazioni e insistenze filologiche, come l’impiego del termine purohita con il significato di “posto innanzi” e un riferimento frequente al dio Agni, Signore del Fuoco o della Fiamma, simbolo della volontà o forza divine nella umanità, che assume l’azione in tutte le consacrazioni delle opere.
Più difficili da capire erano le offerte: meno difficile il cosiddetto “vino di Soma’ — la libagione sacra che rappresenta l’ebbrezza, la delizia e la gioia divina — più difficile il significato simbolico da attribuire al ghritam, il burro chiarificato “che cade a gocce dal cielo o sgocciola dai cavalli del dio Indra, ovvero dalla mente”. La parola ghrita è continuamente impiegata in rapporto con il pensiero o la mente; il cielo stesso nel Veda è un simbolo della mente; il dio Indra rappresenta la mente illuminata e i suoi due cavalli simboleggiano le duplici energie della mente illuminata. A volte ricorre anche la similitudine dell’offerta del burro purificato come offerta dell’intelletto agli dèi. E la parola comprende anche, fra i suoi significati filologici, il senso di brillantezza ricca o calda.
Questo insieme di indicazioni giustificavano quindi nell’Autore l’attribuzione di un certo senso psicologico all’immagine materiale del burro chiarificato. Che così scopriva di poter applicare la stessa regola e lo stesso metodo anche agli altri elementi del sacrificio, nonostante il fatto che i frutti dell’offerta fossero, in apparenza, tutti decisamente materiali: vacche, cavalli, oro, progenie, uomini, forza fisica, vittoria nella battaglia.
E tuttavia: la parola usata per “vacca” (go) significava al contempo “luce” e questo significato di luce è evidente in molti passi del Veda, anche quando si presenta l’immagine della vacca. L’associazione simbolica diventa del tutto chiara quando si parla delle “vacche del Sole” – le stesse dell’armento omerico dell’Odissea – e delle vacche dell’Aurora.
«Psicologicamente, la luce fisica poteva dunque benissimo venire utilizzata come un simbolo della conoscenza e in particolare della conoscenza divina. La verifica di questa possibilità è fornita dai passi ricorrenti in cui il "contesto circostante" è psicologico e l’immagine della vacca costituisce una sorta di "interferenza con la sua invadente suggestione materiale».
In un passo Indra viene invocato come “creatore delle forme perfette” perché beva il vino di Soma; bevendo egli diviene “pieno di estasi” e “donatore di vacche”; a quel punto gli uomini, i sacrificanti, possono raggiungere i suoi pensieri più intimi, giusti e fondamentali; è allora che il dio viene interrogato e il suo chiaro discernimento fa conseguire il bene più alto.
Sri Aurobindo fa notare come in questo passo «le vacche non possono essere un amento fisico; tanto meno avrebbe senso nel contesto il dono della luce fisica». Dunque, almeno in questo caso, il simbolismo della vacca vedica poteva essere stabilito con certezza. Applicato successivamente ad altri passi in cui ricorreva il termine, ne risultava sempre un «significato migliore», insieme alla «maggiore coerenza possibile nel contesto».
La vacca e il cavallo (go e ashva) sono sempre associati. Usha, l’Aurora, è descritta come colei che dona al sacrificante cavalli e vacche. Dunque, anche il cavallo, come la vacca, non può essere soltanto un destriero fisico, ma deve avere allo stesso tempo un significato psicologico. L’analisi successiva porta l’Autore alla conclusione che la vacca e il cavallo, nel simbolismo vedico, rappresentano le due sorelle di Luce ed Energia, Coscienza e Forza, che — per la mentalità vedica e vedantica — costituiscono il duplice aspetto gemellare di tutte le attività dell’esistenza. (p. 52)
«Era di conseguenza evidente che i due principali frutti del sacrificio vedico, la ricchezza di vacche e la ricchezza di cavalli, costituivano elementi simbolici dell’arricchimento dell’illuminazione mentale e della abbondanza di energia vitale. Ne conseguiva che gli altri frutti, continuamente associati a questi, dovevano essere altrettanto capaci di un significato psicologico».
A quel punto «restava solo da determinare la loro esatta implicazione».
Un altro aspetto del simbolismo considerato di primaria importanza è il sistema dei mondi e delle funzioni degli dèi. Le parole simboliche del mantra si riferiscono a tre divisioni cosmiche conosciute dai rishi vedici: la terra, la regione intermedia e il cielo. Oltre queste c’è un cielo più alto, detto Brihat, chiamato il Vasto Mondo e a volte rappresentato come la Grande Acqua. È quello che nelle Upanishad è chiamato il Quarto Mondo (Mahas). Nel Veda, come nei Purana, si fa riferimento a tre mondi supremi senza nome (nei Purana sono nominati come Jana, Tapas e Satya)
I sette mondi corrispondono ai sette principi psicologici o forme dell’esistenza: sat, essere-esistenza — cit, Coscienza — ânanda, delizia-beatitudine — vijñana, sopramente — manas, la mente — prana, il vitale — anna, cibo, nutrimento. I due sistemi (quello puranico e quello vedico) sono identici; ed è proprio sulla base di questa identità sostanziale che Sri Aurobindo dice di aver potuto identificare i mondi vedici con i piani psicologici di coscienza corrispondenti. «In tal modo l’intero sistema vedico è diventato chiaro al mio pensiero…Così che il resto poté seguire in modo naturale e inevitabile» (p. 53-54).
Ed è proprio in questo passo che S.A. accenna chiaramente a quello che possiamo considerare il cuore stesso del Segreto del Veda.
Dice infatti: «Avevo già visto che l’idea centrale dei rishi vedici era la transizione dell’anima umana da uno stato di morte a uno stato di immortalità, con la sostituzione della falsità con la verità, dell’essere diviso e limitato con l’integralità e l’infinità. La morte è lo stato ferale della materia, con mente e vita in essa involute; l’immortalità è uno stato d‘essere di coscienza e di beatitudine infinite. L’uomo si eleva al di là dei due firmamenti, il cielo e la terra, la mente e il corpo, verso l’infinità della verità (mahas) e quindi verso la beatitudine divina. È questo il grande passaggio scoperto dai progenitori, gli antichi rishi» (p. 54).
Il sacrificio vedico è un “viaggio” verso la luce per diventare questa stessa Luce. È un’ascesa verso il Vasto Mondo. Ed è anche una battaglia tra gli dèi, descritti come figli della Luce o della Madre Aditi, l’Illimitata, e i dèmoni che ad essi si oppongono come poteri di divisione e di limitazione. Gli dèi sono coloro che fanno crescere l’uomo, portandogli la luce, riversando su di lui la pienezza, l’abbondanza, accrescendo in lui la verità, guidandolo contro tutti gli attacchi verso la grande meta che è la felicità integrale, la perfetta beatitudine. I demoni che ad essi si oppongono sono detti “ricettatori, squartatori, divoratori, limitatori, fautori-di-dualità, ostacolatori”: sono poteri che agiscono contro l’integralità libera e unificata dell’essere.
«Non si tratta di re o dèi dravidici – come vorrebbe la mentalità moderna con il suo esagerato senso storico: essi rappresentano un’idea molto più antica…la lotta fra i poteri del Bene superiore e quelli del desiderio inferiore…derivata probabilmente da una disciplina originale comune della cultura ariana» (p. 54-55).
La successiva scoperta è che il simbolismo sistematico del Veda si estende anche alle leggende relative agli dèi e ai loro rapporti con gli antichi veggenti.
Sri Aurobindo non esclude che alcuni di questi miti potessero avere avuto una origine naturalistica e astronomica; ma, se è così, «il loro senso originale era stato completato da un simbolismo psicologico».
Il Veda nel suo complesso è dunque una scrittura tutt’altro che confusa o primitiva, tutt’altro che una mescolanza di elementi eterogenei o barbarici (come pure è stata considerata da alcuni studiosi occidentali). Sri Aurobindo la definisce «una Scrittura completa e cosciente di sé, nel disegno e nella portata, velata sotto una copertura talvolta spessa, talvolta trasparente, di un significato materiale altro, ma senza perdere mai di vista per un solo momento i suoi nobili intenti e tendenze spirituali» (p 55).
Questi due temi leggendari o mitici appaiono ovunque, ricorrono negli inni come i «due fili strettamente intrecciati attorno ai quali è tessuto il simbolismo vedico". Sono dunque le due principali ‘parabole’ dei Veda: il che non significa che ne rappresentano le idee centrali, ma sono "i due pilastri fondamentali di questa antica composizione».
Determinare il loro significato significa perciò risolvere il senso dell’intero Rig Veda.
Sgombrato il campo dalle false interpretazioni (insostenibili) di tipo naturalistico o etnico, Sri Aurobindo evidenzia nei dettagli «un simbolismo della lotta fra i poteri spirituali della Luce e dell’Oscurità, della Verità e della Falsità, della Conoscenza e dell’Ignoranza, della Morte e dell’Immortalità» che considera essere «il significato reale dell’intero Veda».
I rishi Angiras sono i “portatori dell’Aurora“, i «liberatori del Sole sottratto all’oscurità»: aurora, sole e oscurità sono immagini utilizzate con un preciso significato spirituale.
La concezione centrale del Veda è infatti «la conquista della Verità sottratta all’oscurità dell’Ignoranza, e con questa anche la conquista dell’immortalità». La Verità dei Veda (il ritam) è una concezione spirituale e psicologica, che corrisponde all’Essere vero, alla Coscienza vera, alla Delizia vera dell’esistenza, al di là della terra corporea, della regione intermedia vitale, del cielo ordinario della mente. Questi sono i piani che occorre superare, varcare, attraversare per arrivare al piano superiore della Verità sovracosciente, il Mondo di Svar, la dimora degli dèi e il fondamento dell’immortalità.
Gli Angiras sono i rishi veggenti, (rappresentanti degli dèi sulla terra e progenitori umani), sono coloro che “hanno trovato la via per i posteri”: la via che porta a questo Mondo di Svar.
Essi sono descritti come “figli e poteri di Agni”, poteri della Fiamma, della Forza divina, pervasa dalla Conoscenza divina, che viene accesa per la vittoria. Essi accendono la fiamma celata nell’evoluzione dell’esistenza terrestre sull’altare sacrificale, nel corso dei nove o dei dieci mesi che simboleggiano i periodi dell’opera divina, grazie alla quale il Sole di Verità viene liberato dall’oscurità.
Il loro sacrificio è anzitutto un dono, un’offerta: è il dono dell’uomo alla Natura superiore o divina di ciò che di più profondo possiede nel proprio essere; il frutto del dono è un ulteriore arricchimento della propria umanità, propiziata dalla generosità degli dei. La ricchezza acquisita in questo modo è uno stato di benessere, di prosperità e di felicità spirituali, che diventa esso stesso un potere per il viaggio e una forza per la battaglia.
Il sacrificio è un viaggio, un avanzare e progredire sulla via divina; il modello di questo viaggio è proprio l’ascesa dei progenitori Angiras al mondo divino di Svar.
Il loro viaggio sacrificale è anche una battaglia contro gli ostacoli continuamente frapposti dai poteri dell’oscurità e della falsità (i Pani e i Vritra, e altri). La lotta decisiva combattuta dagli Angiras e da Indra contro i Pani è il principale episodio di questa lunga guerra.
Le caratteristiche essenziali del sacrificio (l’accensione della fiamma, l’offerta del burro chiarificato e del vino di Soma, il canto della parola sacra o del mantra) sono atti che fanno crescere gli dèi, i poteri divini, nell’uomo; essi si manifestano per fare evolvere la terra e il cielo — ovvero l’esistenza fisica e mentale — fino alla creazione dei mondi o piani superiori.
«L’oggetto del sacrificio è la conquista dell’essere superiore o divino; e con esso la sottomissione alla sua legge e alla sua verità dell’esistenza inferiore e umana» (p. 268).
L’essere-esistenza superiore è il divino, l’infinito, di cui è simbolo Aditi, la Madre illimitata, la Vacca luminosa; l’essere-esistenza inferiore è ancora sottomessa alla sua forma oscura, Diti.
Il burro chiarificato che si versa nel corso del sacrificio è il prodotto della Vacca luminosa, è la chiarezza o lo splendore della luce solare nella mente umana.
Il vino di Soma è la delizia immortale dell’esistenza, celata nelle acque e nelle piante, che viene estratta per essere bevuta dagli dèi e dagli uomini.
Il Verbo è la parola ispirata che esprime l’illuminazione della Verità nell’anima, nel cuore e nella mente.
L’Angira supremo è Agni, la Fiamma dalla quale nascono gli stessi Angiras. Egli sorge insieme a Indra ed entrambi crescono grazie all’offerta del burro chiarificato, simbolo appunto di chiarezza e di splendore, della luce che illumina la mente umana. Brihaspati è il signore del Verbo creatore.
Egli è detto il signore dalle sette bocche e dai sette raggi: cioè dei raggi del pensiero illuminante e delle parole che lo esprimono. È il pensiero completo della Verità, dalla settupla testa, che conquista per l’uomo il quarto mondo, il mondo divino, ottenendo per l’uomo la ricchezza spirituale che è l’oggetto stesso del sacrificio.
Tutti questi dèi sono perciò descritti come «i conquistatori degli armenti del Sole e i distruttori dei Dasyu, delle forze oscure che li nascondono e li negano all’uomo». Gli stessi attributi spettano alle tre divinità femminili evocate dagli Inni vedici: Sarasvati, il fiume della Parola o ispirazione della Verità, Saramâ, la Cagna celeste annunciatrice di Indra, dea del Sole e dell’Aurora, simbolo del potere intuitivo della Verità, e Ushas, l’Aurora, che è l’artefice della grande vittoria e del suo risultato luminoso. Il suo arrivo coincide infatti col levarsi del Sole della Verità sovracosciente: è lei che dissolve la notte dell’ignoranza e fa nascere il giorno della vita vera nella vera coscienza. Usha stessa dunque è “la madre della verità”. Le sue vacche o raggi divini sono le sue verità; le forze che li accompagnano e prendono possesso della vera Vita sono i suoi cavalli (che come abbiamo visto sono i simboli ricorrenti delle ricchezze che l’uomo chiede agli dèi).
Le vacche dell’Aurora, nella parabola, sono state rubate e nascoste dai dèmoni, i signori delle tenebre, nella caverna che sta nelle viscere della montagna: cioè nella caverna del subcosciente segreto. Sono dunque le “illuminazioni di conoscenza” i “pensieri della Verità”, che devono essere liberati dalla prigionia. E la loro liberazione è il sorgere dei Poteri dell’Aurora divina.
La liberazione dei raggi dell’Aurora è anche il ricupero del “Sole nascosto nell’oscurità”, che è quello scoperto da Indra e dagli Angiras nella caverna dei Pani. Con la distruzione della caverna le mandrie dell’Aurora divina (i raggi del Sole di Verità) risalgono la montagna dell’essere e il Sole stesso ascende all’Oceano superiore dell’esistenza divina. I “pensatori vedici” lo conducono nella sua traversata proprio come “una nave sulle acque”, fino a raggiungere l’altra riva. (290).
I Pani che nascondono gli armenti del Sole, i signori della caverna inferiore, sono un genere di Dasyu (o Dasa, forze ostili che tentano di impedire il compimento del progresso interiore dell’uomo alla ricerca dell’immortalità) in opposizione agli dèi, ai veggenti e agli officianti ariani.
L’ariano — spiega Sri Aurobindo — è colui che compie l’azione del sacrificio, trova la parola sacra dell’illuminazione, aspira agli dèi, ad accrescerli venendone accresciuto nella pienezza della vera esistenza; egli è dunque il guerriero della Luce e il viaggiatore verso la Verità.
Il Dasyu è l’essere non divino, che non compie il sacrificio, che ammassa una ricchezza che è incapace di utilizzare nel modo gusto, poiché non è in grado di pronunciare la Parola e realizzare nella sua mente la Verità sovracosciente; egli odia la Parola, gli dèi e il sacrificio, non dona niente di se stesso alle esistenze superiori, bensì estorce e nega la sua ricchezza all’ariano. In questo senso egli è il ladro, il nemico, il lupo, il divoratore, colui che divide, ostruisce e confina. I Dasyu sono i poteri dell’oscurità e dell’ignoranza che si oppongono al cercatore della verità e dell’immortalità.
Gli dèi sono i poteri della Luce, i figli dell’infinità, forme e personalità della Divinità unica; grazie al loro aiuto e alla loro crescita nelle azioni umane, l’uomo si eleva alla verità e all’immortalità.
Se la leggenda degli Angirasa, la storia della lotta contro i Dasyu, è una parabola simbolica, devono esserlo anche gli altri racconti leggendari del Rig Veda, che insistono sull’aiuto degli dèi contro i dèmoni. Quindi, se i Dasyu che rifiutano il dono e il sacrificio, con i quali gli ariani sono sempre in guerra, i Vritra, i Pani e altri non sono nemici umani ma poteri dell’oscurità, della falsità e del male, l’intero affresco del Veda riveste l’aspetto di un simbolo e di un apologo spirituali.
Sri Aurobindo — al termine della “Sintesi conclusiva” del Segreto dei Veda (vol. I) — rimanda a un esame più dettagliato che possa decidere se si tratti di un racconto interamente o solo parzialmente simbolico.
«Il nostro proposito — precisa — è solo quello di vedere se esistano argomenti corretti, salvo prova contraria, per l’idea dalla quale siamo partiti, che gli inni vedici siano il vangelo simbolico degli antichi mistici indiani e che il loro significato sia spirituale e psicologico».
Egli ritiene di aver dimostrato la correttezza di questi argomenti e di aver quindi gettato «una base sufficiente per accostarsi in modo serio al Veda proprio da questo punto di vista e per interpretarlo nel dettaglio come un simbolismo lirico».
Per rendere più solida questa interpretazione viene presa in esame anche l’altra leggenda simile di Vritra e delle Acque, che è in stretta relazione con quella degli Angiras e della Luce.
In questa leggenda Vritra (nome che deriva dalla radice vri = trattenere, frenare) incarna la potenza dell’impedimento ostile. Indra, l’uccisore di Vritra, è insieme ad Agni uno degli dèi principali del pantheon vedico. I suoi compagni di battaglia, i Marut, i cantori del canto sacro, sono gli dèi della tempesta e possiedono, forse più di tutte le altre divinità vediche (Agni o gli Asvin, i Cavalieri gemelli, Mitra, Varuna, Tvastri e le altre dee, Surya il Sole Usha l’Aurora) un carattere fisico alquanto pronunciato. E tuttavia un’analisi accurata rivela che hanno anch’essi un carattere e un simbolismo psicologici.
Vritra e i demoni a lui associati, sono anch’essi dei Dasyu e sono in particolare associati alla ostruzione delle acque celesti, mentre i Pani sono in particolare associati al rifiuto delle Vacche di luce. Ma tutti i Dasyu, senza eccezione, sbarrano la via dell’ascesa verso Svar, il mondo superiore, e si oppongono all’acquisizione della ricchezza da parte dei viaggiatori ariani. Il rifiuto della Luce è la loro opposizione alla visione di Svar, alla visione suprema della Conoscenza; il rifiuto delle acque è la loro opposizione al movimento intenso di Svar, cioè al movimento o alle correnti della Verità. L’opposizione all’acquisizione delle ricchezze è il loro rifiuto dell’abbondante sostanza di Svar, la grande ricchezza che si trova sia nel Sole che nelle Acque.
Tutti i Dasyu sono dunque identificati con l’Oscurità. Ed è grazie alla nascita e allo splendore di Agni, la Fiamma, il Sole di Verità, che è creata la Luce con la quale egli annienta i Dasyu e l’Oscurità.
In conclusione, Sri Aurobindo non si nasconde certo il fatto che il simbolismo vedico, come si sviluppa negli Inni del Rig-Veda, è alquanto complesso nei dettagli, multiforme nei punti di vista, e presenta «troppi lati oscuri e difficoltà all’interprete nelle sue sfumature e allusioni indirette; e soprattutto è stato troppo oscurato da secoli di oblio e di incomprensione, per essere trattato in forma adeguata in una singola opera».
Tuttavia quello che poteva essere fatto è stato fatto: è stato scoperto il filo conduttore e sono state poste, nel modo più saldo possibile, le giusti basi di ulteriori, auspicabili ricerche.
Una delle utili e auspicabili ricerche in tal senso può essere sicuramente una attenta e accurata analisi compartiva dei molti miti e leggende, sparsi in tutto il mondo e in tutte le culture umane, che testimoniano della fondamentale lotta fra la Luce e l’Oscurità, come centrale e costitutiva dello stesso processo di evoluzione umana e terrestre.
L’Autore del Segreto dei Veda vi accenna di tanto in tanto, citando miti e leggende comuni all’area mesopotamica, egizia, ellenica, mediorientale, e anche appartenenti alle culture amerinde, dei Maya o degli indiani dell’America settentrionale.
Ci sono preziose e illuminanti indicazioni di metodo, in particolare nel III capitolo dedicato alle “Teorie moderne”:
«La mitologia comparata ha deformato il senso delle prime tradizioni dell’uomo, ignorando questo stadio importante del progresso umano. Esso ha basato la sua interpretazione che vedeva il nulla tra l’antico selvaggio e Platone o le Upanishad. Ha supposto che le prime religioni siano state fondate sulla meraviglia dei barbari che all’improvviso si svegliano e rimangono stupefatti dell’esistenza di cose così strane come l’aurora, la notte e il sole, tentando di spiegare la loro esistenza in modo grossolano, rozzo, immaginifico. E da questa infantile meraviglia arriviamo con un passo alle teorie profonde dei filosofi greci e dei saggi del Vedanta. La mitologia comparata è una creazione degli ellenisti, che interpreta dati non ellenici da un punto di vista basato esso stesso su una incomprensione della mentalità greca. Il suo metodo è stato un gioco ingegnoso dell’immaginazione poetica, piuttosto che una paziente ricerca scientifica» (p. 32).
«Ci sono molte cose utili nelle speculazioni della mitologia comparata; ma perché l’insieme delle sue conclusioni sia solido e accettabile essa deve fare uso di un metodo più preciso e coerente, organizzandosi come una branca di una scienza delle religioni ben fondata. Dobbiamo riconoscere che le religioni antiche sono sistemi organici, basati su idee almeno coerenti quanto quelle che costituiscono i nostri moderni sistemi di credenze. Dobbiamo riconoscere anche che c’è stato uno sviluppo progressivo perfettamente intelligibile, fra i primi sistemi e i sistemi più recenti di fede religiosa e di pensiero filosofico. È studiando i dati in ampiezza e profondità con questo spirito, scoprendo la vera evoluzione del pensiero e del credo umano, che arriveremo a una conoscenza reale» (p. 33).
«All’origine di tutte le tradizioni umane sussiste il ricordo del passato: Indra e il serpente Vritra, Apollo e il Pitone, Thor e i Giganti, Sigurd e Fafner e gli dèi della mitologia celtica in reciproca lotta; ma è nel Veda che troviamo la chiave di queste immagini che nascondono la speranza o la saggezza di una umanità preistorica» (cap. XVIII, I progenitori umani, p. 227). Alla luce di queste fondamentali indicazioni è possibile prendere in considerazione l’evidente parallelismo che c’è fra la leggenda degli Angiras, come abbiamo visto una delle parabole centrali del Veda e il mito ripreso da Sofocle nel dramma satirico “Ichnéutai” — i ‘cercatori di tracce’ — di cui ci restano solo alcuni frammenti.