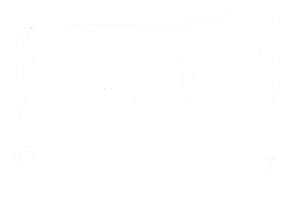Satprem
IL SEGRETO DEI VEDA
di Sri Aurobindo
Satprem, nel 1961,
scrisse il testo di un saggio mai pubblicato,
il cui titolo provvisorio era
“Sri Aurobindo o la trasformazione del mondo”
e che sarebbe stato il primo abbozzo del celebre libro
Sri Aurobindo o l’Avventura della Coscienza”.
L’introduzione di quel primo manoscritto
(che pubblichiamo integralmente qui per la prima volta
in italiano, e che in francese venne pubblicato nel 1991
con il titolo “Le Véda et la destinée humaine”)
costituiscono una analisi del testo di Sri Aurobindo
Il segreto dei Veda.
«Quello che Sri Aurobindo è venuto a compiere, altri poeti, i rishi vedici, l’avevano annunciato diverse migliaia di anni fa, nella preistoria:
Tessete un’opera inviolabile,
diventate l’essere umano, create la specie divina…
O veggenti della Verità,
affilate le lance luminose del pensiero,
aprite la strada verso ciò che è immortale;
conoscitori delle distese segrete,
formate le gradazioni per mezzo delle quali
gli dèi raggiunsero l’immortalità
(Rig Veda, X.53)
Pare che abbiamo scelto, da Adamo in qua, di mangiare il frutto dell’albero della Conoscenza. Ma non è una via che consenta mezze misure o ripensamenti; perché, se restiamo prostrati con il viso nella polvere, schiacciati da una falsa umiltà, i titani o i piccoli dèmoni che sono tra noi saranno prontissimi a impadronirsi del Potere che abbiamo rifiutato: il che è del resto quello che fanno, finendo per schiacciare il dio che è in noi. Si tratta allora di sapere — sì, o no — se vogliamo lasciare questa terra nelle mani dell’Ombra, per cercare ancora una volta di evadere nei nostri svariati paradisi; oppure se il Potere vogliamo prenderlo — trovarlo, intanto — per rifare questa terra secondo una immagine più divina; per far sì, come si esprimevano i rishi vedici, “che la terra e il cielo siano una sola e identica cosa”.
Evidentemente, c’è un Segreto da trovare, di cui recano testimonianza tutte le antiche tradizioni, siano quelle dei rishi vedici o dei magi persiani, dei sacerdoti caldei, di Menfis o dello Yucatan, degli ierofanti d’Eleusi o anche dei nostri celti. Noi abbiamo dimenticato. Abbiamo perso la Parola.
Ho trovato la Legge, il Vero, il Vasto
da cui siamo sortiti e che noi siamo.
Ho udito dalle epoche passate
la loro storia, e ho colto la Parola.
(Sri Aurobindo, Collected Poems: The Rishi)
Sri Aurobindo ha trovato la chiave che può aiutarci a operare il cambiamento necessario — un cambiamento di coscienza — e, al tempo stesso, ha ritrovato la chiave di tante tradizioni, in particolare Il segreto dei Veda, come dicevamo, poiché, finalmente, esiste un unico segreto. La luce che egli proietta sul nostro passato ci aiuterà a comprendere meglio la nostra posizione attuale nello sviluppo umano e le possibilità della nostra evoluzione futura, ma non fraintendiamo: sarebbe un errore grossolano credere che Sri Aurobindo è venuto a resuscitare delle vecchie tradizioni — “Noi non apparteniamo alle aurore del passato, ma ai meriggi del futuro” (Sri Aurobindo, Essays on the Gita) — o anche che il suo lavoro sia legato ai Veda, perché se anche egli non avesse mai appreso il sanscrito, né la sua vita né la sua opera avrebbero subito la minima modificazione; le sue scoperte antiche sono il corollario di una scoperta centrale che affonda nel passato come nel futuro e che fa apparire tutta la nostra Storia come uno sbocciare del futuro o, piuttosto, come l’immensa efflorescenza di un albero gigantesco le cui radici non si trovano in basso o dietro, ma in alto, proprio come lo avevano compreso i rishi vedici, in un eterno Presente.
Nel cuore del tempo, alti disegni sono in moto
(Sri Aurobindo, Savitri)
Leggendo per la prima volta i Veda nella traduzione dei sanscritisti occidentali o in quella dei pandit indiani, Sri Aurobindo vi aveva visto solo un documento di un certo interesse per la storia dell’India, “che sembrava però di scarso valore o importanza per la storia del pensiero o per una esperienza spirituale vivente” (Il segreto dei Veda). Quindici anni dopo, Sri Aurobindo rileggeva i Veda nell’originale, trovandovi “un filone ininterrotto dell’oro più puro di pensiero e di esperienza spirituale” (Il segreto dei Veda). Nel frattempo Sri Aurobindo aveva avuto “una serie di esperienze interiori particolari, che né la psicologia europea né le scuole yogiche e gli insegnamenti del Vedanta riuscivano a spiegare sufficientemente, e che invece i mantra vedici rischiaravano di una luce netta e precisa” (Il segreto dei Veda). Dunque, proprio perché aveva avuto delle esperienze ‘particolari’, Sri Aurobindo è stato in grado di scoprire, dall’interno, il senso vero dei Veda — e soprattutto del più antico dei quattro Veda, il Rig Veda, da lui particolarmente studiato. Il Veda non faceva che confermargli quanto aveva RICEVUTO DIRETTAMENTE. Ma già i rishi non parlavano di “parole segrete, saggezze di veggenti che solo al veggente rivelano il loro senso nascosto”? (Rig Veda, IV.3.16).
Non può dunque sorprendere che gli esegeti vi abbiano scorto essenzialmente un insieme di riti propiziatorî incentrati sul sacrificio del fuoco e su oscuri incantesimi alle divinità della natura — le acque, il fuoco, l’aurora, la luna, il sole, eccetera — al fine di ottenere la pioggia e i buoni raccolti per la tribù, figli maschi e benedizioni per i loro viaggi, oppure protezione contro i ‘ladri del sole’ — come se quei pastori fossero tanto barbari da temere che un brutto giorno il loro sole non si sarebbe più alzato perché qualcuno l’aveva rubato. Solo alcuni inni ‘più moderni’ lasciavano filtrare qua e là, come inavvertitamente, alcuni passi luminosi, i quali potevano a rigore giustificare il rispetto che le Upanishad, apparse all’inizio dell’èra storica, accordavano ai Veda. Per la tradizione indiana, infatti, le Upanishad erano diventate il vero Veda, il ‘libro della Conoscenza’; mentre il Veda, parto di una umanità ai suoi primi balbettii, sarebbe soltanto un ‘libro d’opere’, a cui tutti certo si rifacevano come a una venerabile indiscussa autorità, ma che nessuno ormai comprendeva più. Ci si può chiedere con Sri Aurobindo come mai le Upanishad, di cui il mondo intero riconosce la profonda saggezza, affermassero di ispirarsi ai Veda se i testi vedici non erano che un ordito di riti primitivi; o come mai l’umanità sia repentinamente passata da quei cosiddetti primi balbettii alla ricchezza espressiva dell’epoca upanishadica; o ancora come mai, in Occidente, sia stato possibile passare dai primitivi pastori d’Arcadia alla saggezza dei pensatori ellenici. Non è immaginabile che ci sia “un niente, tra il selvaggio primitivo e Platone o le Upanishad” (Il segreto dei Veda).
E tuttavia, gli esegeti del Veda non hanno tutti i torti, giacché i rishi vivevano nel mezzo delle tribù pastorali ed è attraverso i simboli materiali familiari che bisognava far comunicare questi uomini con ciò che oltrepassa le apparenze immediate; occorreva prenderli al punto in cui erano con i loro bisogni di sicurezza materiale e dei figli maschi robusti; ed è probabile che i loro mantra abbiano avuto il potere di rendere feconde donne sterili, che abbiano potuto proteggere le loro transumanze rischiose dai lupi o dai nemici notturni, ma avevano soprattutto, per l’iniziato, un potere di realizzazione interiore. Infatti, il Veda era un processo di divinizzazione. Era un libro delle opere, certo, e più ancora: un libro dell’Opera.
I rishi, per celare il loro segreto, beneficiavano di una lingua che non era ancora rigida. I suoni avevano un valore emotivo e determinante il senso; erano una cosa viva, creatori di idee, e avevano maggiore importanza, e soprattutto maggiore potere, delle idee che rappresentavano, mentre adesso la situazione si è capovolta, l’idea è diventata la cosa essenziale e il suono un qualcosa di secondario, oramai ogni parola significa soltanto una cosa per volta, in modo rigido, ben determinato, e i poeti se ne rammaricano (“Un’altra lingua!”, esclamava Rimbaud). Ma per il rishi, la parola non era ancora il simbolo convenzionale di una idea; quando essi utilizzavano la parola vrika, per esempio, potevano intendere colui che lacera, che divide, il dualizzatore, il nemico, e accessoriamente un lupo; la radice go poteva significare la vacca, e insieme il raggio di luce. Le parole potevano dunque essere impiegate nel loro senso oggettivo o nel loro senso soggettivo ed è proprio su questo doppio senso, spesso triplo, che venne creato il Veda; triplo senso, perché non erano delle idee che i rishi cercavano di trasmettere, ma delle esperienze, delle illuminazioni, e solo il simbolo poteva servire da veicolo alla visione; erano kavi, ossia ‘veggenti della Verità’, e questo termine era sinonimo di poeta.
Questa poesia, arde dappertutto negli inni del Rig Veda che Sri Aurobindo ha decifrato in maniera così meravigliosa; non è certo un caso che il fuoco, Agni, fosse al centro dei misteri vedici: Agni, la fiamma interiore, l’anima dentro di noi (chi non sa che l’anima è di fuoco?), l’aspirazione innata che trascina l’uomo verso l’alto; Agni, la volontà ardente di ciò che da sempre vede e si ricorda in noi; Agni, ‘il sacerdote sacrificale’, ‘l’operaio divino’, ‘il mediatore fra la terra e il cielo’ (Rig Veda, III.3.2) che “sta al centro della dimora” (Rig Veda, I.70.2). “I Padri che posseggono la visione divina lo hanno posto lì dentro, come un infante che deve nascere (Rig Veda, IX.83.3). È “l’infante nascosto nella caverna segreta” (Rig Veda, V.2.1). “Egli è come la vita e il respiro del nostro esistere, è come il nostro eterno bambino” (Rig Veda, I.66.1). “O figlio del corpo (III.4.2), o Fuoco, figlio del cielo attraverso il corpo della terra” (III.25.1). “Immortale nei mortali” (IV.2.1), vecchio e malandato, egli ridiventa giovane ancora e ancora” (II.4.5). “Quando egli nasce, diventa la voce della divinità, quando è stato formato dentro la madre, come la vita che cresce nella madre, muovendosi diventa il galoppare del vento” (II.29.11). “Quando bene ti portiamo in noi, o Fuoco, tu diventi la crescita suprema e il supremo espandersi del nostro essere; ogni gloria e ogni bellezza è presente nelle tue desiderabili tinte, nella tua visione perfetta. O Distesa, tu sei la pienezza che ci porta al termine del cammino, sei una moltitudine di ricchezze traboccanti da ogni dove” (II.1.12). “O Fuoco… che vedi con visione divina, oceano vivente di luce (III.22.2), o Fiamma dai cento tesori… o tu che conosci tutte le cose nate” (I.5.9).
Noi però non siamo gli unici a avere il privilegio del fuoco divino. Agni non si trova soltanto nell’uomo: “È il figlio delle acque, il figlio delle foreste, il figlio delle cose immote e il figlio delle cose che si muovono. Anche nella pietra, egli è presente” (I.70.2).
E il sacrificio vedico non è soltanto un rituale esteriore, ma il grande Rito interiore attraverso il quale l’uomo si trasforma in Dio; è l’offerta, nella Fiamma, di tutto quanto ci mette i bastoni tra i piedi e impedisce la nostra divinità; è ‘un viaggio’, una ‘ascensione sulla montagna’, una lunga transumanza attraverso varî pericoli. I rishi non erano monaci sognatori, ma ariani (che rappresenta una qualità d’anima, non una qualità razziale, dato che il sanscrito arya significa colui che lavora, lotta e sale verso le cime), erano dei guerrieri della Luce e viaggiatori della Verità. Gli dèi ai quali essi offrivano il sacrificio non erano delle immagini ma delle potenze cosmiche reali che aiutavano la nostra ascesa verso l’immortalità, amritam: “Che ci sia tra voi e voi, o dèi, questa antica amicizia!”, gridavano i rishi (Rig Veda, VI.18.5), e gli dèi non erano lontani, aiutavano gli uomini, e non chiedevano che di vederli crescere in forza e luce. Per i rishi, in effetti, il mondo non si limitava alla ristretta visione mentale, era una ‘tiara ascendente’, una gradazione ininterrotta di ‘piani segreti’ che esistevano in noi e al di fuori di noi, oggettivamente e soggettivamente. Oggettivamente, il mondo era composto — e lo è tuttora! — di una serie di piani di coscienza cosmici (la mente è uno di essi, piuttosto basso nella scala), ognuno con i suoi dèi e i suoi esseri particolari, e questi piani cosmici erano collegati al nostro essere individuale, soggettivo, da un certo numero di punti di raccordi interiori o di ‘centri’ (che la fisiologia indiana chiama cakra), generalmente assopiti nell’uomo ordinario, ma che possono risvegliarsi con il fuoco dell’aspirazione — Agni, ancora — e, spezzando i nostri angusti limiti, metterci in contatto con le vastità dei mondi, con la nostra vastità: “Senza sforzo, i mondi si muovono l’uno nell’altro” (Rig Veda, II.24.5). Non si tratta dunque, per i rishi, di restare chiuso nella propria corazza, ma non si tratta nemmeno di evadere in un Assoluto ineffabile! Bisognava crescere in coscienza e conoscere tutte le ‘dimore’ del nostro reame; occorre imboccare ‘i nostri diversi sentieri’, ‘nascere’ alla totalità del nostro essere, poiché i mondi erano chiamati anche le ‘nascite’ ed era necessario nascere sette volte per possedere l’esistenza spirituale completa: “Nell’ignoranza della mia mente, chiedo quali sono queste gradazioni che gli dèi hanno posto all’interno. Gli dèi onniscienti hanno preso l’Infante di un anno e hanno tessuto sette fili attorno a lui per costruire questa trama” (Rig Veda, I.164.5).
Gli dèi non sono dunque soltanto delle potenze esteriori, oggettive, ma anche potenze interiori, poiché ogni volta che noi ‘nasciamo’ a un altro mondo, questo significa, innanzitutto, che noi abbiamo fatto nascere in noi il dio corrispondente a questo mondo o, come diremmo con un linguaggio moderno, che ci siamo elevati nella nostra coscienza, altrimenti non ci sarebbe stata congiunzione, e in questo modo noi diamo nascita a divinità sempre più grandi, ovvero eleviamo sempre più la nostra coscienza e cresciamo in divinità e in vastità. Viene detto, in effetti, che gli dèi ‘nascono’ in noi, che i Padri degli uomini “foggiarono gli dèi come un fabbro lavora la materia grossolana nella sua fucina” — e che crescendo in noi, essi “aumentano la nostra terra e il nostro cielo” (cioè la capacità della nostra esistenza fisica e mentale), “Che gli dèi siano in tutte le dimore!”, grida il cantore vedico (Rig Veda, IV.1.18). Noi dobbiamo dunque creare gli dèi a nostra volta, dopo che essi ci hanno creato, poiché la causa prima è anche il risultato ultimo: “Libera tuo padre! nella coscienza proteggilo — tuo padre che diviene il figlio e che ti conduce” (Rig Veda, V.3.9). In nessun passo dei Veda si parla di soprannaturale o di miracoloso (“il soprannaturale — dice Sri Aurobindo — è un naturale che non abbiamo ancora raggiunto, o che non conosciamo ancora, o di cui non possediamo ancora la chiave”), tutto è frutto di una cultura di sé progressiva, di un lungo viaggio disseminato di trappole, di una paziente conquista sulle forze d’oscurità, fino al giorno in cui la Fiamma è sufficientemente cresciuta in noi per superare i suoi limiti; allora si compie la redenzione completa, ‘la nascita del Figlio per mezzo del sacrificio’: “L’abbiamo vista, la sua massa di rosso ardente — un grande dio è stato liberato dall’oscurità” (Rig Veda, V.1.2).
Ma non siamo ancora arrivati al nocciolo del segreto vedico. La nascita di Agni, nell’anima — sono tanti gli uomini non ancora nati —, è soltanto l’inizio del viaggio. Questa fiamma interiore è qualcosa che cerca, è il ‘cercatore’ in noi: è una scintilla del grande primo Fuoco, che non si sentirà appagata fino a quando non avrà ritrovato la propria totalità solare, quel ‘sole perduto’ di cui i Veda parlano di continuo. Ma quando ci saremo innalzati di piano in piano, e la Fiamma sarà successivamente ascesa nel triplice mondo della nostra esistenza inferiore fisica, vitale e mentale, essa non si sentirà ancora appagata, perché vorrà salire ancora e ancora. Arriviamo allora a una frontiera mentale in cui sembra che non ci sia più niente da stringere tra le braccia, più niente nemmeno da vedere; dove sembra che dobbiamo abolire tutto per tuffarci nell’estasi di una immensa Luce. Percepiamo allora tutt’intorno, con dolore quasi, questa corazza di materia che ci tiene imprigionati e che ci impedisce l’apoteosi della Fiamma; comprendiamo allora il grido di colui che diceva: “Il mio regno non è di questo mondo”, e i saggi dell’epoca del Vedanta in India, e forse i saggi di tutte le religioni, che non hanno mai cessato di dire: “Bisogna lasciare questo corpo per poter abbracciare l’Eterno”. La nostra fiamma resterà allora per sempre mutila quaggiù, il nostro cercare andrà sempre deluso? Dovremo sempre scegliere fra la terra e il cielo, rinunciando a questa per quello?
Ma al di là del triplice mondo inferiore, i rishi avevano scoperto ‘un certo quarto’, turiyam svid; avevano trovato ‘la vasta dimora’, ‘il mondo solare’, Svar: “Mi sono innalzato dalla terra al mondo di mezzo [la vita]; mi sono innalzato dal mondo di mezzo fino al cielo [la mente]; e dal firmamento celeste sono giunto fino al mondo solare, alla Luce” (Yajur Veda, 17.67). Ed è detto: “Mortali, essi raggiunsero l’immortalità” (Rig Veda, I.110.4). Qual è dunque il loro segreto? Come hanno fatto a passare dal ‘cielo mentale’ al ‘grande cielo’ senza lasciare questo corpo, senza dissolversi nell’estasi, se così possiamo dire?
Il segreto è nella materia. Perché è nella materia che sta rinchiuso Agni e stiamo rinchiusi noi. Agni è detto ‘senza testa né piedi’, ‘quello che nasconde le sue due estremità’ del sopracosciente (che i rishi chiamavano ancora ‘il grande oceano’), e in basso sprofonda nell’‘oceano informe’ dell’incosciente (che loro chiamavano anche ‘la roccia’). Noi, invece, siamo monchi. Ma i rishi erano uomini di saldo realismo, di un realismo vero, basato sullo Spirito; e poiché le vette mentali si aprivano su una lacuna di luce, estasiante, certo, ma senza presa sul mondo, essi si misero in cammino per la via che scende. Comincia allora la ricerca del ‘sole perduto’, il lungo ‘pellegrinaggio’ della discesa nell’incosciente e la lotta senza tregua contro le forze oscure ‘ladre di sole’, contro pani e vritra, pitoni e giganti nascosti nel ‘recinto oscuro’ insieme a tutta la coorte degli usurpatori; quelli che dualizzano, che ostruiscono, che lacerano, CHE COPRONO. Ma ‘l’operaio divino’, Agni, viene aiutato dagli dèi e condotto nella sua ricerca dal ‘raggio intuitivo’, Sarama, la cagna celeste dal fiuto sottile, che lo mette sulla pista delle ‘greggi rubate’ (strane greggi, che ‘brillano’). E di quando in quando sfolgora una fuggevole aurora, poi tutto svanisce; bisogna avanzare a piedi, ‘scavare e scavare’, lottare contro ‘i lupi’, sempre più scatenati quanto più ci si approssima alla tana. Ma Agni è un guerriero. Agni cresce proprio attraverso le difficoltà che incontra, la sua fiamma si fa sempre più viva sotto i colpi dell’Avversario. I rishi non solo dicevano che “la Notte e il Giorno allattano entrambi l’Infante divino”; dicevano pure che la Notte e il Giorno sono “due sorelle immortali che hanno il medesimo amante [il Sole]… Unite esse sono, benché diverse di forma” (Rig Veda, 113.2-3). L’alternarsi di chiarore e oscurità diventa sempre più rapido, finché sorge il Giorno e ‘le greggi dell’Aurora’ [ricordiamo Omero e ‘le greggi di Helios’] si alzano, “svegliando qualcuno che era morto” (Rig Veda, I.113.8). ‘La roccia senza fine’ dell’incosciente si spacca, il cercatore discopre ‘il sole che dimora nell’oscurità’ (III.39.5): la coscienza divina nel cuore della Materia.
Questo è il segreto dei Veda, la vittoria dei sette rishi Angirasa e dei Navagva che scoprirono “il cammino degli dèi”: “I nostri padri, grazie ai loro mantra, distrussero i baluardi più ostinati; con il loro urlo, i veggenti Angirasa fecero a pezzi la roccia della montagna; costruirono in noi un cammino verso il Grande Cielo, scoprirono il Giorno e il mondo solare e il raggio intuitivo e le greggi della luce” (Rig Veda, I.71.2). “La collina feconda si aprì in due liberando la nascita suprema… un dio ha aperto le porte umane” (Rig Veda, V.45). Al fondo del fondo della Materia (cioè del corpo, della terra), i rishi erano stati precipitati nella Luce — quella medesima Luce che altri cercavano in alto, nell’estasi al di fuori del corpo e della terra. È quello che i rishi chiamarono ‘il Grande Passaggio’. Avevano trovato, senza lasciare la terra, ‘la vasta dimora’ che è ‘la dimora medesima degli dèi’, Svar, cioè il mondo solare originario che Sri Aurobindo chiama mondo sopramentale: “Esseri umani [i rishi sottolineano di essere degli uomini], dopo aver messo a morte colui-che-ricopre, attraversarono la terra e il cielo [cioè la materia e la mente] e fecero del vasto mondo la loro dimora” (Rig Veda, I.36.8). Erano entrati ‘nel Vasto, nel Vero, nell’Esatto’, Brihat, Satyam, Ritam, ‘nella luce che non s’infrange’, nella ‘luce che non teme’, poiché lì non esiste più sofferenza né falsità né morte: è l’immortalità, amritam. E il Veda ci offre la sua alta visione unificatrice che illuminerà l’India fino ai giorni nostri: “C’è una Verità nascosta da una verità, là dove vengono liberati i cavalli del sole; i diecimila si tengono insieme: c’era Questo Uno. Ho visto la forma del più grande degli dèi incarnati” (Rig Veda, V.62.1). Questa verità che nasconde la Verità, è l’apogeo del mentale, la mistica frontiera dove il cercatore sbocca nell’estasi, credendo di avere trovato la Verità suprema; è il ‘coperchio d’oro’ di cui parlerà più tardi l’Upanishad. Ma i rishi avevano trovato la Verità che sta oltre questa verità, il luogo in cui i diecimila raggi delle nostre illuminazioni e delle nostre verità inferiori si raccolgono in un grande Corpo solare, avevano visto il Corpo glorioso di cui tutti gli dèi sono poteri viventi — tad ekam, Questo Uno; tat satyam, Questa Verità. “L’Essere è uno — dice il rishi Dirghatamas — ma i saggi lo esprimono in vario modo: dicono Indra, Varuna, Mitra, Agni; lo chiamano Agni, Yama, Matarisvan…” (Rig Veda, I.164.46).
Ma questa visione solare non annulla la nostra terra, la completa: “Allora, in verità, essi si risvegliarono e videro totalmente. Dietro di loro, attorno a loro e dappertutto, ebbero, invero, l’estasi stessa di cui si gode nel cielo. In tutte le case chiuse dimoravano tutti gli dèi” (Rig Veda, IV.1.18). Il Sole ha invaso tutte le nostre abitazioni, ha preso possesso di tutte le nostre azioni e dei nostri movimenti; la Felicità divina è scesa fin nelle cellule del nostro corpo come un vino: “O Fiamma, o vino, la tua forza eroica è diventata cosciente” (Rig Veda, I.93.4). Il liquore d’immortalità fluisce nelle nostre vene. Soma, l’ambrosia che non costituisce tanto l’immortalità di un corpo ma la conquista della nostra coscienza divina sulla sommità della montagna eterna. Ma guai a chi non è pronto, “si spezza come la giara mal cotta”, poiché non riesce a contenere l’Intensità: “non gusta questa felicità colui che non è ben saldo e il cui corpo non ha sopportato il calore del fuoco; soli possono sopportarlo e goderne quanti sono stati preparati dalla fiamma” (Rig Veda, IX.83.1). Il rishi ha attraversato tutte le prove, è ormai stabilito nella “sua alta fondazione” (III.55.7) e possiede anche, nel suo corpo, su questa terra, ‘le due nascite’, umana e divina, “eterne e in un medesimo nido”, “come uno che gode le sue due donne” (I.62.7).
Tutto si riconcilia. Il rishi è ‘il figlio delle due Madri’: è figlio di Aditi, la vacca luminosa, la Madre dell’infinita luce, la creatrice dei mondi; ma è anche figlio di Diti, la vacca nera, la Madre delle ‘tenebre infinite’ e dell’esistenza divisa; poiché alla fine Diti, al termine della notte apparente, ci dà il latte del cielo e la nascita divina. Tutto si compie. Il rishi accoglie in un medesimo fluire le forze umane e le cose divine (Rig Veda, IX.70.3), ha realizzato l’universale nell’individuale, è diventato l’Infinito nel finito; “Allora la tua umanità diverrà simile all’opera degli dèi, come se il cielo di luce si fondasse visibilmente in te” (Rig Veda, V.66.2). E lungi dal rifiutare la terra, il rishi prega: “O divinità, serba per noi l’Infinito e prodigaci il finito” (Rig Veda, IV.2.11).
Il viaggio si compie. Agni ha ritrovato la sua totalità solare, le sue due estremità nascoste. ‘L’opera inviolabile’ è compiuta, poiché Agni è il luogo in cui l’alto e il basso si incontrano. Ma in verità non esiste né alto né basso; non esiste altro che un unico Sole dovunque: “O Fiamma, tu sali all’oceano del cielo verso gli dèi; tu fai incontrare le divinità dei piani, le acque che si estendono nel regno di luce al di sopra del sole e le acque che si estendono in basso” (Rig Veda, III.23.3). “O Fuoco, o divinità universale, tu sei il nodo ombelicale di tutte le terre e dei loro abitatori. Tu guidi tutti gli uomini nati, e come un pilastro li sostieni” (Rig Veda, I.59.1); “O Fiamma, tu fai fondere ciò che è mortale in una suprema immortalità… Tu crei la felicità divina e la gioia umana” (Rig Veda, I.31.7).
Perché la Gioia è il cuore del mondo, sta al fondo delle cose, è “il pozzo di miele coperto dalla roccia” (Rig Veda, II.24.4).
Dandoci la chiave del segreto dei Veda, ultimo testamento delle età dell’Intuizione, Sri Aurobindo ci ha forse dato la chiave di tutte le tradizioni, dalla Persia all’America centrale e alle rive del Reno, il segreto di tutti i cercatori della perfezione, da Eleusi ai catari, ai Cavalieri della Tavola Rotonda, agli alchimisti, poiché sembra di ritrovare dappertutto questa antica Memoria di una grande verità trasformatrice e del suo oscuramento, e della Ricerca, e della battaglia degli eroi della Luce contro le forze ostili, la lotta di Apollo contro il Pitone, di Indra contro il serpente Vritra, di Thor contro i Giganti, di Sigurd contro Fafner. È il mito solare dei Maya, la discesa di Orfeo, la Trasmutazione. È il serpente che si morde la coda. Ma in nessuna altra tradizione troviamo la totalità del Segreto in modo così puro, e ci meravigliamo di fronte a questi conquistatori vedici: “Non avevano probabilmente aggiogato il fulmine ai loro carri, né pesato il sole e le stelle, né materializzato tutte quelle forze distruttrici della natura per farne agenti di massacro e di dominio, ma avevano misurato tutti i cieli e tutte le terre che sono dentro di noi, avevano sondato l’incosciente e il subcosciente e il sopracosciente; avevano decifrato l’enigma della morte e trovato il segreto dell’immortalità… E, soprattutto, avevano questa ‘luce ariana’, questa garanzia e questa gioia, questa amicizia da pari a pari con gli dèi che l’ariano apportava con sé nel mondo” (Sri Aurobindo, Il segreto dei Veda)».