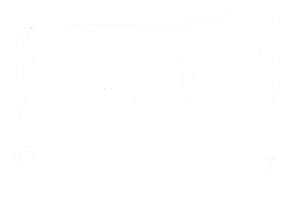IL SEGRETO DEI VEDA
svelato da Sri Aurobindo
Sri Aurobindo, in una serie di articoli
scritti e pubblicati tra il 1918 e il 1921,
in seguito raccolti sotto il comune titolo
“The Renaissance in India”,
offre alcune riflessioni sulla cultura indiana,
esaminandone i suoi varî aspetti:
letterario, artistico, filosofico, spirituale.
Vi sono qui e là alcune osservazioni sui Veda
che sembrano scritte come una introduzione ideale
al libro Il segreto dei Veda.
«I Veda sono la creazione di una antica forma mentale intuitiva e simbolica alla quale la mentalità successiva dell’uomo, fortemente intellettualizzata e governata da un lato dall’idea razionale e da concezioni astratte, dall’altro dai fatti della vita e della materia accettati per come essi si presentano ai sensi e all’intelligenza senza ricercare in essi alcun significato divino o mistico, abbandonandosi all’immaginazione come gioco della creatività estetica piuttosto che come possibilità di apertura delle porte della verità e confidando nei suoi suggerimenti solo quando essi sono confermati dalla ragione o dall’esperienza fisica, esclusivamente consapevole di intuizioni prudentemente intellettualizzate e recalcitrante verso la maggior parte delle altre, è cresciuta totalmente estranea.
Non è dunque per nulla sorprendente che i Veda siano diventati incomprensibili alle nostre menti tranne che nel loro aspetto linguistico più esteriore e conosciuti inoltre molto imperfettamente a causa dell’ostacolo costituito da una lingua antica e non pienamente compresa, e che siano state rese le più inadeguate interpretazioni per ridurre questa grande creazione di una mente umana giovane e splendida a uno scarabocchio pasticciato e mutilato, a un miscuglio incoerente di assurdità da parte di una immaginazione primitiva tesa a complicare ciò che altrimenti sarebbe assai semplice, uniforme e comune testimonianza di una religione naturalistica che rispecchiava esclusivamente e poteva servire unicamente i rozzi e materialistici desiderî di una barbara mentalità di vita.
I Veda divennero poi, per l’idea scolastica e ritualistica dei preti hindu e dei pandit [eruditi], niente di più che un libro di mitologia e di cerimonie sacrificali; gli studiosi europei, ricercando in essi solo ciò che era di un qualche interesse razionale — la storia, i miti e le nozioni religiose popolari di una etnia umana primitiva — hanno tuttavia fatto il torto peggiore ai Veda e insistendo su una interpretazione totalmente esteriore li hanno spogliati ancor più del loro interesse spirituale e della loro bellezza e grandezza poetica.
Ma così non era per i rishi vedici o per i grandi veggenti e pensatori che li seguirono e svilupparono dalle loro intuizioni luminose e pregnanti una propria, meravigliosa struttura di pensiero e parola costruita su una rivelazione spirituale e una esperienza senza precedenti. I Veda furono per questi antichi veggenti il Mondo che scopriva la Verità rivestendo di immagini e di simboli i significati mistici della vita.
Fu una scoperta e uno svelarsi divini della potenza della parola, della sua misteriosa capacità di rivelazione e di creazione, non la parola dell’intelligenza logica, razionale o estetica, ma quella di una ritmica espressione intuitiva e ispirata, il mantra.
Immagine e mito vennero liberamente usati, non come un indulgere all’immaginazione ma come simboli e parabole viventi di cose estremamente reali per chi le pronunciava e che non potevano trovare altrimenti la loro forma espressiva più intima e originale, e l’immaginazione stessa diventava l’officiante sacro di realtà più grandi di quelle che incontrano e trattengono l’occhio e la mente limitati dalle suggestioni esterne della vita e dell’esistenza materiale.
Questa era la loro concezione del poeta sacro: una mente visitata da qualche più alta luce e dalle sue forme in idea e parola, un veggente e un uditore della Verità, kavayah satyashrutayah.
I poeti dei versi vedici non contemplavano la propria funzione come è immaginata dagli studiosi moderni, essi non si consideravano una sorta di sciamani compositori di inni e di formule magiche al vertice di una rozza e barbara tribù, ma veggenti e pensatori, rishi dhira.
Questi cantori erano convinti di possedere una alta verità mistica e occulta, certi di essere i latori di un linguaggio idoneo a una conoscenza divina, e parlavano esplicitamente delle loro forme espressive come di parole segrete che mostrano il proprio completo significato solo al veggente, kavaye nivacanani vacamsi. E per quelli che vennero dopo di loro i Veda furono libri di conoscenza, e proprio della conoscenza suprema, una rivelazione, una grande espressione di eterna e impersonale verità vista e udita nell’esperienza interiore di pensatori ispirati e semidivini.
Le circostanze più esteriori delle cerimonie sacrificali per le quali gli inni furono scritti sostenevano un significante potere simbolico e psicologico, come era ben noto agli autori degli antichi Brahmana.
I versi sacri, ciascuno in se stesso tenuto a essere colmo di un significato divino, furono intesi dai pensatori delle Upanishad come le profonde e pregnanti parole originarie delle verità che essi cercavano, e la più alta legittimazione che potevano dare alle loro espressioni sublimi fu una citazione dei loro predecessori con la formula tad esha ricabhyukya — “questa è la parola che fu pronunciata nel Rig Veda”.
Ma il semplice buon senso dovrebbe dirci che coloro che furono così vicini, in tutti i sensi, ai poeti originali, dovevano possedere una migliore possibilità di fare propria almeno la verità essenziale sulla questione e ci suggerisce la forte probabilità che i Veda furono realmente ciò che pretendono essere: la ricerca verso una conoscenza mistica, la prima forma del costante tentativo della mente indiana, al quale essa è sempre stata fedele, di guardare oltre le apparenze del mondo fisico e, attraverso la propria esperienza interiore, alla divinità, ai poteri, alla immanenza dell’Uno del quale i saggi parlano in molti modi — la famosa frase nella quale i Veda esprimono il loro più centrale segreto, ekam sad vipra bahudha vadanti.
Il carattere più vero dei Veda può essere meglio compreso esaminandoli in qualsiasi punto e interpretandoli chiaramente in relazione alle loro frasi e immagini… se li leggiamo per quello che sono senza nessuna falsa traduzione in ciò che pensiamo dovrebbero avere detto dei barbari primitivi, troveremo invece una poesia sacra suprema e potente nelle sue parole e nelle sue immagini, sebbene in altro genere di linguaggio e di fantasia creativa rispetto a quelli che noi oggi prediligiamo e apprezziamo, profonda e sottile nell’esperienza psicologica e stimolata da un’anima di visione e espressione profondamente partecipe».
«I poeti dei Veda possedevano una mentalità diversa dalla nostra, il loro uso delle immagini è di un genere particolare e una antica tendenza della loro capacità visiva conferisce un profilo strano alle loro espressioni.
Il fisico e i mondi fisici furono ai loro occhi una manifestazione, una duplice e varia e tuttavia connessa e omogenea rappresentazione di divinità cosmiche, la vita interiore e esteriore dell’uomo, una divina relazione con gli dèi, e dietro ogni realtà esisteva l’unico Spirito o Essere del quale gli dèi erano nomi e personalità e poteri.
Queste divinità erano a un tempo signori della natura fisica e delle sue forme e dei suoi principî; i loro dèi, i loro corpi e gli intimi poteri divini con le loro corrispondenti condizioni e energia sono innati nel nostro essere psichico perché essi sono i poteri spirituali dell’universo, i guardiani della verità e della immortalità, i figli dell’infinito e ciascuno di essi è anche nella sua origine e nella sua realtà ultima lo Spirito supremo che pone in evidenza uno di questi aspetti.
La vita dell’uomo era per questi veggenti una realtà combinata di verità e menzogna, un movimento dal mortale alla immortalità, da una commistione di luce e di oscurità allo splendore di una Verità divina la cui dimora è al di sopra, nell’Infinito, ma che può essere costruita nell’anima e nella vita dell’uomo, una battaglia tra i figli della Luce e quelli della Notte, l’ottenimento di un tesoro, della vera ricchezza, la ricompensa garantita dagli dèi all’uomo guerriero, un’avventura e un sacrificio; e di questa realtà essi parlarono all’interno di un sistema stabilito di immagini prese dalla natura e dalla circostante vita guerriera, pastorale e agricola della gente ariana, centrato intorno al culto del Fuoco, all’adorazione dei poteri viventi della Natura e alle cerimonie del sacrificio.
Ogni dettaglio dell’esistenza profana e del sacrificio erano simboli nella loro vita e nelle loro attività, nella loro poesia, non simboli morti o metafore artificiali, ma viventi e potenti suggestioni, controparti di realtà interiori. E essi usavano inoltre nella loro espressione un corpo stabilito e tuttavia vario di altre immagini e uno splendido tessuto di mito e parabola, immagini che diventavano parabole, parabole che diventavano miti, miti che restavano comunque immagini, e tuttavia tutte queste cose costituivano per essi, in un modo che può essere compreso solo da coloro che sono penetrati all’interno di un certo genere di esperienze psichiche, realtà effettive.
Il fisico scioglieva le sue ombre negli splendori dello psichico, lo psichico cresceva nella luce dello spirituale e non esisteva alcuna linea netta di demarcazione in questi passaggi, ma una fusione naturale e una compenetrazione delle loro suggestioni e dei loro colori.
È evidente che una poesia di questo genere, composta da uomini con questo tipo di visione o immaginazione, non può essere né interpretata né giudicata dai modelli di una ragione e di un gusto fedeli ai soli canoni dell’esistenza fisica».
«I poeti vedici sono maestri dalla tecnica consumata, i loro ritmi sono scolpiti come carri degli dèi e trasportati da grandi e divine ali di suono a un tempo concentrati e dilatati, ampi nel movimento e sottili nella modulazione, il loro discorso è lirico per intensità e epico per elevazione, una espressione di grande potere, pura e intrepida e dallo splendido profilo, dall’effetto diretto e incisivo, pienamente profusa di senso e di suggestione così che ogni singolo verso esiste allo stesso tempo come cosa definita e autonoma e come ampia connessione tra ciò che è venuto prima e quanto lo segue.
Una sacra tradizione sacerdotale scrupolosamente osservata diede loro sia forma che significato, ma questo significato consisteva nelle più profonde esperienze psichiche e spirituali delle quali l’anima dell’uomo è capace e raramente o mai le forme degeneravano in convenzione, poiché ciò che dovevano trasmettere era vissuto interiormente da ogni poeta e rinnovato in espressione nella propria mente attraverso le sottigliezze e le maestrie della visione individuale. Le voci dei più grandi veggenti, Vishvamitra, Vamadeva, Dirghatamas e molti altri, toccano le più alte vette e latitudini di una poesia mistica e sublime.
Lo spirituale, l’infinito è vicino e reale e gli dèi sono reali e i mondi interiori non tanto al di là quanto immanenti alla nostra esistenza».