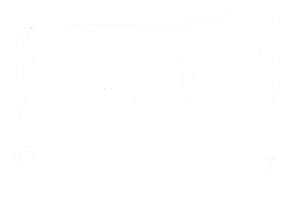Tommaso Iorco
DAI VEDA A KALKI
- l’India nel disegno terrestre -
aria nuova edizioni
(684 pagine totali)
Riportiamo qui un breve stralcio
tratto da ciascun capitolo del libro, al fine di offrire un piccolo assaggio
che possa eventualmente stimolare
la lettura integrale del testo.
• dalla Introduzione:
«Occorre sapersi accostare con sufficiente apertura mentale, per accorgersi che l’India ha avuto prevalentemente un atteggiamento positivo nei confronti della vita, e ciò si tradusse attraverso la costruzione di civiltà superbe e raffinatissime. “Compiendo le opere in questo mondo, l’uomo desideri pure vivere cent’anni; così sia anche per te, ma l’azione non si attacchi all’uomo”, esorta senza mezzi termini l’antichissima Îsha Upanishad. E sulla stessa linea, tutte le maggiori Upanishad insistono su una vasta realizzazione spirituale che porti con sé, come sua diretta e naturale conseguenza, una grande prosperità terrestre, come nel caso della Taittirîya Upanishad, contenente un ripetuto invito, chiaro e inequivocabile, a non rigettare la materia (annam na nindhyât, annam na paricakshita) — “grande è la gloria di colui che gode della materia ed è posseduto da essa, ricco d’armenti… e colmo di gloria”, annâdo annavân kîrtyâ mahân pashubhih saha. Quanti hanno compiuto un approfondito esame sull’argomento, hanno potuto constatare come le scoperte effettuate dai ricercatori indiani abbraccino tutti i dominî dello scibile degli antichi: matematica, fisica, chimica, astronomia, grammatica, medicina, chirurgia — e questo sarebbe stato impossibile se il popolo indiano avesse avuto una propensione esclusiva verso l’astrazione metafisica. Per limitarci a qualche esempio, molti secoli prima di Galileo, un astronomo indiano si accorse che la terra, sebbene paia immobile, è un corpo in movimento, calâ prithvî sthirâ bhâti. Noi tutti attribuiamo a Newton la scoperta della forza di gravità, tuttavia nel Surya Siddhanta, un testo datato intorno al 400 a.C., Bhaskara dice: “gli oggetti cadono a terra a causa di una determinata forza. La Terra, i pianeti, le costellazioni, la luna e il sole sono mantenuti in orbita a causa di questa stessa forza”. Così come è riconosciuto il fatto che ai matematici indiani appartenga la scoperta del sistema metrico decimale, l’estrazione delle radici quadrate (karni), i numeri ‘arabi’ (compreso lo zero), il raggio del cerchio (trijyâ) e il ‘pi greco’ (ove la ‘p’ è la prima lettera del sanscritoparidhi vyâs anupât, ossia “rapporto tra la circonferenza e il suo diametro”). Il matematico statunitense A. Seidenberg ha dimostrato come la geometria greca, egizia e babilonese (compreso lo stesso teorema di Pitagora) derivi dai concetti matematici indiani contenuti nei Sulba-Sûtra, la cui datazione non può essere posteriore al 2000 a.C., data del Medio Regno dell’Egitto e dell’Antico Impero Babilonese in cui per la prima volta compaiono tali conoscenze. Voltaire nel 1773 fece notare che “2500 anni or sono Pitagora partì da Samo per recarsi sulle rive del Gange a studiare la geometria… Egli non avrebbe sostenuto un viaggio così arduo se la reputazione della scienza brahmanica non fosse stata riconosciuta in Europa… Sappiamo che l’aritmetica, la geometria, l’astronomia erano ben note ai brahmani. Da tempi immemorabili essi conoscevano gli equinozi, e i loro calcoli erano assai più precisi di quelli realizzati molto più tardi dai greci” (Fragments historiques sur l’Inde). Non a caso lo scienziato Jakob Robert Oppenheimer considerava “l’accesso ai Veda il più grande privilegio che il XX secolo può rivendicare sui secoli precedenti”.
Quel che in proposito si può affermare, è che la scienza, in India, non è mai stata considerata la ricerca principale, bensì un potere ausiliario della conoscenza spirituale. “Che me ne farò di tutto questo — grida la Brihadâranyaka Upanishad, — se non mi porta il nettare dell’immortalità?”. Ma tale atteggiamento, anziché risultare riduttivo, è al contrario un attestato di grandezza degli antichi ricercatori (nel caso della Chiesa cattolica, che come sappiamo spesso e volentieri cercò di reprimere con ogni mezzo l’indagine scientifica, ciò avvenne per il fatto che tale istituzione non rappresentò mai la conoscenza spirituale, bensì il dogma religioso, che è ben altra cosa — lo stesso Galileo, d’altronde, era un uomo di scienza e al tempo stesso un autentico uomo di fede, assai più genuino degli ecclesiastici bigotti che lo condannarono). William Macintosh, sulla falsariga di Voltaire, ribadì in tempi più recenti che “tutta quanta la storia indica l’India come la madre della scienza e dell’arte… Questo paese nei tempi antichi era talmente rinomato per la sua conoscenza e saggezza che i filosofi greci non disdegnarono di viaggiare fin laggiù per approfondire le loro conoscenze” (Les Indes florissantes: Anthologie des voyageurs français). Sulla medesima linea, il naturalista francese Pierre Sonnerat, riconobbe che “si trovano in India le vestigia della più remota antichità… Sappiamo infatti che tutti i popoli si sono recati colà per trarre gli elementi della propria conoscenza… L’India, nel suo splendore, ha distribuito i suoi doni a tutti gli altri popoli; l’Egitto e la Grecia hanno tratto da lei i loro miti e la loro saggezza” (ib.). Le scienze, al pari di poesia, canto, danza, musica, arte drammatica, scultura e architettura, erano considerate espressioni di una ricca fioritura spirituale ed erano tutte materie da porre con reverenza ai piedi dei rishi, i quali peraltro erano costantemente preoccupati a indicare che solo dopo essersi saldamente stabilito nel finito, l’uomo può sperare di raggiungere con efficacia l’Infinito — l’Oltretempo può essere còlto con pienezza solo da colui che si è lasciato modellare dal tempo, diventando in tal modo un essere umano compiuto. “Proteggete i sentieri radiosi aperti dal pensiero, DIVENTATE L’ESSERE UMANO, CREATE LA RAZZA DIVINA, aguzzate le lance di luce per progredire verso ciò che è immortale”, ammonivano gli antichi veggenti (Rig Veda, X.53). L’aspetto dinamico del Divino non era affatto considerato antitetico al suo aspetto statico, né il suo moto perpetuo costituiva un bizzarro girare senza senso. È vero che la mitica “Ruota del Brahman” viene descritta come roteante in eterno su se stessa, ma mai nello stesso punto: essa procede sempre in avanti, verso una formula di perfezione perpetuamente progressiva».
dal capitolo 1. I Rishi vedici:
«Gli dèi vedici sarebbero dei simboli. Ma che cosa è in realtà per noi un simbolo? Quando si vuole rendere maggiormente comprensibile all’uomo un certo ordine di cose al quale egli normalmente non può avere accesso, viene usata una trasposizione, che noi chiamiamo per l’appunto simbolo. Così accade con certe immagini oniriche, o con talune visioni di mondi o di esseri ultrafisici (che prendono sfumature differenti a seconda del background psicologico del destinatario — qui Lakshmî, là Pallade Atena, altrove Morrìgan, o la Madonna). Ed è un po’ quello che compie l’uomo stesso attraverso l’invenzione delle scritture ideografiche, e magari anche di certe forme di pittura astratta o simbolista. Ma, mentre a livello umano il simbolo è soltanto una trasposizione, un sistema di corrispondenze, è del tutto probabile che ad altri e più elevati livelli di coscienza possa rappresentare qualcosa di più.
In ogni caso, comunque, il simbolismo dei rishi vedici è essenzialmente la figurazione di realtà nascoste — sanketa. I varî dèi sono poteri del Divino, incaricati di mantenere l’ordine dei mondi, e nel contempo di aiutare l’uomo a raggiungere uno stato di perfetta gioia (sovente essi vengono indicati con il nome di mayobhuvah, ‘apportatori di felicità’); sono prototipi più o meno fedeli di realtà vive ed operanti, sebbene a prima vista sembrino mere personificazioni di forze naturali quali la pioggia, il fuoco, il sole… Semmai, è vero l’esatto contrario: il fuoco e il sole fisici sono soltanto le risultanze materiali di potenze soprafisiche, le quali a loro volta sono differenti emanazioni dell’unica Energia primordiale. Al punto da non rilevare, nei Veda, alcuna sostanziale contrapposizione tra il visibile e l’invisibile; il velo che separa la realtà materiale dagli altri ordini di realtà doveva essere per gli antichi rishi sottilissimo e molto trasparente; il visibile era semplicemente l’aspetto esteriore di forze soprafisiche, invisibili soltanto per coloro che non erano dotati della visione divina (dîvya drishthi).
La mente umana è per natura orientata a contrapporre e a suddividere tutto in compartimenti stagni, nel tentativo di afferrare, attraverso questa sua opera analitica, una realtà che per propria natura è invece un tutto unico senza soluzione di continuità; e purtroppo, classificando in categorie, la mente si lascia sfuggire la fondamentale unità di tutte le cose. In tal modo, essa pone da una parte l’essere, dall’altra il divenire, scavando un abisso inconciliabile tra i due; da una parte tutto ciò che riguarda la personalità, e dalla parte opposta tutto ciò che è impersonale; da un lato il monismo, dal lato opposto il dualismo, scindendo senza fine l’inscindibile. A un simile rigido processo logico, il monoteismo appare come un concetto diametralmente opposto al politeismo. Nella realtà delle cose, tuttavia, queste nette distinzioni non esistono affatto (per lo meno, non come contrapposizioni in cui soltanto uno dei due concetti risulta vero). L’Energia unica, causale, immanente e trascendente, sorgente e origine di tutto e al di là di tutto, è alla base di ciò che è concepibile o inconcepibile. Gli dèi sono, in questa prospettiva, gli aspetti di una molteplicità eterna e infinita — poteri dell’unica Energia nelle sue svariate funzioni, che incoraggiano e sostengono le azioni umane, dhartârâ carshanînâm (Rig Veda, I.17.2). “A ciò che è essenzialmente uno nell’essere, i rishi danno molti nomi”, recita un passo del Rig Veda (X.114.5). “Coloro che, devoti agli Dei, li adorano pieni di fede, in realtà adorano Me soltanto”, dirà più tardi Sri Krishna nella Bhagavad-Gîtâ (IX.23). In India, monoteismo e politeismo convivono fianco a fianco come due facce della medesima realtà; tutto si fonde nell’Uno, come le scintille nell’unica fiamma.
E, sempre grazie alla sua peculiare duttilità, l’India è riuscita a incorporare nel corso dei secoli tutte quelle concezioni dell’universo, dalle più semplici alle più elaborate, che sono entrate in contatto con la sua tradizione, ampliandola senza limiti, in un processo che continua ancora oggi. I Veda, in realtà, riescono a combinare con grande naturalezza nel loro monismo elementi che il rigido teismo moderno reputa inconciliabili, come il panteismo e perfino il politeismo. Non ci soddisfa per nulla il termine ‘panenteismo’ coniato da Krause e utilizzato spesso per identificare la filosofia vedico-vedantica, ma la necessità stessa di trovare un nuovo vocabolo che possa identificare la sua particolare prospettiva, dimostra per lo meno l’ampiezza della visione indiana, la quale non si lascia così facilmente rinchiudere in strutture di pensiero giocoforza limitate. Per nostra fortuna, come è stato giustamente detto (e per di più da un prelato occidentale), “Dio non si occupa di teologia”!».
dal capitolo 2. Le Upanishad:
«Le Upanishad appartengono a un’epoca in cui l’intelletto incomincia a sviluppare le sue potenzialità speculative, mantenendo tuttavia una certa plasticità di visione che andrà via via stemperandosi a mano a mano che la mente umana si farà più sviluppata nelle sue strutture analitiche. I veggenti upanishadici tennero sempre in grande considerazione il vero senso dei Veda, usando gli antichi mantra come un vero e proprio strumento di verifica delle loro personali intuizioni e percezioni spirituali; inoltre, il verbo vedico era una sorta di seme da cui essi facevano germogliare le antiche verità dando loro nuove forme di bellezza e di vigore. Ciò che realizzarono, lo espressero in termini più chiaramente comprensibili per l’epoca in cui vissero (e, indirettamente, per la nostra). Tuttavia, il loro scopo non era quello di formulare una filosofia ben strutturata (cosa che mai fecero), né di limitarsi a compiere una mera interpretazione dei Veda: anche in questo caso, illuminare era il loro unico obiettivo; da genuini ricercatori quali erano, miravano sempre e innanzi tutto all’esperienza diretta e, conseguentemente, ad aprire nuovi sentieri, non limitandosi a seguire le orme di piste già battute.
Non ci stancheremo di ripetere, infatti, che non ci troviamo di fronte a un pensiero filosofico per il quale è sufficiente una comprensione intellettuale, come nel caso degli scritti di Hume o di Locke, ma di una visione del mondo che occorre fare propria con l’esperienza, di una sapienza che non si può ottenere per mezzo del mero raziocinio — naishâ tarkena matir âpaneyâ (Katha Upanishad, I.2.9); na manasâ prâptum shakyah (ibidem, II.3.12).
All’epoca delle Upanishad, il rito simbolico del sacrificio stava diventando sempre più privo del suo vero significato, sempre piú superficiale, più ingombrante, al punto che si era giunti a relegare i Veda ai preti, mentre il vedânta sorgeva proprio per diventare sempre più esclusivo appannaggio di quanti cercavano la verità attraverso la loro personale esplorazione. Il linguaggio si fece quindi più diretto, e venne usato per offrire delle potenti suggestioni intuitive e illuminative. I Veda cominciarono il loro declino, e dopo essere passati dalle mani dei rishi a quelle dei purohit (dei preti), passarono da queste a quelle dei pandit (degli eruditi) — e quindi, come sempre accade quando avviene una simile degenerazione, si trasformarono in lettera morta — un superbo monumento, pur sempre degno di grande ammirazione e rispetto, ma fondamentalmente privo di vita. Fu a quel momento che gli kshatriya, non soddisfatti — da grandi uomini d’azione e conquistatori quali erano — dei riti esteriori dei preti (e delle loro macchinazioni per ottenere prestigio e potere), o delle piroette cerebrali di qualche saltimbanco dell’intelletto, si consacrarono al brahmavidyâ e produssero questa superba catena himalayana costituita dalle Upanishad, collegando mirabilmente il cielo alla terra, similmente al bastone della poetica immagine di Kâlidâsa (prithivyâ iva mânadandah). Una nuova èra stava sorgendo: l’Era dell’Intuizione stava progressivamente cedendo il suo posto ai primi albori dell’Età della Ragione.
A conferma di ciò, spesso troviamo nelle Upanishad situazioni in cui alcuni preti vanno a trovare uno kshatriya per essere istruiti sul Brahman; vengono riportati diversi aneddotti molto gustosi in tal senso, come quello narrato nella Chândogya Upanishad, in cui il giovane brahmino Shvetaketu andò dal re Pravâhana, il quale gli fece alcune domande riguardanti l’Assoluto. Quando il ragazzo fu costretto ad ammettere la propria ignoranza al riguardo, il sovrano ribatté: “Ma allora come puoi dire di essere stato istruito? Come può chi non conosce queste cose affermare di essere istruito?” (V.III.4). Già. Profondamente rattristato, il giovane tornò dal padre Gotama e gli chiese di educarlo su tali cose, ma questi, non sapendo rispondere, si recò di persona dal sovrano e si fece ammaestrare sul Brahman e sul vero significato del sacrificio vedico. Oppure quando, nella Brihadâranyaka Upanishad, il re Ajatashatru fa ironicamente notare al sacerdote Driptabâlâki, venuto a chiedergli ammaestramenti spirituali, il paradosso di uno kshatriya che deve istruire un brâhmana sul brahman! Nella Chândogya Upanishad, si precisa inoltre che tale conoscenza può essere impartita a qualunque aspirante, purché sincero, senza alcuna distinzione di classe sociale.
Le Upanishad contengono in nuce le premesse di tutti i sistemi filosofici indiani, compresi quelli che se ne sono resi poi indipendenti sviluppando un indirizzo autonomo (come ad esempio il sâmkhya e il buddhismo), tanto da poter affermare — e questo è unanimemente accettato — che non esiste alcuna forma importante della cultura sapienziale indiana che non affondi le sue radici in esse. Tali testi sono incentrati sulla ricerca del Divino, del Sé, dell’Assoluto, e rappresentano senza ombra di dubbio tra le più ardite testimonianze che lo spirito umano abbia lasciato nel cercare di elevarsi verso l’Ignoto e l’Insondabile. Approfondire nella pratica la relazione esistente tra l’essere individuale e l’Essere Supremo è sempre stata la principale preoccupazione dei ricercatori che hanno percorso il suolo dell’India attraverso i secoli. E di tale tensione le Upanishad figurano tra le vette più eccelse».
dal capitolo 3. Sâmkhya:
«In definitiva, allorché il Purusha, riprendendo coscienza della sua natura immobile e distaccata, cessa di essere schiavo della Prakriti, ritorna al suo immacolato ed eterno stato di quiete. Ciò può e deve avvenire in vita, dopodiché il mukta, il liberato, potrà abbandonare la propria forma corporea con un atto di volontà (iccha-mrityu), e quindi diventare un videhamukta, un liberato privo di corpo, o magari potrà lasciare che la Natura continui una sorta di azione meccanica, esaurendo il proprio samskâra (ovvero ogni residuo derivante dalle azioni compiute in questa o in precedenti incarnazioni, che al momento della liberazione non si è ancora del tutto esaurito), finché non giunga in modo naturale il momento della dipartita, âdehanipâtât; in quest’ultimo caso, si parla di jîvanmukta, un liberato ancora vivente in un corpo umano.
La tradizione indiana distingue tre differenti forme di karma-bandha, di azioni che legano l’individuo alla ruota del samsâra e delle continue rinascite (punarjanman): sañcita-karma, che riguarda le azioni accumulate nelle vite passate, i cui frutti non sono ancora giunti a maturazione; prârabdha-karma, ovvero quelle azioni che, giunte a maturazione in una qualche vita precedente, stanno portando i loro frutti (dolci o amari) nella vita attuale; e sañciyamâna-karma, le azioni che nella presente vita accumuleranno nuove conseguenze e quindi la necessità di ulteriori nascite. Ebbene, la presa di coscienza del Purusha immoto e raccolto in sé, si dice faccia evaporare dal ‘serbatoio karmico’ (karmâshaya) il sañcita-karma(non rendendone più necessaria la maturazione), ed elimini pure ilsañciyamâna-karma, mentre il prârabdha-karma deve essere consumato, in un modo o in un altro, sebbene il jîvanmukta in realtà non ne sia più minimamente affetto. Vi sono inoltre da considerare alcuni particolarissimi effetti karmici, utkata karma, che si ritiene non possano essere modificabili, e quindi occorrerà lasciarli esaurire in modo naturale. Il liberato vivente, ad ogni modo, non ha più alcuna iniziativa individuale,samkalparambha, è assolutamente immobile interiormente, senza tensioni e del tutto privo di conflitti, non desidera più nulla, non si interessa di alcun orientamento all’azione, è del tutto scevro di iniziativa e di spinte centrifughe, nishesta, aniha, nirapeksha, nivritta, niskriya, sarvarambha, profondamente immerso nell’eterna, inalienabile Pace suprema, prashânti, sia qui che altrove — iha ca amutra ca.
Così come la ruota del vasaio può girare ancora un po’ per forza d’inerzia — recita una nota allegoria indiana — allo stesso modo il corpo continua per qualche tempo a vivere a causa del prârabdha-karma. Il jîvanmukta potrà in tal caso, se ne avrà voglia (o meglio, se la cosa dovesse prodursi del tutto spontaneamente), lasciarsi circondare da quanti cercano la sua presenza per essere illuminati dal suo esempio onde ottenere anch’essi la tanto agognata liberazione.
Ma come si può ottenere questo stato di supremo affrancamento? Ecco che a questo punto il sâmkhya passa la sua parola allo yoga, il quale offre alcuni strumenti di notevole efficacia, atti ad effettuare — attraverso una serie di pratiche sistematiche — tale realizzazione del Sé (âtmasakshatkâr).
Beninteso, anche il sâmkhya possiede le sue potenti tecniche, in quanto non si tratta affatto di un sistema meramente teoretico — al contrario, l’intero suo apparato speculativo serve di base a una mistica altamente pragmatica, come abbiamo cercato di porre in evidenza in questa sia pur breve esposizione dei suoi principî chiave. Ma lo yoga, nella sua accezione più ampia e più completa, non essendosi mai separato dalle sue sorgenti vedico-upanishadiche, è in grado di offrirci un approccio ben più completo, come pure un sistema organico che non traccia divisioni inconciliabili tra l’Essere (o gli esseri) e l’Energia, e che permette all’uomo di compiersi in una liberazione (mukti) che diventa il punto di partenza per un’ampia perfezione di sé (siddhi), sfociante in una illimitata felicità (bhukti), goduta tanto nell’essere puro quanto nel divenire cosmico.
Lo yoga, in definitiva, può rispondere in modo esaustivo (e con altrettanto acume e pragmatismo) a tutti quei fondamentali quesiti che il sâmkhya lascia perlopiù irrisolti, annullàti o scavalcati in nome dell’urgenza del raggiungimento di una meta che potrebbe benissimo rivelarsi parziale e riduttiva nella sua frettolosa intransigenza».
dal capitolo 4. Yoga:
«Gli antichi veggenti dell’India ben sapevano che l’uomo non è separato dall’universo, ma è un tutt’uno con esso, come un’onda è parte dell’oceano. Un infinito oceano d’energia, di Shakti, pervade tutto, si proietta in ogni nome e in ogni forma, nâma-rûpa, e il minerale, la pianta, l’animale, l’uomo sono, nella loro esistenza fenomenica, recipienti più o meno efficaci di questa divina Energia. La medesima forza che anima le stelle e i pianeti, abita pure in noi, ci muove, e tutte le nostre azioni e i nostri pensieri sono il suo gioco e nascono dalla complessità delle proprie interazioni con se stessa. Ognuno di noi è una sorta di dinamo in cui l’energia viene generata e racchiusa, per essere conservata, utilizzata e ricaricata.
Esistono processi mediante i quali l’uomo può ripulire quelle che William Blake definiva “le porte della percezione”, al fine di rimuovere le ostruzioni tra il canale di comunicazione (ovvero l’essere umano) e la suprema Energia che vediamo espressa, sia pur parzialmente, nell’uomo e nel cosmo. Bisogna ripulire il passaggio fra la mente esterna e l’essere interiore, abbattere il muro che separa l’una dall’altro. E ogni uomo è potenzialmente in grado di operare una simile kátharsis; coloro che lo fanno in modo cosciente, praticano una qualche forma di yoga.
Lo yoga, essenzialmente, è una rivoluzione radicale di tutto il nostro attuale sistema — è un cambiamento totale del nostro punto di riferimento, del nostro asse. Noi abitualmente viviamo in superficie, ruotando più o meno vanamente attorno a un ego fasullo e transitorio, mentre lo yoga ci porta all’interno, là dove orbitano i varî pianeti che costituiscono la nostra natura, e in quelle profondità è possibile trovare l’equilibrio armonico del nostro microcosmo, e da quelle profondità possiamo imparare ad agire in superficie, eternamente stabiliti nel fondale di un immutabile Silenzio dal quale ogni energia può scaturire.
L’essere umano, comunemente, vive per lo più alla superficie del proprio essere, ignaro della propria complessità, più o meno pago di seguire la ronda abituale di pensieri, sentimenti, desiderî, abitudini, impulsi ricorrenti che considera ‘suoi’, ovvero generati da lui. Mentre, come abbiamo appena appreso dal sâmkhya, è la Natura che agisce in noi, dandoci l’illusione di un ‘io’ (anch’esso fabbricazione della Natura) che crede di essere l’autore dei propri movimenti, quando in realtà è una marionetta appesa ai tre fili dei guna. È la Natura il burattinaio che forgia il ‘nostro’ carattere, le ‘nostre’ preferenze, i ‘nostri’ limiti, le ‘nostre’ virtù e i ‘nostri’ difetti. Lo yoga si propone niente di meno che di spezzare tutti questi fili, di abolire l’attuale assoggettamento alla Prakriti e di operare un totale ribaltamento di coscienza, passando da questa sorta di determinismo universale, in cui una piccola dose di libero arbitrio ci conferisce l’illusione di essere noi i creatori del nostro destino, a una condizione in cui siamo veramente liberi, legittimi padroni e signori della nostra natura, in grado di determinarne gli indirizzi e le scelte.
In un certo senso, possiamo dire che tutto persegue segretamente un’evoluzione, e di conseguenza una qualche forma di yoga, dato che la Natura nel suo lento operato è spinta a manifestare poteri di coscienza sempre più alti e più divini, al fine di realizzare il grande Disegno che l’Essere segretamente le richiede. Lo abbiamo visto attraverso la lunga spirale evolutiva terrestre, in cui dalla Materia (ovvero dal regno puramente minerale) si è evoluta la Vita, seguendo un processo di complessificazione crescente (dal regno vegetale a quello animale) che ha reso possibile l’emergere della Mente. Ma è altrettanto vero che, per lo meno su questa terra, l’essere umano rappresenta la sola specie — per quel che ne sappiamo — che possa diventare cosciente di tale processo (grazie al sufficiente sviluppo in lui di quello strumento che gli permette una sia pur incompleta coscienza di sé: la mente razionale), e tra costoro pochissimi in realtà sono quelli che praticano una qualche forma di yoga consapevole, cercando di collaborare al processo evolutivo (sarebbe già molto cercare di non ostacolarlo!), organizzando in sé i poteri insiti nella Natura, allo scopo di accelerare con una collaborazione cosciente gli intenti della Grande Madre. Ed essendo l’umanità quella che è attualmente, spetta all’individuo che sente il richiamo verso le altezze scalare queste cime, perlopiù come un pioniere o un precursore.
In tutti i paesi del mondo abbiamo la testimonianza della ricerca di realtà superiori, e del modo di entrare in contatto con esse — non solo in India, ma anche in Caldea, in Egitto, in Cina, in Grecia, fra le popolazioni celtiche, come pure presso gli amerindi e le civiltà sudamericane precolombiane (e, stando a quanto ci riferisce Platone, ad Atlantide, o, seguendo la tradizione Tamîl, nella mitica Kumarikhandam, sommersa dalle acque e indicata come il centro di una civiltà assai evoluta fiorente intorno al 12.000 a.C.)».
dal capitolo 5. La Bhagavad-Gîtâ:
«La Bhagavad-Gîtâ è una straordinaria e feconda sintesi ante litteram fra Sâmkhya, Yoga e Vedânta. In realtà, la Gîtâ è, assieme alle Upanishad e al Brahma-Sûtra, una delle tre autorità riconosciute del Vedânta (e infatti formano il cosiddetto prasthâna-traya, o ‘triplice canone’). Tutte le sue idee vedantine sono fortemente colorate dalle concezioni proprie del sâmkhya e dello yoga, ed è da questa colorazione che deriva il carattere sintetico peculiare della sua filosofia. Nei settecento versetti di cui è costituita (si tratta infatti essenzialmente e primariamente di un’opera di poesia mistica, proprio come i Veda e le Upanishad), Vyâsa rivela l’essenza dell’insegnamento di Krishna, il quale indica ad Arjuna la triplice via delle opere (karma), della devozione (upâsanâ) e della conoscenza (jñâna); i principî essenziali su cui la Gîtâ fonda il proprio insegnamento sono l’equanimità, il distacco, lo svolgimento del proprio compito (swadharma), il lavoro eseguito mantenendo una coscienza yogica, l’azione priva di desiderio (nishkâma karma, con la conseguente rinuncia ai frutti che da essa derivano), il superamento dei tre modi inferiori della Natura e, a coronamento di tutto ciò, il totale dono di sé al Supremo, conducente all’immersione, da parte dell’individuo, nella coscienza divina. È questo, infatti, che Krishna indica in ultimo come la conoscenza suprema e il più profondo dei segreti.
La tradizione indiana talvolta ama suddividere i diciotto canti della Gîtâ in tre gruppi, ognuno concernente uno dei tre aspetti della Parola rivelata nel Sama-Veda:tat tvam asi (‘tu sei Quello’). I primi sei canti indicano la via dell’azione priva di attaccamento ai frutti, sintetizzata nella parola tvam, ‘tu’ (ovvero l’essere umano, e ciò che questi deve compiere, kartavyam-karma). I sei canti seguenti, delineando la triplice via, tracciano il cammino per arrivare a tat, Quello, l’Assoluto. Infine, gli ultimi sei canti illustrano lo stato di conoscenza suprema, collegandolo al puro essere, asi, che stabilisce e afferma la connessione tra tate tvam, tra tu e Quello, tra l’individuo e l’Assoluto supremo.
Dall’epoca della sua apparizione, la Bhagavad-Gîtâ non ha mai cessato di esercitare una immensa azione spirituale, suscitando entusiastici apprezzamenti ovunque sia giunta. Ai giorni nostri, Eliade definì la Gîtâ come “la chiave di volta della spiritualità indiana” (Patañjali et le Yoga). Aldous Huxley scrisse che “la Gîtâ è una delle più chiare ed esaurienti sintesi della filosofia perenne che siano mai state concepite. Da qui il suo valore imperituro, non soltanto per gli indiani, ma per l’intera umanità” (dall’introduzione a The Bhagavadgîtâ by Prabhavânanda and Isherwood). Émile Burnouf, cui si deve la prima traduzione in francese della Gîtâ (nel 1861), era del parere che “è forse il libro più bello che sia stato scritto da mano umana; mai era stato enunciato con maggior forza il principio di unità assoluta degli esseri e delle cose, essenza e punto culminante della filosofia indiana” (Traduction française de la Gîtâ). Anche Emerson, nei suoi magistrali Essays, fece notare come “in tutte le nazioni vi sono spiriti inclini ad approfondire la concezione dell’unità fondamentale delle cose. L’assorbimento della contemplazione e l’estasi della devozione fonde tutti gli esseri in un unico Essere… Tale tendenza trova la sua più alta espressione nei testi sacri dell’Oriente, e in modo particolare nelle Scritture dell’India: nei Veda, nella Bhagavad-Gîtâ… ‘Il mondo intero — dice il divino Krishna — è una manifestazione di Vishnu, che è identico in tutte le cose, e il saggio le vede non come parti a se stanti, ma come un tutto unico’.” (da Plato; or, the Philosopher). Sta di fatto che questo breve testo riveste un’importanza unica nella storia spirituale dell’India e dell’umanità».
dal capitolo 6. Il Vedânta:
«Col Vedânta, il pensiero filosofico dell’India si slancia verso le più ardite vette della metafisica pura. Il compito delle Upanishad è stato quello di fornire verità di straordinaria ampiezza, principî generali di sbalorditiva profondità, mirando sempre al cuore delle cose, senza soffermarsi troppo sui particolari. I filosofi del Vedânta, per contro, partono dagli aurei pilastri delle Upanishad per innalzare un sublime grattacielo metafisico — o dovremmo definirlo, più coerentemente, un superbo abhramliha — in cui vengono sviluppati analiticamente certi dettagli che nel tessuto vedico-upanishadico sono appena accennati.
Tra i massimi rappresentanti del Vedânta ricordiamo innanzitutto il grande Shamkara, vissuto tra l’ottavo e il nono secolo d.C., quindi Nimbârka, nell’undicesimo secolo, Râmânuja, alla fine dell’undicesimo secolo, Madhva, tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo, e poi ancora Vallabha, tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo. In realtà, ognuno dei personaggi citati rappresenta una diversa corrente di pensiero vedânta che, pur poggiando tutte quante sull’autorità dei Veda e delle Upanishad (e per ciò dette âstika, al contrario di quelle specializzazioni che preferirono non accettare tale autorità, conosciute come nâstika, tra le quali il buddhismo e il jainismo, sebbene queste ultime si nutrano anch’esse dallo stesso tronco, quali rami del medesimo grandioso albero), presentano alcune differenze nell’interpretazione delle grandi verità enunciate.
La Natura segue spesso, nel suo percorso, una tendenza separatrice e specializzatrice che, come abbiamo già avuto modo di osservare, ha l’immensa utilità di approfondire fin nei più minuti dettagli ogni singolo frammento di verità, per poi tornare in modo più fecondo alla sintesi e all’unità (un processo in qualche modo analogo è avvenuto nella parte occidentale del mondo quando alla filosofia metafisica e all’alchimia si è sostituita la scienza). Dobbiamo quindi considerare tutte queste interpretazioni con grande riconoscenza e rispetto, senza nutrire in alcun modo uno spirito partigiano nei confronti di alcuna di esse e di conseguente avversione verso le altre. In questa scomposizione dell’unica luce bianca nei vari colori del prisma, ognuna di esse ha compiuto un accuratissimo, e nel complesso encomiabile, esame del suo colore preferito, offrendoci una descrizione minuziosa di tutte le sue varie sfumature. Poco importa che esse considerino il colore scelto come l’unico vero. Noi che adoriamo la bianca luce originaria, siamo grati della grande messe che queste correnti ci hanno consentito di raccogliere, permettendoci di godere in modo ancora più concreto dell’unità nella diversità. In India è peraltro famosa la simpatica storiella di quel gruppo di ciechi, ognuno intento a toccare una parte diversa di un elefante e a cercare di descrivere l’intero animale (hasti-darshane iva jâtyandhâh); così, l’uomo che toccava l’orecchio paragonava il mammifero ad un grande ventaglio, chi toccava la coda diceva che era come una fune, e l’altro che palpava una zampa credeva si trattasse di una colonna. Mentre, chi conosce l’elefante nella sua interezza (akritsnavidah, direbbe la Gîtâ), comprende che ciascuno aveva afferrato soltanto una parte della verità. Ci si accorge così che avevano tutti ragione e, al tempo stesso, proclamando il loro aspetto come il solo vero, si sbagliavano tutti».
dal capitolo 7. I Purâna:
«Nei Purâna troviamo alcune immagini di grande efficacia e bellezza, come ad esempio il suggestivo ‘uovo di Brahman’ (brahmânda) da cui sarebbe nato il mitico ‘Embrione d’oro’ (hiranyagarbha), covato dal Tapas primordiale — presentando delle sorprendenti analogie con alcune moderne ipotesi scientifiche sulla nascita del presente universo. La stessa sequenza dei dieci Avatâra (dashavatâra) che troviamo in essi elencata, può essere vista come una sorta di parabola dell’evoluzione, una metafora della crescita progressiva della coscienza divina nell’incoscienza terrestre e nella parziale coscienza umana; ecco come il Matsya-Purâna elenca le dieci Incarnazioni divine: «Matsya (Pesce), Kûrma (Tartaruga), Varâha (Cinghiale), Narasimha (Uomo-leone), Vâmana (Nano), Paramashurâma (Râma con la scure), Râma, Krishna, Buddha, Kalki» (285.67). Abbiamo dunque innanzitutto l’Avatâr in forma di pesce, poi di anfibio, in terzo luogo di rettile, quindi in una forma a metà strada tra l’uomo e l’animale, successivamente come uomo non ancora pienamente sviluppato (un nano o, diremmo noi oggi, una scimmia antropomorfa), cui segue l’avatâra rappresentante l’uomo rajasico dotato di un divino dinamismo, quindi l’apoteosi dell’uomo sattvico (Râma), l’Avatâr elevatosi al di sopra degli opposti (Buddha), l’Incarnazione del divino Purushottama (Krishna); e infine, Kalki, l’Incarnazione futura, il quale deve completare l’opera dei precedenti Avatâra calando il regno di Dio sulla terra. Kalki viene descritto con una spada fiammeggiante nelle mani, sul dorso di un cavallo bianco. “Al crepuscolo dell’epoca presente, quando tutti i sovrani saranno diventati ladri [ci siamo!], il Signore dell’universo nascerà da un Vishnuyashas e sarà denominato Kalki” (Bhâgavata-Purâna, I.3.26).
Per comprendere poi in quale modo alcune intuizioni vediche siano state rielaborate, subendo una vera e propria trasmutazione, basta esaminare il concetto vedico dei ‘dieci raggi’ (dasha-gâva), che nei Purâna, pur restando sostanzialmente fedeli al significato mistico e simbolico dei dieci piani di coscienza identificati dai veggenti vedici, sono stati antropomorfizzati con delle figure assai eloquenti nel loro significato simbolico, per rappresentare in modo maggiormente comprensibile a tutti le caratteristiche che gli esseri di quei piani debbono presumibilmente avere. Il piano materiale (il bhu vedico, corrispondente all’annam vedantico) è rappresentato da un animale domestico, pashu; il piano vitale (bhuvar) da una scimmia, vânara, in riferimento all’instancabile moto cinetico dell’energia (prâna); mentre il dio che governa quel piano è, comprensibilmente, Vayu, il soffio vitale. La sfera sensoriale è abitata da una classe di dèmoni, i pishaca. Il livello della mente emotiva è affollato da una sorta di folletti, i pramatha. Il piano mentale vero e proprio (swar, manas) è occupato dai Giganti, i rakshasa (si sa che la mente è di per sé piuttosto invadente!), mentre il dio che regna al suo apice rimane Indra. I Titani, o asura, presiedono il piano dell’intelletto puro (buddhi). Per contro, gli Dei, in quanto Poteri del Supremo, nella concezione puranica si tengono al di sopra della manifestazione cosmica. Il piano dell’Ânanda è abitato dai Sadhyadeva, e presieduto dal dio Soma. I Siddhadeva dimorano sul piano di Tapas, con Shiva al centro. Vishnu è il dio che regna nel mondo di Cit, la Coscienza. I Satyadeva, infine, con Brahmâ per sovrano, stanno nel reame di Sat, la pura Esistenza».
dal capitolo 8. I Tantra:
«I tantrici, essenzialmente, mirano all’unione con il Divino tramite la sua Energia. La condizione in cui cessa ogni opposizione e distinzione viene chiamata dai tantrici advaya (non-duale) e si raggiunge realizzando l’unità fondamentale dell’Assoluto Supremo tramite la sua Divina Shakti. A tale altissima condizione si perviene attraverso il distacco dalla smania di possesso, l’emancipazione dall’asservimento alle dualità, e la dissoluzione dell’ego —nihspriha, nirdvandva, nirahamkâra. Ma, anziché cercare tale abolizione per via negativa (cessando cioè di identificarsi con i moti della Prakriti inferiore, apara-prakriti), il tantrika cerca di attuarla per via positiva (innalzando tali moti al livello della Prakriti superiore, para-prakriti). Il risultato più importante che ne deriva è l’ottenimento di un dinamismo divino perlopiù sconosciuto agli yogi appartenenti a una delle scuole vedantine (da non confondere con il vedânta originale — quello delle Upanishad — che, come abbiamo avuto modo di constatare, non era per nulla quietistico), che puntano semmai alla cessazione di ogni attività nel Brahman immobile e silenzioso, nell’Immutabile Assoluto (akshara brahman). Peraltro, la liberazione tantrica dal senso dell’ego distrugge automaticamente (senza esercitare uno sforzo volitivo di tipo ascetico) le sei imperfezioni (shada ripus, ahamkâra-dosha) ad esso correlate di cui parlano i testi, ossia: kâma (la lussuria), rodha (l’ira), lobha (l’avidità), moha (l’infatuazione), mada (l’orgoglio), emâtsarya (l’invidia). Dunque, anziché cercare di sopprimere talune inclinazioni negative imponendosi un rigido principio ascetico (o etico, ma non è il caso presso gli yogi), operazione sempre precaria e rischiosa — in quanto tende piuttosto a rafforzare e indurire l’ego che non ad abolirlo —, lo yogi tantrico opera per estirpare il male alla radice, eliminando il senso stesso dell’ego che genera tali deformazioni, ma facendo bene attenzione a non sradicare con esso anche il principio del sé individuato.
Se, per fare un esempio, Patañjali definisce l’essenza dello yoga come la cessazione delle cittavritti, o ‘vortici di coscienza mentale’ (nel celebre aforisma di apertura dei suoi Yoga-Sûtra: yogashcittavrittinirodhah — I.2), il tântrika si spinge molto più in là, e in una direzione decisamente più comprensiva: egli si accorge infatti che abolendo le cittavritti ottiene sì la trance yogica, ma attraverso una soppressione drastica delle facoltà mentali che conduce con ogni probabilità alla moksha, ma anche a una definitiva paralisi della natura strumentale dell’uomo. Ciò va benissimo in uno yoga rigorosamente quietistico che punti unicamente a fondersi con l’Assoluto extratemporale, abbandonando il corpo, la materia, la terra (visti come illusorî o non-reali) al suo destino. Se, invece, vogliamo trasformare anche la nostra natura strumentale (come entro certi limiti ha tentato per l’appunto di fare il tantrismo, e come avevano tentato i rishi vedici) a immagine divina, per renderla partecipe delle supreme delizie dello Spirito, in tal caso è necessario partire da presupposti ben più ampi, che permettano alla divina Shakti di operare una palingenesi all’interno dell’âdhâra (termine usato dai tantrici a indicare il complesso della nostra natura mentale-vitale-fisica). L’arresto dell’attività della citta porta all’immobilismo, all’inerzia strumentale; se invece impariamo a controllare le vritti della coscienza mentale, dominandole e diventandone gli assoluti padroni, potremo indifferentemente assumere un atteggiamento esteriormente immobile o attivo, e ciò — in un caso come nell’altro — non disturberà affatto l’eterna quiete dello spirito sovrano (il quale dimora al di sopra di tali moti di superficie), ma potrà nel contempo permettere di sbarazzarci dei falsi movimenti della natura, accogliendo solo ciò che possiede una sua intrinseca utilità e verità, e rifiutando ciò che non appartiene alla vera coscienza e all’autentica esperienza spirituale.
L’idea di base è di non reprimere gli istinti che appartengono all’animalità umana, bensì di trasformarli nei loro divini corrispondenti. Nell’Ignoranza (avidyâ), ogni moto della natura inferiore è, in realtà, una deformazione di un principio divino che appartiene alla Natura superiore (o, se preferiamo, alla Soprannatura). Il desiderio, per limitarci a fare un esempio, è la leva mediante cui il principio vitale compie lo scopo della propria affermazione nell’universo, e tentare di estirparlo a favore dell’inerzia equivale a rifiutare il principio stesso della vita. Il desiderio, invece, può essere trasformato nel suo divino corrispondente, diventando desiderio dell’infinito, anelito dell’eterno, pura brama d’assoluto, trovando soddisfazione in un godimento supremo nella beatitudine del Divino che tutto possiede e che gode di se stesso attraverso tutte le cose».
dal capitolo 9. Altre correnti del grande fiume:
«Oltre ai Tantra, indipendenti dalla tradizione vedica, sia pur solo in apparenza, abbiamo lo shivaismo, il jainismo, il sikhismo, il buddhismo — tutte diramazioni di un medesimo grande fiume.
Prima di compiere una breve analisi di queste correnti, cerchiamo di contestualizzarle, per provare a capire come esse sono sorte e, ancor più, in cosa consiste l’eventuale comune denominatore, il filo che le lega a doppio nodo in un legame di parentela, come tante perle di un’unica collana.
Per fare ciò, dobbiamo andare all’inizio del Kali-Yuga, l’Età del Ferro (corrispondente grosso modo all’inizio della nostra èra volgare) — le vecchie verità, perduto il loro vigore, cadono nel dominio della pura convenzione, e vengono sempre più relegate in qualche remoto e sparuto eremitaggio, o forse nemmeno là, visto che gli stessi asceti sembrano più interessati ad acquisire poteri soprannaturali che a cercare la realizzazione spirituale; lo stesso dimorare in un corpo fisico inizia ad apparire nel suo carattere negativo, come una sorta di condanna, di punizione, e il mondo stesso viene visto sempre più come un luogo di dolore e di espiazione, sul quale è impresso l’indelebile marchio della transitorietà e dell’infelicità; la sofferenza fa sentire in modo più acuto la sua morsa fatale sulle creature. La fretta s’impadronisce degli uomini, e l’utilitarismo diventa sempre più l’indiscusso sovrano dei popoli.
Pertanto, le filosofie che iniziano a sorgere in quest’epoca, pur nelle loro enormi diversità e divergenze, condividono tutte una comune angoscia: l’assillo dell’impermanenza della vita e, di conseguenza, la ricerca del modo di fuggire dalla gravosa ruota del samsâra, ossia delle successive rinascite che ci legano a questa ‘valle di lacrime’.
In questo clima di fondamentale pessimismo, in India iniziano a prendere corpo tutta una serie di dottrine materialistiche, tra le quali si distingue, per la genuinità delle proprie argomentazioni, quella fondata da Cârvâka, denominata lokâyata. Essa sostiene che esiste soltanto questo mondo, loka; e i suoi seguaci sono chiamati per l’appunto lokayatika.
Con qualche lieve differenza, tutte le dottrine materialiste sorte in questo periodo (e anche, a ben vedere, in altre epoche e in altre latitudini, come ad esempio il sistema epicureo dell’antica Grecia, o il materialismo scientifico dell’Europa ottocentesca) sostengono principî analoghi: è reale solo ciò che può essere sperimentato dai cinque sensi — ergo, la materia è la sola realtà, da cui tutto nasce (pensiero, coscienza, volontà) e in cui tutto alla fine si dissolve. “La ricchezza e il godimento sono gli unici obiettivi dell’esistenza umana. Il pensiero stesso nasce dalla materia. Non esiste nessun altro mondo. La morte è la fine di tutto”, recita un testo indiano dell’epoca, il Prabodhacandrodaya. La sola conclusione logica, in conseguenza di queste riflessioni, è la ricerca di una felicità tutta mondana, consistente nel cercare di godersela il più possibile. Ecco allora che il Sarva-darshana-samgraha può permettersi di fornire tale consiglio: “finché la vita è in vostro possesso, vivete allegramente; nessuno può sfuggire all’occhio penetrante della Morte” — chi vuol esser lieto, sia: | di doman non c’è certezza.
Queste scuole, atee e materialiste, conobbero in India un’ampia diffusione e perdurarono per secoli, giungendo a predicare perfino nei templi (e ciò è da ascrivere senza alcun dubbio a favore del grande spirito di liberalità insito nel temperamento indiano); i suoi sostenitori arrivarono addirittura a citare alcuni versi delle Upanishad (opportunamente scelti ed estrapolati dal loro contesto) per avvalorare le loro tesi, come il seguente distico, preso della Brihadâranyaka Upanishad: “La coscienza, procedendo da questi elementi materiali, in essi viene distrutta. E quando questi vengono distrutti, dopo la morte non rimane alcuna ideazione cosciente” (II.4.12). Oppure chiamando a testimonianza gli stessi Veda, come quel passo in cui il rishi si chiede, con una punta di agnosticismo che può essere facilmente esagerata: “Chi può conoscere da dove sia scaturito l’immenso universo?” (Rig Veda, X.129). E, similmente alle concezioni filosofiche del materialista ottocentesco Jeremy Bentham, i cârvâka approdarono ad un atteggiamento che conferì una coloritura etica al loro edonismo: essi erano ben coscienti che, per ottenere la propria felicità, occorreva — in virtù della naturale legge del karma per la quale si raccoglie ciò che si semina — cercare di non arrecare infelicità agli altri. E difatti non sono mai state levate contro i cârvâka (né contro movimenti affini) accuse di antisocialità o di immoralità.
Interessante è poi notare quanto la teoria lokâyata conosciuta con il nome di yadricchâvâda (ossia della ‘causalità accidentale’), risulti simile alla teoria del materialismo occidentale del diciannovesimo secolo (l’empirismo scientifico di John Stuart Mill, per esempio), secondo cui l’universo sarebbe sorto da una combinazione del tutto casuale di particelle elementari di materia.
Non rientra negli scopi del presente lavoro addentrarsi ulteriormente in questo territorio. Ci è bastato accennarlo, per permetterci di capire meglio la piega presa dalle mistiche che in quel periodo si svilupparono in India, impregnate di una particolare forma di pragmatismo nella quale si avverte una sorta di febbrile impazienza — quell’atteggiamento frettoloso e sbrigativo che via via diverrà la nota dominante della vita moderna, in contrasto con la tranquilla ponderatezza e l’olimpica ampiezza di visione degli antichi veggenti».
dal capitolo 10. Buddha:
«Il buddhismo cela, nel suo grande seno, molti tesori ancora nascosti, che — se svelati e considerati alla luce del principio ispiratore del presente libro — possono fornirci importanti elementi per comprendere meglio la natura della coscienza e dell’esistenza, risultando quindi utilissimi in una nuova figurazione mondiale del pensiero e dell’esperienza. Il buddhismo, in modo troppo generico, viene associato alla ricerca di uno stato trascendente, il nirvâna per l’appunto, al di là di sofferenza e ignoranza, e al di là della sfera fenomenica dell’esistenza. Tuttavia, ci sono aspetti e sfumature non ancora chiaramente interpretati dagli studiosi, che andrebbero in una direzione assai più vasta e inclusiva. […]
Per il tantrismo buddhista, similmente a quello hindu, il mondo è luogo non soltanto di Liberazione, ma anche di Realizzazione — la prima intesa come emancipazione dai propri limiti egoici, la seconda come instaurazione di un regno di pace e di armonia universale determinato dalla presenza e dalla guida di esseri affrancati dalle suddette limitazioni e dotati di quel giusto discernimento, di quel potere attivo e di quella gentilezza amorevole capace di riversarsi e diffondersi sull’intera umanità.
La tradizione mahâyâna attribuisce allo stesso Shakyamuni un discorso — raccolto nel voluminoso Avatamsaka-sûtra, e considerato dal prof. Suzuki come la “quintessenza del pensiero, del sentimento e dell’esperienza buddhista” — pronunciato mentre questi si trovava ancora sotto l’albero del Risveglio, mentre era immerso nella più alta esperienza del nirvâna, nel quale egli descrive in modo particolareggiato la maniera in cui viene percepito il mondo in quel particolare stato di coscienza. Questo sûtra (che gli studiosi pongono poco prima dell’èra cristiana, o in coincidenza con essa, ma della cui versione sanscrita originale sono sopravvissuti solo due dei quaranta capitoli totali — il 26°, Dashabhumika, e il 40°, Samantabhadra —, mentre l’edizione integrale più antica risale a una traduzione in cinese del V secolo d.C., dal titolo Hua-yen Ching), è uno dei più importanti dell’intero canone buddhista, al punto da avere determinato la nascita di una precisa scuola, detta per l’appunto avatamsaka; alla luce della visione qui espressa, il mondo fenomenico appare intessuto da una fitta rete di reciproche correlazioni, una sostanziale interdipendenza del tutto con ognuna delle sue parti, ove gli elementi e le circostanze universali interagiscono tra loro in modo tale che ciascuno di essi contiene in sé tutti gli altri. Il testo si concentra sulla relazione intercorrente tra i fenomeni e l’Assoluto. Ogni cosa è in completa armonia con tutto il resto, essendo l’intero esistente manifestazione di un’unica Causa. Tutto nell’universo, che si tratti di esseri animati o inanimati, senzienti o insenzienti, è espressione del più alto Principio. In questa visione, non solo il Tutto contiene ogni cosa, ma ogni cosa contiene la totalità. Oltre ad anticipare talune ipotesi suggerite dagli avamposti della scienza moderna, questa visione è importante soprattutto perché si riallaccia alla medesima conciliazione tra l’Essere e il Divenire che l’India ha perseguito per così lungo tempo e che conferisce il vero senso all’esistenza universale. […]
E nell’ultimo capitolo dell’Avatamsaka, conosciuto come «i 10 voti di Samantabhadra», l’omonimo Bodhisattva chiede di prendere su di sé le conseguenze del karma negativo accumulato da tutti gli esseri, al fine di condurli più rapidamente all’Illuminazione. Samantabhadra ribadisce inoltre il concetto più volte ripetuto nel testo, riguardante l’interpenetrazione di tutti i fenomeni: “Nella più piccola particella di polvere vi sono mondi innumerevoli e inconcepibili”, oltre alla stessa simultaneità spazio-temporale: “Un singolo capello contiene l’intero passato, presente e futuro”.
È invece ormai ben noto a tutti come la figura del Bodhisattva raggiunge via via un’importanza sempre maggiore nel buddhismo, diventando l’essere ideale, l’immagine della perfezione e della compassione. Come leggiamo dal Vajradhvaja-sûtra, il Bodhisattva è colui che scende per un compito preciso, con un’alta missione salvifica: “Prendo su di me il fardello di tutte le sofferenze, deciso a sopportarlo. Non tornerò indietro, non fuggirò né tremerò, giacché non temo nulla, non mi arrendo, né esito. Lavoro per l’instaurazione di un incomparabile regno di conoscenza fra questi esseri. Non mi interessa la mia esclusiva salvezza personale. Devo salvare tutti questi esseri dall’oceano del samsâra per mezzo della nave della perfetta conoscenza”. Aggiungiamo che anche l’alchimia buddhista, sviluppatasi soprattutto grazie ad un sorprendente mistico vissuto durante il VII secolo d.C. di nome Nâgârjuna (da non confondere con l’omonimo capostipite della scuola mâdhyamika), nella sua ricerca dell’elisir della vita (amrita), a beneficio di tutti coloro che potessero fruirne, è orientata in questa stessa direzione di un riscatto terrestre dell’umanità».
dal capitolo 11. L’India moderna:
«Lo scrittore francese Pierre Loti, chiamato a rivestire il ruolo di presidente onorario del “Comitato franco-indiano” sorto alla vigilia della prima guerra mondiale, espresse un augurio rivolto all’India, che vorremmo fare nostro: “Possa il tuo risveglio destare quell’Occidente svilito, malato, accecato dalla quotidianità, distruttore di nazioni come pure di dèi e di anime, affinché s’inchini dinanzi a te, vetusta India, dinanzi alle meraviglie delle tue primordiali creazioni” (dai documenti della fondazione del Comité Franco-Hindu).
Concludiamo questo capitolo dedicato all’incipiente resurrezione dell’India con quanto Sri Aurobindo scrisse nel 1905, a guisa di breve riepilogo e, nel contempo, quale introduzione ideale all’ultimo capitolo di questo nostro lavoro, a lui dedicato.
“I veggenti dell’antica India avevano compiuto, nei loro esperimenti e sforzi di disciplina spirituale e di conquista del corpo, una scoperta che nella sua importanza per il futuro della conoscenza umana oscura le intuizioni di Newton e di Galileo; perfino la scoperta del metodo induttivo e sperimentale effettuata dalla scienza non la si può considerare altrettanto fondamentale; poiché essi penetrarono il metodo dello yoga fino ai suoi processi ultimi, e mediante tale metodologia si elevarono al culmine di una triplice realizzazione.
Essi percepirono anzitutto come sola realtà, sottostante al flusso e alla molteplicità delle cose, l’esistenza di una suprema Unità e immutabile Stabilità; giunsero a comprendere che Quello è la sola realtà e che tutti i fenomeni non sono che le sue forme e le sue sembianze, che Quello è il vero Sé di tutte le cose, e i fenomeni non sono che le sue vesti e i suoi ornamenti; sperimentarono che Quello è assoluto e trascendente, e quindi eterno, immutabile, infinito e indivisibile. Fu questa dunque la prima realizzazione ottenuta attraverso lo Yoga, nityonityanam, l’Uno eterno nella moltitudine transitoria.
Allo stesso tempo, essi colsero una verità interiore — una verità sorprendente: percepirono che il Sé trascendente e assoluto dell’universo costituisce anche il sé degli esseri viventi, e quindi anche il sé dell’uomo, che è il più evoluto tra gli esseri che attualmente abitano il piano materiale terrestre. Il Purusha, l’essere cosciente nell’uomo che aveva tanto sconcertato i sâmkhya, si è rivelato nella sua realtà ultima identico a Prakriti, la sorgente apparentemente non cosciente della realtà; tale non-coscienza di Prakriti, tra le molte altre scoperte, si è dimostrata un’apparenza, non una realtà, poiché dietro ogni forma inanimata un’Intelligenza cosciente è, all’occhio dello yogi, all’opera, in un’evidenza luminosa in sé. Questa fu dunque la seconda realizzazione ottenuta attraverso lo Yoga, cetanascetanam, l’Uno cosciente nella moltitudine delle coscienze.
Infine, alla base di queste due realizzazioni, se ne trova una terza, la più importante per l’umanità, cioè che l’essere che si manifesta in ogni uomo è completo, perché esattamente identico al Sé trascendente; il Trascendente è indivisibile e il senso dell’individualità separata non è che una delle apparenze fondamentali dalle quali la manifestazione dell’esistenza fenomenica perpetuamente dipende. In tal modo l’Assoluto, che sarebbe altrimenti aldilà di ogni conoscenza, diventa conoscibile; e l’uomo che conosce integralmente il proprio essere conosce l’intero universo. Questa stupenda verità è stata espressa nelle due famose formule vedantine, so’ham, “io sono Quello”, e aham brahma asmi, “io sono il Brahman, l’Eterno”.
Basata su queste quattro grandi verità, nityonityanam, cetanascetanam, so’ham, aham brahma asmi, come su quattro possenti pilastri, la suprema filosofia delle Upanishad si è innalzata tra le più lontane stelle.
Fu l’anima, il temperamento, lo spirito ideale formato ed espresso nelle Upanishad che costruì in seguito le grandi filosofie, edificò la struttura del dharma, testimoniò la sua eroica gioventù nel Mahâbhârata e nel Râmâyana, si intellettualizzò infaticabilmente nell’epoca classica della sua maturità, produsse così tante intuizioni originali nella scienza, creò un così prolifico fervore di esperienze estetiche, vitali e sensoriali, rinnovò la sua ricchezza spirituale nel Tantra e nei Purâna, si profuse nella magnificenza e nella bellezza delle linee e del colore, scolpì e fuse il suo pensiero e la sua visione nella pietra e nel bronzo, si riversò in nuovi canali espressivi nei linguaggi posteriori — e ora, dopo una lunga eclissi, riemerge identico nella diversità e pronto per una nuova vita e per una nuova creazione» (The Philosophy of the Upanishads)».
dal capitolo 12. Sri Aurobindo:
«Risulta sempre più evidente, oggi, l’intima connessione che lega la nostra individualità al mondo intero. Gli scenari della trasformazione epocale in atto sono tutti interconnessi e interdipendenti tra loro: tecnologia, politica, cultura, arte, ecologia, medicina, scienza… tutto ormai ruota come in una specie di vortice cosmico che sembra volerci rimpastare per una nuova figurazione mondiale. Questo è perciò il tempo della grande prova, e della grande svolta. Il tempo del grande pericolo, e della Grazia.
Davvero, è tutto sottosopra, in questo nostro mondo umano attuale. Un vero e proprio caos dal quale, magari quando meno ce lo aspettiamo, sorgerà una nuova armonia, l’Armonia sopra-mentale e solare.
La tragedia messa in scena dalla Mente volge ormai al termine, e gli attori prendono a vagare, sperduti, come tanti ‘personaggi in cerca d’autore’. Sì, è tempo di gettare via tutte le maschere, finalmente, e di ammirare i primi luminosi versi — scritti sul grande Libro del mondo — dell’epopea dell’Amore!
Tutti noi, in questa epoca buia, è come se stessimo attraversando collettivamente una fase iniziatica di discesa nel caos e di rinascita. Spesso, è proprio nei travagli del mondo attuale che si manifesta con più chiarezza il senso profondo di ciò che sta avvenendo. “Forse il soffocamento dell’individuo è veramente la soffocazione del Dio nell’uomo” (Sri Aurobindo, The Synthesis of Yoga).
Ci troviamo, per lo più senza saperlo, nell’èra della più grande rivoluzione mai tentata: un vero e proprio colpo di stato mondiale, in cui l’antico sovrano — Sua Signoria il Mentale — vede ogni giorno di più vacillare il proprio trono, un tempo così sicuro. “La mente non è in grado di far mutare in modo radicale la natura umana. Potremo cambiare le istituzioni umane all’infinito, ma l’imperfezione finirà sempre per mandare in pezzi le nostre istituzioni… Ci vuole un altro potere, che non solo sappia resistere a questa gravitazione verso il basso, ma vincerla” (Sri Aurobindo, Letters). La mente deve quindi, a questo punto della nostra evoluzione, fare posto a una più grande divinità, dotata di luce intrinseca, e non soltanto riflessa. Ma, come sappiamo bene, i monarchi non si lasciano spodestare così facilmente.
Era forse questo il senso di quell’inno vedico che, unico nel suo genere, probabilmente il più enigmatico in assoluto, descrive il conflitto di Indra con Usha? Perché mai il dio Indra si sarebbe lanciato contro il carro di Usha, l’Aurora divina, che aveva in precedenza aiutato? Ma Indra, lo abbiamo visto, è il Potere della Mente. E il suo compito non è quello di compiere, bensì di iniziare. La sua comparsa era necessaria affinché certe cose potessero mostrarsi alla luce del giorno, affinché un primo bagliore di coscienza-di-sé filtrasse tra le crepe della spessa muraglia dell’Incoscienza. Dopodiché, sarebbe stato messo da parte per lasciare il posto all’invasione aurorale della luce. D’altronde, non fu certo Indra a conferire un ordine alla Natura! Un preciso ordine cosmico (ritam) già esisteva, e c’era pure la montagna che si ergeva fra cielo e terra, pur se teneva ben nascosti i suoi tesori, occultati nel proprio grembo. Il compito di Indra era quello di fendere la montagna (vi parvato jihîta), creare un ponte tra l’inconscia divinità animale e la cosciente divinità del dio. Questo ponte, o meglio, questa stretta passerella, è proprio l’uomo mentale che noi tutti siamo. E, una volta compiuta la sua missione, il dio Indra sarebbe stato sostituito da un dio bambino, Skanda. Ma Indra, come tutti i sovrani, non è disposto a cedere così facilmente il suo trono, e attacca il carro di Usha affinché tutto rimanga immutato ed egli possa regnare per lungo tempo ancora. Gli permetterà il dio Sole di contrastare vittoriosamente la propria figlia, e le sue stesse mandrie risplendenti?
Sono trascorsi interi millennî da quando i rishi vedici hanno vissuto fisicamente su questa terra. Essi avevano intravisto la possibilità di una trasformazione divina della Materia, avevano scoperto “il favo di miele sotto la Roccia” dell’Incosciente materiale. Risulta ormai evidente quanto le immagini vediche fossero precise, giacché quando l’esperienza spirituale giunge a conglobare la sfera più materiale, il corpo fisico percepisce concretamente un frammento roccioso sotto i suoi piedi, ha la sensazione di un torrente in piena che lo inonda da ogni parte, sente un sole che lo irradia dall’alto — e si tratta di esperienze reali, assai più reali della roccia, del fiume e del sole fisici. Ma i rishi vedici se ne sono andati via portando con sé il loro segreto. L’umanità non era ancora pronta, è evidente. Ma ne è dovuta scorrere di acqua sotto i ponti, da allora!, — e tanto sangue, tante miserie. Oggi, siamo arrivati (o stiamo arrivando) a toccare il fondo dell’orrore. L’Orrore viene a galla dappertutto, in tutta la sua ripugnante bruttura.
Tutte le fogne, che per secoli abbiamo tenuto ben sigillate nel sottosuolo, sono state ‘messe a nudo’ — apokálypsis! Il XX secolo si è chiuso alle nostre spalle lasciando aperte questioni decisamente scottanti… camere a gas, effetto serra, pozzi di petrolio in fiamme, alimenti geneticamente modificati, sconvolgimento degli ecosistemi, clonazioni, sfruttamento di risorse, di bambini, di donne… Dalle origini della storia fino all’ultimo Ottocento, le vittime umane pare non abbiano superato complessivamente le quaranta milioni di unità. Mentre, il Novecento, da solo, ha mietuto qualcosa come centodiecimilioni di vittime! “Ogni tappa dell’evoluzione — osserva Sri Aurobindo nel 1909 — è segnata da una forte recrudescenza di tutto ciò che deve scomparire” (Karmayogin).
No, non si tratta certo di essere millenaristi, intendiamoci. Noi non crediamo affatto alla fine del mondo. Tanto più che, ormai, l’homo-economicus ha preso il sopravvento, assennato e prudente — suo sembra il futuro del pianeta! Mentre qualche sparuto bacchettone (vecchio brontosauro in via di estinzione) vorrebbe farci credere che occorre restaurare i vecchi valori morali, che giacciono ormai agonizzanti sotto le macerie di questo cataclisma. Che il diavolo se li porti, gli uni e gli altri! Sì, i rivoluzionari restano il sale della terra.
“Così come nella pratica della scienza spirituale, o arte dello yoga, dobbiamo portare in superficie le possibilità psicologiche che esistono nella natura e sbarrano la strada al nostro perfezionamento e alla nostra realizzazione spirituale, al fine di eliminare non solo tali possibilità ma anche quelle assopite che potrebbero ridestarsi in futuro per disfare il lavoro compiuto, nello stesso modo la Natura agisce con le forze mondiali che incontra sul suo cammino: essa non soltanto chiama a raccolta quelle che l’assisteranno, ma porta anche in superficie, per eliminarle, quelle che sa essere gli ostacoli normali e anche inevitabili che senz’altro si ergeranno per intralciare la sua volontà segreta. Si è spesso osservato questo processo nella storia dell’umanità; se ne vede oggi un esempio di enorme potenza, proporzionato alla portata di ciò che dev’essere compiuto. Ma queste resistenze hanno finito per aiutare, proprio con la loro resistenza, molto più di quanto l’hanno ostacolato, l’intento della grande Creatrice e di Colui che la muove” (Sri Aurobindo, The Ideal of Human Unity).
L’aria si fa sempre più irrespirabile. Un fetore putrescente esala da milioni di idee cadaveriche, e dall’ennesimo inconcludente ‘best-seller’ (morti chiedono a un morto libri morti, per dirla con Saba). Non dovrebbe mancare molto, oramai, alla fine della Menzogna, visto che il suo parossismo è visibile dovunque. “Questo nostro mondo materiale, oltre alle cose pienamente incarnate del presente, è popolato da ombre poderose, spettri di cose morte e spiriti di cose non ancora nate. Gli spettri delle cose morte sono delle realtà assai moleste ed ora abbondano: spettri di religioni morte, di arti morte, di moralità morte, di teorie politiche morte, che pretendono di conservare i loro corpi in decomposizione o di animare in parte il corpo delle cose esistenti. Ripetendo ostinatamente le loro formule sacre del passato, ipnotizzano le menti retrograde e intimidiscono perfino la parte progressista dell’umanità. Ma esistono pure gli spiriti nascituri, ancora incapaci di rivestire un corpo definito pur essendo già nati nella mente; questi ultimi esistono come influenze di cui la mente umana è consapevole e a cui essa risponde attualmente in modo confuso e disordinato” (Sri Aurobindo, The Ideal of Human Unity). Eric Hobsbawn, considerato il più grande storico del ventesimo secolo, sembra fare eco a tali parole quando scrive che “se l’umanità deve avere un futuro nel quale riconoscersi, non potrà averlo prolungando il passato o il presente. Se cerchiamo di costruire il terzo millennio su questa base, falliremo. E il prezzo del fallimento… è il buio” (The Brief Century).
È tempo di QUALCOSA D’ALTRO.
In verità, noi abbiamo il grande privilegio di vivere nell’epoca più meravigliosa della storia, proprio perché tutto sta crollando. Non dobbiamo infatti scordare che la fine dell’uomo è l’inizio della nuova specie. La Kâlîsantarana Upanishad afferma che molti ricercatori spirituali vissuti in precedenti ère, espressero il preciso desiderio di rinascere nell’attuale Kali Yuga, perché in tal modo la loro crescita spirituale avrebbe potuto conoscere uno sviluppo cento volte più rapido di quello ottenibile ai loro tempi! Noi esseri umani, purtroppo, abbiamo l’abitudine di interpretare i segni al contrario, e per questo ci allarmiamo tanto vedendo le assurdità, le depravazioni, le insensatezze che sbucano da ogni angolo di questo mondo che si fa ogni giorno più invivibile — e tuttavia, se sapessimo vedere, ci accorgeremmo che è proprio questo buio il segnale dell’aurora imminente. “È peculiare al Kali Yuga distruggere ogni cosa mettendo tutto in discussione allo scopo di stabilire (dopo una lotta tra le varie forze positive e negative) una nuova armonia di vita e di conoscenza in un ulteriore Satya Yuga”, scriveva Sri Aurobindo, col suo immenso acume, intorno al 1912 (Satyakama Jabala).
E, in Savitri, aggiunge: “E forse troveremo, quando tutto sarà fallito, nascosta dentro, la chiave del perfetto cambiamento”. E prosegue, annunciando la gloriosa imminenza —
When darkness deepens strangling the earth’s breast,
And man’s corporeal mind is the only lamp,
As a thief’s in the night shall be the covert tread
Of one who steps unseen into his house.
A Voice ill-heard shall speak, the soul obey,
A Power into mind’s inner chamber steal,
A charm and sweetness open life’s closed doors
And beauty conquer the resisting world,
The Truth-Light capture Nature by surprise,
A stealth of God compel the heart to bliss
And earth grow unexpectedly divine.
[I.I.IV.321-331]
Quando il buio sarà fondo, strozzando il petto terrestre,
e la mente del corpo sarà la sola lampada,
come un ladro di notte a silenziosi passi
verrà Colui che, non visto, penetra nella dimora.
Parlerà Voce negletta, l’anima le obbedirà,
nella stanza della mente s’infiltrerà un Potere,
della vita un dolce incanto aprirà le porte chiuse,
la beltà sul resistere del mondo trionferà,
lesta la luce del Vero catturerà la Natura,
una mossa del Divino spingerà i cuori alla gioia
e la terra divina sarà, senz’aspettarselo».