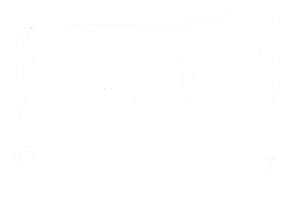SRI AUROBINDO SU SAVITRI
«In merito alle numerose suggestioni contenute nella sua epistola, vi sono diverse osservazioni da fare. Alcune di esse pongono in primo piano questioni tecniche relative alla poesia mistica, che contavo di esaminare in una introduzione a Savitri, quando verrà pubblicato; niente comunque impedisce che possa anticipare qualcosa fin da ora.
Rapide transizioni da un’immagine a un’altra sono una caratteristica costante di Savitri, così come di gran parte della poesia mistica. Qui [nell’incipit del canto di apertura dell’epopea — The Symbol Dawn, “L’Aurora Simbolo”] non sto producendo una descrizione dell’aurora come di una singola immagine in continuo sviluppo, né variazioni di una medesima immagine. Descrivo invece una rapida serie di transizioni, sovrapponendo diverse immagini suggestive in sequenza. Inizialmente vi è l’oscuro quietismo, poi il tocco persistente, quindi la prima “bellezza e meraviglia” conducente al cancello magico e al “chiarente spiraglio”. Viene poi l’oscurità che svanisce, dove la similitudine usata [«La tenebra scemò come un manto che cade», verso 96] suggerisce la rapidità del cambiamento. Come risultato, quello che all’inizio era uno spiraglio diventa una breccia ampia e luminosa — volendo dare una consequenzialità logica, si può considerare lo spiraglio come una scucitura nel “mantello”, che si allarga in un grosso squarcio. Quindi tutto si trasforma nel “breve perpetuo segno”; seguono l’iridescenza, il bagliore e l’aura meravigliosa. In una successione così rapida di immagini, non potete costringermi a un concatenamento logico delle immagini, o a una monotonia di tipo classico. La Musa mistica ha più la natura di una baccante inebriata dal vino di Dioniso, che non quella di un’ordinata casalinga.
Inoltre, spero non si aspetti da me un’accurata descrizione scientifica della terra, immersa per metà nell’oscurità e per metà nella luce, il che rovinerebbe il mio simbolo impressionista; o dovrei forse riesumare la concezione della terra come una superficie piatta e immobile? Non sto scrivendo un trattato scientifico — sto selezionando alcune idee e impressioni per dar forma al simbolo di una parziale e temporanea tenebra dell’anima e della natura che, per la percezione o sensazione soggettiva di chi si trova in quella Notte, appare universale ed eterna. Chi si trova inghiottito nella Notte, non pensa che l’altra metà della terra è piena di luce; per lui tutto è notte e la terra è una viandante sperduta in un’immutabile oscurità. Se sacrificassi l’impressionismo dell’immagine e rinunciassi a rappresentare la terra come roteante nello spazio tenebroso, allora potrei lasciar perdere anche il simbolo che ne costituisce parte essenziale. Con ogni evidenza, ho illustrato la terra che, nel suo ruotare, perviene all’aurora e passa dall’oscurità alla luce. Occorre cogliere l’idea nella sua integralità, in ciascuna delle sue transizioni, senza fissarsi su un singolo particolare con insistenza troppo pedissequa. In questa epopea presento costantemente, di volta in volta, prospettive parziali della vita come se costituissero l’interezza, per offrire il pieno valore dell’esperienza di coloro che sono legati a quel particolare punto di vista (per esempio, la concezione e l’esperienza materialistiche della vita) — se poi dovessi essere accusato di incoerenza filosofica, ebbene, significherà unicamente che la tecnica dell’interpretazione surmentale della vita non è così facile per tutti da comprendere.
Veniamo ora al passaggio che lei ha attaccato con tanta veemenza, riguardo l’Incosciente che desta l’Ignoranza. In primo luogo, il termine “formless” [senza forma, informe] risulta in effetti inefficace, non a causa della sua ripetizione, ma per il fatto che non rappresenta la parola o l’idea giusta e io stesso non ne ero soddisfatto. Ho perciò trasformato l’intero passaggio nel modo che segue:
Then something in the inscrutable darkness stirred;
A nameless movement, an unthought Idea
Insistent, dissatisfied, without an aim
Something that wished but knew not how to be,
Teased the Inconscient to wake Ignorance.
Poi qualcosa si mosse nel buio imperscrutabile:
un moto senza nome, un’Idea non pensata,
insistente, mai pago, senza meta,
qualcosa ch’esser voleva senza però saper come,
incitò l’Incosciente a destare Ignoranza.
Tuttavia, ho lasciato l’espressione da lei condannata e, evidentemente, pensa sia di pessimo gusto poetico incitare qualcosa di così incorporeo e irreale come l’Incosciente. Ma qui sorgono diverse questioni fondamentali. Innanzi tutto, è proprio necessario considerare parole come Incosciente e Ignoranza un gergo tecnico astratto? In tal caso, perché allora non dovrebbero essere bandite in modo analogo anche parole come conoscenza, coscienza e via dicendo? Magari si afferma che si tratta di termini filosofici astratti che non possono avere alcun significato concreto, che non possono rappresentare cose che si sentono e si percepiscono, nonostante ci si trovi spesso a combatterli proprio come si combatterebbero nemici visibili? Ebbene l’Incosciente e l’Ignoranza possono essere considerati meramente come vuote astrazioni e liquidati come gergo irrilevante solo quando non ci si è mai scontrati con essi o non ci si è mai immersi nella loro realtà oscura e senza fondo. Per me sono cose reali, sono poteri concreti la cui resistenza si avverte dovunque e in ogni momento, in tutta la sua inerzia tremenda e illimitata. In realtà, nello scrivere quel verso non avevo intenzione né di insegnare filosofia né di introdurre forzosamente un’idea metafisica, anche se ciò può esservi implicitamente contenuto. Mi sono limitato a presentare un avvenimento che per me era in qualche modo sensibile e, per così dire, psicologicamente e spiritualmente concreto. L’Incosciente compare in modo ricorrente in tutti i Canti del Primo Libro di Savitri. Per esempio:
Opponent of that glory of escape,
The black Inconscient swung its dragon tail
Lashing a slumbrous Infinite by its force
Into the deep obscurities of form
Di questa fuga gloriosa avversario,
dimenò l’atro Incosciente la propria coda di drago,
frustando con la sua forza un Infinito assopito
nelle latebre oscure della forma
Anche qui è possibile leggere un’idea metafisica dietro o dentro la cosa vista. Ma questo basta a farne un gergo tecnico, o a rendere il tutto una mistura illegittima? Non appare così alla mia sensibilità poetica. Lei però potrebbe obiettare: “così è per il lettore non mistico ed è quel lettore che occorre soddisfare, poiché lei scrive per il grande pubblico e non unicamente per se stesso.” Ma se avessi dovuto scrivere per il lettore ordinario, non avrei neppure cominciato Savitri. In effetti, ho scritto per me stesso e per tutti coloro che possono apprezzare il soggetto, le immagini e la tecnica della poesia mistica.
Qui sta la vera pietra d’inciampo, in modo particolare per questo tipo di poesia mistica. Per il mistico sono reali e presenti, persino costantemente presenti alla propria esperienza, intime al suo essere, verità che per il lettore ordinario sono astrazioni intellettuali o speculazioni metafisiche. Egli scrive di esperienze che sono estranee alla mentalità ordinaria, tanto da risultare per quest’ultima inintelligibili o nelle quali essa si trova perduta come in un oscuro abisso, sempre che non le prenda per fantasie poetiche espresse con immagini fabbricate dall’intelletto. A questa stregua un critico dello Hindu condannò poesie come Nirvana e Transformation. Disse che si trattava di semplici speculazioni e immagini intellettuali e che in esse non ravvisava alcun sentimento religioso e nessuna esperienza spirituale. Eppure, Nirvana è una trascrizione fedelissima di una delle principali esperienze (per quanto può essere consentito da una lingua generata dalla mente umana), la descrizione di una realizzazione nella quale la mente è del tutto silenziosa e dove nessuna concezione mentale può minimamente penetrare. Si è costretti a fare ricorso a parole e immagini per offrire alla mente qualche percezione, qualche rappresentazione di ciò che risiede al di là dal pensiero. L’incomprensione del critico si scontrava in quel caso soprattutto con versi come:
Only the illimitable Permanent
is here.
Solo l’illimitato Permanente
è qui.
Evidentemente, egli prese tale espressione come una specie di gergo tecnico o di filosofia astratta. Ma non è affatto così: percepii con soverchiante vividezza qualcosa d’illimitabile o, per lo meno, qualcosa che non poteva essere descritto con nessun altro termine. Nessun’altra definizione se non il “Permanente” poteva essere detta di Quello, che era rimasto l’unico esistente. Per il mistico non vi sono astrazioni. Tutto ciò che per la mente intellettuale è astratto, per lui possiede una concretezza, una sostanzialità che sono più reali della forma sensibile di qualsiasi oggetto o avvenimento sul piano fisico. Per me, ad esempio, la coscienza costituisce la sostanza stessa dell’esistenza e posso sentirla ovunque, che avvolge e penetra tanto la pietra quanto l’uomo o l’animale. Un movimento, un flusso di coscienza, per me non costituisce un’immagine, ma un fatto. Se scrivessi: “contro di me in ondate la sua collera montò”, per il lettore ordinario sarebbe una semplice immagine, non qualcosa che è stato da me vissuto come un’esperienza viva; eppure, sarebbe solo la descrizione esatta di qualcosa che una volta mi capitò veramente: un’ondata di collera, una percepibile e violenta corrente di collera che saliva dal piano terra e mi veniva contro, mentre stavo seduto sulla veranda della Guest House; quanto la cosa fosse reale mi fu confermato più tardi dalla persona stessa che aveva avuto quel moto d’ira. Questo è solo un esempio, ma tutto quello che c’è di spirituale e psicologico in Savitri è del medesimo genere. Che cosa si dovrebbe fare in simili circostanze? Il poeta mistico può solo descrivere quello che sente o vede in se stesso o negli altri o nel mondo, esattamente come sente, vede o sperimenta tali cose attraverso la visione precisa, il contatto intimo o l’identità, e lasciare che sia il lettore a comprendere, non comprendere, o a equivocare secondo la sua capacità. Un nuovo tipo di poesia richiede una mentalità nuova tanto nello scrittore quanto nel lettore.
Un’altra questione riguarda il posto della filosofia in poesia o, meglio, se la filosofia debba occupare un posto o meno in poesia. Alcuni romantici sembravano convinti che il poeta non debba avere alcun diritto di pensare, ma debba solo vedere e sentire. Da più parti sono stato accusato di pensare troppo; è stato detto che quando cerco di scrivere in versi, il pensiero s’intromette e scaccia la poesia. Io sostengo, al contrario, che la filosofia ha il suo posto e può perfino assumere un ruolo dominante in poesia, insieme alle esperienze psicologiche — come avviene per esempio nella Gita. Tutto dipende da come viene fatta, se si tratta di una filosofia arida o di filosofia vivente, di un arido enunciato intellettuale o dell’espressione di una verità vivente del pensiero e anche di qualcosa della sua bellezza, della sua luce e del suo potere.
La teoria che sconsiglia al poeta di pensare o, perlomeno, di trattare il pensare come fine a se stesso, deriva da un temperamento romanticheggiante condotto all’estremo e culminante nella domanda del surrealista: “Perché mai la poesia dovrebbe voler dire qualcosa?” Oppure nell’esaltazione fatta da Housman della poesia pura, che egli paradossalmente descrive come una sorta di sublime assurdità niente affatto indirizzata all’intelligenza mentale, ma unicamente al plesso solare, tesa a destare una risposta o sensazione vitale e fisica più che intellettuale. A parte questi punti di vista estremi, l’obiezione nasce in realtà da una vividezza d’intensità dell’immaginazione e delle sensazioni, che tiene in poco conto la visione positiva e le sequenze logiche con cui la mente contempla le cose; il centro o i centri che cerca di risvegliare non sono la mente cerebrale e neppure l’intelligenza poetica, bensì il fisico sottile, il centro nervoso, vitale, oppure quello psichico. Blake non costituisce certo un esempio dell’assurdo, pur essendo sovente privo di un significato che l’intelletto o la mente di superficie possa ritenere coerente o preciso. Esprime cose vere e reali, che non sono assurde ma hanno un senso più profondo, percepibile in modo potente, con un grande vibrato di ben precise emozioni interiori; ma qualunque tentativo di darne una definizione intellettuale esatta le svuota di ogni contenuto e ne compromette il fascino. Non è questo il metodo di Savitri. Savitri mira a un’espressione forte, immediata e chiara della realtà spirituale. Se non viene compresa, è perché le verità che esprime sono inusuali per la mentalità ordinaria o perché appartengono a un dominio o a dominî inesplorati, oppure si addentrano in campi di esperienza occulta — mai per tentare di ottenere un effetto di profondità oscura e vaga, o per sfuggire all’analisi del pensiero. Il pensiero ivi contenuto non è intellettuale ma intuitivo o più che intuitivo, tendente invariabilmente a esprimere una visione, un contatto o una conoscenza spirituali ottenuti penetrando l’oggetto stesso, per identità.
È da notare, peraltro, che i poeti romantici non bandirono affatto il pensiero; al contrario, pensarono con una profusione quasi infaticabile. Possedevano una peculiare visione della vita, qualcosa che si potrebbe definire una loro filosofia, una loro visione del mondo, cui diedero espressione. Keats, che fu il più romantico dei poeti, scrisse “To philosophise I dare not yet” [“Filosofar non oso ancora”] e non “Ho una stoffa troppo poetica per filosofare”. Filosofare era visto da lui, di fatto, come l’imbarcarsi su una nave ammiraglia ove poter innalzare un’insegna quasi regale. La filosofia di Savitri è qualcosa di diverso, ma nondimeno è presente: esprime, o cerca di esprimere, una totale e sfaccettata visione ed esperienza di tutti i piani dell’esistenza e della loro azione interdipendente. Il linguaggio, qualunque esso sia, e i termini, quali che siano, che si rivelino idonei a trasmettere questa verità di visione e d’esperienza, vengono utilizzati senza remore e senza ammettere la benché minima regola mentale di ciò che è o non è “poetico”. Non esita a ricorrere a termini che possono essere considerati tecnici, se utili a esprimere qualcosa di diretto, vivido e potente. Per far questo non c’è nessun bisogno di introdurre un gergo tecnico, vale a dire un linguaggio specifico o artificioso, che esprimerebbe solo idee astratte e generiche prive di ogni verità o realtà vivente. Linguaggi del genere non possono costituire buona letteratura, tanto meno buona poesia. Esiste tuttavia un “poeticismo” che vorrebbe tracciare una specie di cordone sanitario intorno a parole e idee che esso considera prosastiche; ma tali parole, usate nel modo appropriato, possono rendere la poesia più forte ed espanderne il raggio d’azione. È una limitazione, quindi, che non mi pare giustificata.
Mi sono dilungato su questi punti per via di certe critiche mosse da alcuni recensori e da altre persone (talune di grande competenza) in cui veniva suggerito, o si affermava esplicitamente, che nella mia poesia ci sarebbe troppo pensiero e che io sarei da considerare più un filosofo che un poeta. Eccomi dunque costretto a difendere il diritto del poeta a pensare, oltre che a vedere e sentire — il diritto di “osar filosofare”. Mi trovo sostanzialmente d’accordo con i moderni nella loro rivolta contro l’insistenza dei romantici sull’emozione, contro l’obiezione di questi al pensiero e alla riflessione filosofica in poesia. Tuttavia i modernisti, attualmente, si stanno spingendo troppo oltre. Nella loro rivolta contro quello che potremmo chiamare poeticismo, hanno cessato di essere poetici; volendo sfuggire lo scrivere retorico, la pretesa retorica di bellezza e grandezza di stile, si sono sbarazzati dell’autentica bellezza e grandezza poetica. Ripudiando uno stile troppo volutamente poetico, sono caduti in uno stile colloquiale, giungendo a scrivere in modo del tutto piatto; e, sopra tutto, hanno rifiutato il ritmo poetico per andare a scadere nella prosa, o in una mezza prosa, o in una totale assenza di ritmo. Si è inoltre dato un peso eccessivo al pensiero, perdendo la propensione verso la visione intuitiva; e, bandendo l’emozione dalla camera più intima nella casa della Poesia, ci si è trovati costretti, per sopperire all’aridità di un pensiero troppo ingombrante, di introdurre le esasperazioni del vitale inferiore e delle reazioni sensoriali non rigenerate, o alterate unicamente mediante esagerazione. Ciò nonostante, è stato forse restituita al poeta la libertà di pensare, come pure di fare ricorso a una certa immediatezza e spontaneità di stile.
Vorrei ora occuparmi della legge che vieta le ripetizioni. È una regola mirante a una certa eleganza intellettuale, in risposta a un’esigenza che si fa sentire quando l’intelligenza poetica e il bisogno di un gusto classico e raffinato diventano predominanti. Un simile approccio considera la poesia come una forma d’intrattenimento e di diletto per le menti più acculturate; è utile per una certa arte impeccabile della parola, un’inventiva ingegnosa e costante, una continua vena di novità nelle idee, nelle trame, nelle parole e nelle frasi. Un tratto di quest’arte è l’eleganza e la varietà delle forme esteriori, che non deve mai venire meno. Ma non tutta la poesia può essere ricondotta a un simile stile. Le sue regole non si applicano a poeti come Omero o Valmiki o altri scrittori del passato. I Veda potrebbero essere descritti quasi come un insieme di ripetizioni; come pure le opere dei poeti vaishnava e tutta quanta la poesia devozionale indiana in genere. Arnold, parlando di Omero, ebbe modo di notare questa peculiarità: concluse che, nel modo omerico di scrivere, non c’era nulla di particolare da obiettare alla ripetizione ravvicinata delle parole. In molti casi sembra anzi che Omero si compiaccia nel ripetersi; indugia in descrizioni che sempre ritornano, epiteti reiterati, addirittura interi versi che vengono ripetuti a mano a mano che avvenimenti dello stesso tipo ricorrono nel corso della narrazione. Si veda per esempio il verso,
Doupesen de peson, arabese de teuche’ ep’ autoi.
[Iliade, IV.504]
Cadde in un tonfo e su lui risuonaron le armi.
Egli non esita neppure a ripetere versi uguali con una semplice variazione alla fine, come in
Be de kat Oulumpoio karenon choomenos ker,
[Iliade, I.42]
— e poi nuovamente in
Be de kat Oulumpoio karenon aixasa
[Iliade, IV.74]
«Giù dall’Olimpo scese, irato in cuore» e «Giù dall’Olimpo lei scese, d’un balzo». Altrove principia un verso con la medesima espressione e descrive un movimento umano fisico o psicologico in modo similare in una scena della natura, come nel caso del silenzioso dolore di un uomo che ascolta il rimbombo dell’oceano:
Be d’akeon para thina poluphloios boio thalasses
[Iliade, I.34]
S’avviò in silenzio verso il mare tonante.
Nemmeno nella poesia mistica si può obiettare alle ripetizioni; molti poeti vi ricorrono, a volte in modo insistente. Potrei citare come esempio la ripetizione costante della parola vedica rtam, verità, anche otto o nove volte in una breve poesia di otto o dieci strofe, talvolta addirittura in una singola strofe. Lungi dall’indebolire la poesia, queste ripetizioni le conferiscono un potere e una bellezza singolari. La ripetizione di idee chiave, di immagini e simboli chiave, di parole e frasi chiave, epiteti e a volte emistichi o versi chiave è una caratteristica riscontrabile di frequente. Queste ripetizioni creano un’atmosfera, conferiscono una struttura significativa, una sorta di cornice psicologica, un’architettura. Lo scopo, in questo caso, non è quello di intrattenere: si tratta dell’espressione intrinseca di una verità interiore, una visione di cose e idee insolite per la mente comune, l’esternarsi di un’esperienza interiore. Il poeta ricerca il vero più che il nuovo. Egli può usare avrtti, la ripetizione, come uno dei mezzi più potenti a sua disposizione per trasmettere ciò che ha pensato e visto e fissarlo nella mente in un’atmosfera di luce e di bellezza. In Savitri ho usato ampiamente questo tipo di ripetizione. Lo scopo, in questo caso, non è solo di presentare una verità nascosta nella sua vera forma e visione, ma di comunicarla con efficacia trovando la giusta parola, la giusta frase, le mot juste, la vera immagine o il vero simbolo, la parola — se possibile — inevitabile. Se tali cose sono presenti, nient’altro ha importanza, nemmeno le ripetizioni. Questa è la naturale conclusione quando la ripetizione è voluta e serve a uno scopo preciso, ma può rimanere valida perfino in quei casi in cui la ripetizione non è deliberata e si produce nel flusso dell’ispirazione. Non vedo alcun problema nel ricorrere di immagini uguali o simili come il mare o l’oceano, il cielo o il paradiso in passaggi di una certa profusione; purché rappresentino la cosa giusta, ciascuna al proprio posto nell’insieme. Lo stesso criterio si applica alle parole, agli epiteti, alle idee. Solo quando la ripetizione è maldestra, esitante, o quando diventa un fardello assillante e dispensabile, quando non contiene potere espressivo ed è riducibile a una eco sgradevole e insignificante — in tal caso deve essere rigettata.
Posso assicurare che nessuna delle obiezioni da lei sollevate non mi è sovvenuta come possibile da parte di un certo tipo di critica, nel momento stesso in cui scrivevo o mentre rileggevo quanto avevo composto; ma le ho messe da parte come inapplicabili o irrilevanti per il tipo di epopea che sto realizzando; perciò non deve sorprendersi di fronte al mio deprezzarle come troppo deboli e inconsistenti.»
SRI AUROBINDO
(1946)