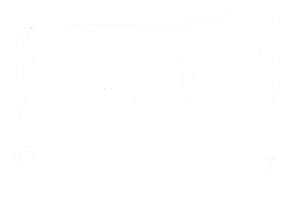IL KARMA
e il significato della
RINASCITA
(qualche riflessione su edizioni e traduzioni)
- a cura del CENTRO STUDI arya -
Vorremmo addentrarci in alcune riflessioni riguardanti le traduzioni e, per farlo, abbiamo deciso di utilizzare come esempio la recente traduzione italiana del libro di Sri Aurobindo “The Problem of Rebirth”, per effettuare qui qualche riflessione su edizioni e traduzioni, a partire dalla presente.
Come è noto, siamo piuttosto selettivi e severi riguardo a traduzioni di testi di Mère e Sri Aurobindo. Perciò, a scanso di equivoci, teniamo a precisare anzitutto che, nonostante non ci necessiterebbe procurarci tali traduzioni, abbiamo l’abitudine di acquistare e compulsare puntualmente ogni nuovo testo che in italiano viene pubblicato dei due Autori da noi amati: si tratta di un piccolo ma per noi significativo attestato di riconoscenza non-verbale nei confronti di chiunque si assuma la fatica del tradurre e l’ancor più penosa ventura di cercare un editore.
Talvolta, come è avvenuto nel nostro stesso caso, i traduttori possono decidere addirittura di pubblicare la traduzione a proprie spese, per motivi che possono essere disparati e che vanno dal non riuscire a trovare un editore seriamente interessato, all'ancor più che comprensibile scelta di non accettare eventuali ingerenze da parte degli editori — i quali, non di rado, nel panorama avvilente dell’industria italiana, finiscono per dare un ‘taglio’ al volume troppo smaccatamente commerciale e troppo poco rispettoso di certi particolari che a loro appaiono dettagli irrilevanti, quando non addirittura futili, ma che per un traduttore serio, competente e sensibile risultano ineludibili. Un esempio per tutti, particolarmente emblematico: il più delle volte l’editore tende a scrivere in modo troppo sbrigativo “Aurobindo”, anziché “Sri Aurobindo” (quante insistenze e raccomandazioni deve fare il traduttore, per giunta non sempre rispettate!), prestandosi così a una operazione di incosciente ma fatale mancanza di rispetto verso l’Autore — un po’ come se un editore intenzionato a pubblicare un libro di Alberto Moravia, decidesse di utilizzare il nome di Alberto Pincherle che, pur essendo il nome anagrafico di Moravia, contravverrebbe alla volontà dell’Autore stesso (se ciò non è mai avvenuto, nel caso di Moravia, è solo perché costituirebbe una pessima operazione commerciale, è evidente). Per inciso, guarda caso, troviamo per ben tre volte, sulle alette di risguardo della sovracoperta, il nome “Aurobindo” in questo nuovo testo edito dal sia pur encomiabile Ubaldini.
Ma, per tornare a noi, teniamo a sottolineare con la massima enfasi possibile la più spontanea e sincera riconoscenza verso chiunque si assuma oneri così gravosi di traduzione e pubblicazione (e solo chi ha provato ad avventurarcisi può comprendere la vera mole dell’impegno e della fatica richiesti), indipendentemente dalla qualità della traduzione e dell’edizione.
Fatta questa doverosa premessa, è da dire che entra parallelamente in gioco, da parte nostra, la valutazione, scrupolosissima, della qualità della traduzione e dell’edizione. Il fatto che sul nostro CATALOGO figurino pochissimi testi di Mère e Sri Aurobindo pubblicati da altri editori (tra quelli presenti, ci onoriamo in particolare di ospitare i tredici volumi de L’AGENDA DI MÈRE), la dice lunga sul rigore delle nostre scelte. E dato che alcuni giudicano eccessiva tale nostra “pignoleria”, abbiamo deciso di tentare di motivarla nel modo più esplicito e diretto (senza minimamente curarci di urtare l'eventuale suscettibilità di chicchessia, né di attirarci eventuali pestate sui piedi — ormai ci abbiamo fatto il callo!) attraverso il presente articolo, in modo da analizzare nel dettaglio alcuni elementi relativi ai criteri che ispirano le nostre scelte, cosicché ciascuno possa trarre le proprie conclusioni.
Ma, prima di procedere, reiteriamo: se ci permettiamo di scrivere qualcosa in proposito, è solo in virtù di una personale esperienza (a un tempo fonte di immenso lavoro e di incomparabile gioia) in fatto di traduzioni e di editoria. Conoscendo a fondo, ormai, le difficoltà e le insidie del mestiere, e non avendo alcun problema ad ammettere di aver dovuto attraversare entrambe, possiamo a giusto titolo sentirci autorizzati a dire la nostra, liberamente, non certo per sentenziare ma, semmai, per condividere le nostre riflessioni con chiunque abbia una mentalità sufficientemente aperta e disponibile.
Abbiamo già scritto, in passato, un lungo articolo al riguardo, che ancora oggi vivamente consigliamo e che, per certi versi, integra il presente: TRADURRE SRI AUROBINDO. Ora, tuttavia, è forse il caso di entrare ancor più nel dettaglio, offrendo esempi concreti. E l’occasione ci viene offerta da questa traduzione di Maurizio Mingotti che, proprio perché la consideriamo complessivamente buona, assolve al meglio i nostri scopi. Sulle pessime traduzioni, si sa, non vale neanche la pena soffermarsi: si commentano da sé. È invece sviscerando una buona traduzione che i pochi elementi discutibili eventualmente ravvisabili possono presentare per noi il più grande stimolo e il maggiore interesse a essere analizzati. È come quando si osserva un muro: se è tutto sporco, non ci si industria certo nell'individuare e discutere ogni singola macchia, sarebbe una insulsa perdita di tempo; se invece è bello nitido e bene imbiancato, le eventuali macchioline presenti su di esso, oltre a risultare ancora più fastidiose (proprio perché saltano all’occhio con maggiore evidenza), sono anche più facili da correggere e certamente più istruttive da esaminare.
Veniamo perciò al dunque e analizziamo nel dettaglio questa pregevole traduzione.
La prima cosa che a noi è balzata all’occhio, è lo ‘stile traduttivo’ di Maurizio Mingotti, abbastanza diverso dal nostro su alcuni punti, la qual cosa ci è subito apparsa come una fonte di stimolo e di arricchimento per noi stessi: il fattore necessario, infatti, non consiste nel condividere i valori estetici e le scelte peculiari che legittimamente attengono a ciascun traduttore, ma nell'appurare che la qualità sia sufficientemente buona. Non è un dettaglio da poco... Parecchi anni fa, per fare un esempio concreto e significativo, conoscemmo a fondo un esperto traduttore dal francese (specializzato nei testi di Satprem) che aveva però una strana deformazione professionale: in pratica, riconosceva adeguato solo il proprio modo di tradurre Satprem! Se qualcuno traduceva in altro modo, ugualmente valido (o magari addirittura migliore, chi può dirlo con assoluta sicurezza?), lui puntualmente diceva: «Sì, la traduzione di Tal-dei-tali è buona, non c’è dubbio, ma è fatta a modo suo»! Così, molto probabilmente senza neanche accorgersene, egli lasciava trasparire il suo desiderio di arrogarsi il diritto di ritenersi l’unico a tradurre Satprem nel solo modo corretto, senza personalismi di sorta, mentre tutti gli altri traducevano “a modo loro”! È invece importante, secondo noi, sviluppare una duttilità che si mostri sempre capace di apprezzare le più disparate tipologie di traduzione con la massima obiettività possibile, vale a dire senza aspettarsi che ricalchino i nostri stilemi, ma apprezzandone il valore qualitativo indipendentemente da eventuali gusti o idiosincrasie personali.
È con grande riconoscenza, dunque, che abbiamo compulsato questa fatica di Maurizio Mingotti, trovandovi una qualità tale da rendere sufficiente giustizia alla bellezza e alla luminosissima e incomparabile chiarezza del testo originale. Soprassiederemo pertanto su quelli che possiamo definire difetti marginali, peccati veniali da cui nessun traduttore e nessun editore (noi compresi, ovviamente) può dirsi totalmente esente, soprattutto in una prima edizione: ci riferiamo in particolare alla eventuale presenza di refusi (purché non troppo numerosi, beninteso), ai rimandi non sempre ineccepibili di eventuali citazioni presenti nel testo che si intende correlare di note personali (le cosiddette “note del traduttore”, o “n.d.t.”, in acronimo), a qualche ripetizione inopportuna e a elementi analoghi. Certo, è perlomeno curioso notare per ben due volte la presenza di un refuso su un medesimo lemma (“intellegibile”, in luogo di “intelligibile”), in due punti decisamente distanti tra loro; errore che tuttavia siamo coscienti di aver commesso pure noi nella nostra prima pubblicazione in assoluto che, proprio per farci le ossa, fu volutamente un testo su Sri Aurobindo e non di Sri Aurobindo.
Per concludere con i refusi, ci limitiamo a notare che, per una qualche bizzarra ironia del destino (come se il diavolo dovesse sempre mettere il suo zampino sulle traduzioni in italiano di opere di Mère e Sri Aurobindo!), il loro numero maggiore — in questa traduzione di Maurizio Mingotti che stiamo prendendo in esame — si trova in corrispondenza della prima appendice, in fondo al volume: ovvero, in quel meraviglioso capitolo poscritto che Sri Aurobindo aggiunse in fase di revisione del testo, nel 1927 (mentre l’opera, lo ricordiamo, risale agli anni compresi tra il 1915 e il 1921, scritta e pubblicata a puntate sulla rivista filosofica Arya) e che, di tutti, ci sembra il capitolo più importante dell’intera opera. Peccato.
Non intendiamo neppure soffermarci su scelte espressive che non condividiamo (che siano scelte stilistiche del traduttore o imposte dall’editore a noi poco importa), come alcune espressioni o certi giri sintattici che, in questa traduzione, sono talvolta più vicini al parlato che a una forma scritta elegante e corretta. Ci limitiamo a ricordare che Sri Aurobindo era un poeta raffinatissimo e aveva portato la scrittura a una forma di perfezione di sublime eccellenza, in cui verità e bellezza sempre coesistono fianco a fianco; la sua raffinatezza espressiva, certo, non è mai volutamente e artificiosamente ricercata (al contrario, fluisce sempre con la più suasiva naturalezza) e raggiunge picchi di assoluta grazia; perfino la sua prosa più filosofica non è mai arida o faticosa, come invece solitamente accade con i filosofi (a parte qualche luminosa eccezione, da Platone a Nietzsche); e, inutile dirlo, non troveremo mai la sia pur minima concessione al lettore medio e ai facili espedienti di chi vuole apparire colloquiale e comprarsi in qualche modo la simpatia del pubblico. La traduzione di Maurizio Mingotti, sia chiaro, non scade mai di livello e non cerca per nulla facili plausi, ci mancherebbe. Non è certo questo il punto; più semplicemente, noi avremmo evitato di utilizzare espressioni tipo “man mano” (forma linguisticamente scorretta, seppure ormai accettata nella lingua parlata, che in questa traduzione purtroppo sovrabbonda) e avremmo optato semmai per la sola forma veramente corretta: “a mano a mano”. Ma non importa — non è certo su simili dettagli che intendiamo soffermarci. Nel complesso, la traduzione scorre fluida e, al tempo stesso, traduce in modo scrupoloso il testo originale — questo è il solo vero punto di capitale importanza.
Compulsando la traduzione con cura, abbiamo pure notato con piacere un sapiente uso della punteggiatura. A qualcuno potrà forse sembrare un particolare di second’ordine, ma i grandi scrittori cesellano sempre con la massima attenzione la punteggiatura, responsabile in buona misura di conferire alla prosa (e, in misura decisamente minore, alla poesia) il giusto respiro, l'esatto ritmo voluto dall’autore. La punteggiatura è dunque estremamente importante e, da questo lavoro, si evince che il traduttore ne è ben cosciente e sa come calibrarla, senza mai cadere nell’errore di ricalcare la punteggiatura dell’inglese che, per certi versi, si basa su presupposti lievemente diversi rispetto all’italiano (tanto per dirne una, la virgola, in inglese, viene non di rado utilizzata per indicare i due punti). A essere proprio pignoli, talvolta ci pare di ravvisare qualche virgola di troppo (per esempio, due virgole poste a cornice di una congiunzione a noi sembrano davvero eccessive: «, e,»); altre volte, invece, il respiro del periodo avrebbe forse richiesto l’inserimento di una virgola per rendere il testo maggiormente comprensibile. Ma si tratta di pareri discutibili e consideriamo il lavoro complessivo molto buono anche sotto questo profilo.
Altra cosa davvero ammirevole, che abbiamo subito notato, è la grande economia nell’uso delle maiuscole: è forse opportuno ricordare che abbondare nelle maiuscole è uno degli errori più grossolani dei traduttori dilettanti in italiano dall’inglese (e ne parliamo proprio perché è uno degli errori più frequenti — seppur non uno dei più gravi — che si riscontrano nella maggior parte delle traduzioni finora pubblicate di testi di Sri Aurobindo). Inserire maiuscole a profusione, nella lingua italiana, produce il risultato deleterio di conferire una ridondanza e una insincerità tali da appesantire il discorso e renderlo ampolloso, barocco, tradendo lo spirito del testo originale. Qui, forse, Maurizio Mingotti cade qualche volta (rarissimamente, sia chiaro) nella tendenza opposta, ma è pur sempre più giustificata del suo contrario.
Anche le note del traduttore, a pie’ di pagina, sono calibrate con cura parsimoniosa e appropriate nel loro contenuto. Come è noto, in un testo di prosa (per la poesia è diverso, si sa), le note del traduttore devono essere limitate all’essenziale, proprio come avviene qui. Il più delle volte, Maurizio Mingotti ne ha fatto ricorso per spiegare o tradurre termini greci, latini o sanscriti. Di meglio non si poteva chiedere (possibilmente, in vista di una eventuale prossima edizione, chiederemmo di verificare bene i riferimenti ai testi sanscriti, soprattutto nel caso delle citazioni upanishadiche). Noi avremmo aggiunto solo un paio di ulteriori note (e una ci pare sia stata omessa per una semplice svista, ma potremmo sbagliarci, ovviamente): a pagina 122, ove Sri Aurobindo accenna a Temi, probabilmente sarebbe stato utile ricordare al lettore che si tratta di una figura della mitologia greca (una titanide il cui nome significa “irremovibile” e che veniva spesso raffigurata con una bilancia in mano, a simboleggiare quella giustizia che per i greci doveva personificare); e a pagina 163, in corrispondenza con il passaggio in cui Sri Aurobindo, per esemplificare un particolare modo di operare del karma, chiama in causa un re del Belgio: sarebbe forse stato opportuno precisare in nota che si tratta di Leopoldo II (il quale, tra il 1885 e il 1908, sfruttò il Congo ricavandone una ingente fortuna, costringendo i congolesi ai lavori forzati e causando la morte di almeno due milioni di loro, su una popolazione totale di quindici milioni, oltre a mutilare barbaramente gli oppositori: per gli storici, all’unanimità, si tratta di genocidio).
Vi è poi una nota, a pag. 149, in cui il termine sanscrito tapasya, così sottile e ricco di sfumature psicologiche, viene reso dal traduttore come “ascetismo” e, poco oltre (a pag. 151), viene perfino tradotto l’inglese self-control con “pratica ascetica”. È davvero un peccato notare come il traduttore, in questo caso, si sia lasciato totalmente fuorviare da uno di quei grossolani fraintendimenti cui gli “indologi” occidentali sono caduti, travisando nel modo più incauto e puerile alcuni termini sanscriti e facendoli digerire acriticamente a quanti non hanno potuto approfondire il sanscrito al di fuori delle aule universitarie, dove ancora oggi la maggior parte dei cattedratici conferisce simili colorazioni falsate e occidentalizzate (come già aveva denunciato a gran voce Schopenhauer, purtroppo senza grandi risultati) a un gran numero di termini sanscriti, dimostrando in tal modo di essere perlopiù incapaci di osservare una cultura 'altra' senza appiccicarvi i propri stereotipi, imprigionandola nelle gabbie concettuali a cui sono avvezzi. È lo stesso Sri Aurobindo a definire (a pag. 405 del testo originale, vol. XIII del “The Complete Works of Sri Aurobindo”) tapasya come «a right concentration of energy», “una concentrazione di energia adeguatamente diretta” verso un preciso scopo. L’ascetismo è solo una forma derivata, bassa e pervertita di tapasya; Sri Krishna nella Bhagavad-Gita depreca senza mezzi termini le macerazioni ascetiche e, più in generale, tutti i maggiori sistemi di yoga le distinguono dalla vera tapasya, prendendo le distanze da esse. Tutto il capitolo successivo (ovvero, il terzo della seconda parte del testo), in cui Sri Aurobindo utilizza con profusione tale termine sanscrito, dandone ormai per scontata la giusta valenza da Lui stesso indicata (come sinteticamente illustrato poc’anzi), rischia di essere volgarmente frainteso se il lettore tiene conto di quella malaugurata nota del traduttore.
Vorremmo permetterci a questo punto una breve digressione, che per noi riveste una certa importanza, prendendo a prestito proprio questo esempio di deformazione semantica del termine tapasya. Qualcuno, infatti, potrà magari obiettare che l'origine etimologica di “ascetismo” rimanda a accezioni nobili, che hanno a che fare, per l'appunto, con la pura askesis greca; tuttavia, è evidente che nel valutare l'esatto valore di un termine, e il suo appropriato inserimento in un determinato contesto, occorre prendere in considerazione, ancor più dell'etimologia, il valore vivo e reale assunto nella lingua e nella cultura che lo ha fatto proprio, talvolta discostandosi considerevolmente dal senso originale. Ne sono significativi esempi parole come “religione” o “cattolico”, il cui senso originario è alquanto diverso dal loro effettivo utilizzo attuale, assai più ristretto e specifico. Peraltro, “cattolico”, nei paesi anglosassoni (in prevalenza protestanti) veicola sovente il suo senso originale più che quello settario; infatti nella lingua inglese lo si incontra spesso nella sua accezione più ampia. Lo stesso Sri Aurobindo lo utilizza perlopiù in questa accezione, per esempio in The Synthesis of Yoga. Tradurlo letteralmente, come ha fatto Nata (altra edizione Ubaldini, peraltro — e l'Editore, purtroppo, non sembra interessato a curare una quanto mai necessaria nuova edizione interamente ritradotta), suona a dir poco ridicolo (ma se fosse questo il peggiore difetto della traduzione di Nata, ci sarebbe di che rallegrarsi!); la sola traduzione italiana legittima di catholic, quando non si riferisce alla romana chiesa, è unanimemente considerata la parola “universale”. Per fare un ulteriore esempio in tale ambito, ancora più evidente, proviamo a immaginare quanto risulterebbe inopportuno definire Gesù un pedofilo per il fatto che, a quanto pare, amasse la compagnia dei bambini («Lasciate che i bambini vengano a me»)... Eppure, la parola pedofilia ha una etimologia nobilissima; peccato che nell'uso corrente (anche colto, a partire dalla terminologia psichiatrica) pedofilia e pedopornografia siano purtroppo considerati pressoché sinonimi.
Per concludere questa lunga digressione, notiamo che, sotto il profilo strettamente etimologico (oltre che sonoro), la parola italiana più vicina a tapas sarebbe “tepore”: e tuttavia, troppo divergenti sono i due lemmi nel significato e nelle implicazioni che ciascuno di essi ha assunto, pur conservando una evidente parentela. Le sfumature sono importanti nella difficile opera del tradurre.
Tornando alla traduzione di Maurizio Mingotti, l’unica critica davvero sostanziale che sentiamo di muovere, riguarda l’utilizzo della parola “supermentale” per tradurre l’inglese “supramental”. Per nostra fortuna, Sri Aurobindo in questo testo ricorre a tale neologismo (da Lui stesso coniato) solo una dozzina di volte. Diciamo subito, infatti, che se nel testo originale fosse stato usato questo termine con maggiore profusione, avremmo senza la minima esitazione ritenuto l’intera traduzione non degna del nostro interesse, anche nel caso in cui tutto il resto fosse stato tradotto in modo magistrale. Per la precisione, troviamo questo famigerato “supermentale” a pag. 78 (per due volte) a pag. 136, a pag. 183 (tre volte), a pag. 184 (tre volte), a pag. 186 (tre volte). Solo in due occasioni è stato tradotto con “sopramentale”, che noi riteniamo infinitamente più adeguato e del quale noi stessi ci avvaliamo nelle nostre traduzioni.
Sarebbe davvero troppo lungo e complesso entrare nel merito per motivare, qui, l’importanza che noi accordiamo a tale termine e a una traduzione perlomeno non fuorviante, perciò rimandiamo nuovamente allo specifico approfondimento da noi appositamente realizzato: TRADURRE SRI AUROBINDO. Nel presente articolo ci limitiamo a fare qualche puntualizzazione e a contestare qualche bizzarra scusante giunta alle nostre orecchie. A partire da quella di chi, pur legittimando pienamente i dubbi da sempre sollevati su tale impropria resa, alla fine giustificava la scelta dicendo che il primo a farne uso fu proprio quel Nata che, forse, chiese lumi direttamente a Mère. A parte il fatto che Nata, di cui ammiriamo lo slancio e la dedizione, non fa testo quanto a traduzioni — anzi, semmai è da prendere come esempio di come non bisogna tradurre (peraltro, ci è stato riferito che Nata traducesse dal francese e non dall’originale inglese, il che non sarebbe propriamente corretto, visto che ciò non viene mai specificato nelle pubblicazioni, come invece sarebbe d'obbligo, per onestà intellettuale e non solo); è assai poco probabile che egli abbia mai chiesto un chiarimento in tal senso o che, comunque, abbia ricevuto un qualche consiglio al riguardo: Mère, infatti, che l’italiano lo aveva studiato da giovane ma che, per sua stessa ammissione, lo aveva completamente dimenticato, nelle sue personali (e notevolissime) traduzioni di testi di Sri Aurobindo, traspone invariabilmente il sostantivo inglese “the Supermind” con l’aggettivo sostantivato francese “le Supramental”.
È pur vero che il francese non offre alternative in tal senso: mancando alla lingua francese il sostantivo 'mente' (che, com'è noto, è detta 'esprit'), i francesi si trovano costretti a sostantivare l'aggettivo dicendo 'le mental' e, per conseguenza, 'le supramental'. Ma anche l'inglese ha dei limiti in tal senso: infatti, pur avendo l'aggettivo sostantivato 'the supramental' ('il sopramentale'), troviamo come unico sostantivo possibile 'the Supermind'. L'italiano, invece, nella fattispecie supera in duttilità espressiva e in precisione sia l'inglese sia il francese: possiamo infatti ricorrere, con uguale correttezza grammaticale, oltre all'aggettivo sostantivato 'il sopramentale' (per tradurre adeguatamente “the supramental” e “le supramental”), a due diversi sostantivi per rendere l'inglese Supermind: 'la sopramente' e 'la supermente'. Ora, il punto è proprio questo: se avessimo a nostra disposizione come unico sostantivo “supermente”, non avremmo scelta e dovremmo prestarci alle evidenti ambiguità che il prefisso 'super' comporta; avendo invece la possibilità di una alternativa (peraltro assai più chiara e felice), non utilizzarla equivale a volersi giocoforza prestare ai peggiori fraintendimenti, proprio in relazione al fatto che esiste il modo per ovviarvi, a differenza di quanto accade in francese e inglese! Avendo infatti due lemmi ugualmente corretti dal punto di vista strettamente grammaticale, è ovvio che essi si arricchiscono di sfumature e giocoforza assumono due connotazioni opposte: “sopramente”, che indica per l'appunto un potere di coscienza al di sopra della mente (esattamente quanto Sri Aurobindo intendeva esprimere), mentre “supermente” si limita ad assumere una infinitamente più riduttiva connotazione di mente super.
Non a caso, vi sono una molteplicità di termini inglesi che utilizzano il prefisso “super”, tradotti in italiano con “sovra” o “sopra” e che risulterebbero impropri se si volessero caparbiamente rendere nel modo più pedissequamente letterale. Nella traduzione stessa di Maurizio Mingotti, a pag. 143 troviamo, giustamente, “sovramorale”; il che è ovvio: se infatti provassimo a leggere l’intero periodo sostituendo “sovramorale” con 'supermorale', ne deriverebbe un senso completamente falsato: “sovramorale” indica qualcosa che supera la morale, mentre “supermorale” significa una morale portata fino all'esasperazione (come nel puritanesimo, per intenderci). Ma allora, ci si chiede, perché ritenere che la cosa possa essere diversa utilizzando quel ‘supermentale’ (brutto finanche nel suono, oltre che depistante!) in luogo di un più adeguato e chiaro ‘sopramentale’? Il fatto che si tratti di un piano di coscienza poco facilmente accessibile non giustifica certo una simile superficialità di trattamento. Dovrebbe semmai meritare l'esatto contrario, proprio per non ingenerare fraintendimenti, come avvenne per tutto un secolo nei confronti dell’Übermeinsch nietzchiano, tradotto maldestramente con ‘Superuomo’, prima che l’illustre penna di Gianni Vattimo non mettesse compiutamente in luce la deformazione insita in una simile traduzione, soprattutto dopo l’aberrante distorsione operata dai nazifascisti, convincendo da quel momento tutti i traduttori e gli studiosi a adeguarsi. Ciò nonostante, Mingotti sembra non avere scrupoli nell’utilizzare con una certa profusione termini come “superumano”, in luogo di sovrumano o postumano o altro, così come “supermente” (pag. 37, pag. 81, pag. 185, pag. 186), come se si stesse alludendo a una mente sviluppata al massimo delle sue capacità o, peggio ancora, a superomistici delirî. Davvero deludente che nel Duemila ancora si abbiano tali derive depistanti, sia pure in buona fede.
E non si tratta, sia chiaro, di voler 'migliorare' l'originale, né di volerlo adeguare alle sensibilità e alle idee correnti. Una simile pretesa sarebbe, da parte di qualunque traduttore e nei confronti di qualunque Autore, una presunzione bella e buona. Semmai, è esattamente il contrario: si vuole rendere il testo originale nel modo più corretto possibile. Sri Aurobindo esortò con affettuosa insistenza i suoi primi traduttori (Dilip, Nolini, Prithwi Singh e altri) i quali, per comprensibile rispetto e timore reverenziale nei confronti dell'Autore, erano inizialmente spinti a tradurre nel modo più letterale possibile, ricordando loro che non tradire lo spirito è assai più importante di una rigida e illusoria osservanza della forma.
Ritornando alla traduzione di Maurizio Mingotti, su una linea non meno discutibile, laddove nel testo originale troviamo «our racial, our human heredity», ovvero “la nostra umana eredità, in quanto specie”, troviamo la traduzione «dalla razza, dalla specie» come se si trattasse di due cose distinte, prestando così (senza volerlo, ne siamo certi) il testo a un qualche sospetto di divisione razziale, mai presente nell’originale in alcun testo di Mère e Sri Aurobindo, notoriamente e categoricamente avversi a ogni assurda discriminazione razziale. Bisogna fare attenzione a non cadere in simili errori, anche perché la buona volontà (con cui in genere si tende a scusare svarioni del genere) non basta quando ci si assume la responsabilità così grande di decidersi a rendere pubblica la propria traduzione di un testo di Mère e Sri Aurobindo.
Stiamo ormai per avvicinarci alla conclusione di questo articolo, ma ancora un paio di segnalazioni sono per noi doverose. A pag. 30 leggiamo “pensiero induista”, per tradurre l’espressione originale «Hindu thought». E, di nuovo, siamo davvero sorpresi... Con ogni evidenza, Sri Aurobindo non si riferisce qui al cosiddetto ‘induismo’ (inglese Hinduism) ma a una determinata linea di pensiero filosofico sviluppatasi in India (o, se si preferisce, sviluppatasi nel pensiero hindu, o nel pensiero indiano): perché dunque introdurre nella traduzione un “ismo” religioso dove in originale non è affatto presente? Ecco un’altra deformazione che sarebbe altamente auspicabile evitare categoricamente (sarebbe peraltro molto interessante, per noi, illustrare a fondo come il termine “induismo” sia una pura invenzione a tavolino da parte degli studiosi occidentali, ma rischieremmo di farla davvero troppo lunga e, oltretutto, crediamo pure di esserci già espressi da qualche parte sull’argomento; conviene comunque ricordare che Sri Aurobindo non era ‘induista’, poiché non apparteneva — come da sue esplicite dichiarazioni — a nessuna religione d’oriente o d’occidente, antica o moderna che sia. L'esperienza spirituale per via sperimentale (e le sue conseguenze materiche, terrestri) era l'oggetto costante della ricerca e dell'Opera di Mère e Sri Aurobindo, non certo le assunzioni aprioristiche di un qualche credo religioso!
Infine, per dovere di completezza e per offrire un ulteriore spunto di riflessione, permettiamoci un piccolo accenno a un dettaglio tutto sommato ininfluente ma che reputiamo comunque degno di nota: vi sono, nel testo originale, due bellissimi termini inglesi utilizzati da Sri Aurobindo in una medesima frase, volti a produrre uno di quei ben noti e intraducibili giochi linguistici assai felici (già in “The Synthesis of Yoga” aveva fatto qualcosa di simile con «understanding» e «overstanding», come pure, negli scritti di critica poetica, con «undertone» e «overtone»): «underlord» e «overlord», tradotti rispettivamente come “vassallo” e “signore”, il che a nostro parere tradisce lo spirito di totale interdipendenza non-dualista che secondo noi si voleva suggerire nell’originale, per rappresentare due aspetti della medesima Divinità: l’immanente e l’universale-trascendente; in modo più appropriato, a nostro avviso, si sarebbero potuti rendere con “principe ereditario” e “signore supremo”, dato che il vassallo evoca oggi colorazioni per lo più spregiative e, in ogni caso, una netta distinzione di rango, con valenze ormai prevalentemente psicologiche (come quando, per esempio, Sri Aurobindo scrive, in chiusura del V capitolo di “The Supramental Manifestation upon Earth”, «if man is not doomed to remain always as a vassal of the Ignorance,» ecc.). Alcune antiche culture contemplavano l'esistenza di diversi re locali, tutti governati da un re supremo; nella tradizione celtica, per esempio, vi erano varî regnanti locali (gaelico “rí”), tutti comandati da un re supremo (“ard-rí”): ecco, l’idea che Sri Aurobindo voleva evocare nel passaggio in questione sembra proprio questa, trasportata ovviamente in un dominio per nulla rigido e separativo come invece appare quello fisico.
E, ancora, notiamo un ulteriore dettaglio, che attiene tuttavia allo stile e al gusto personale e non certo a imprecisioni o inesattezze, relativamente all’assenza di quei trattini di collegamento che nelle lingue anglosassoni, talvolta, legano insieme più termini senza creare vere e proprie parole composte (come quando, nel testo che stiamo prendendo in considerazione, Sri Aurobindo scrive “All-Soul”); in italiano, gli autori più esigenti e raffinati hanno introdotto da almeno un secolo a questa parte (i poeti per primi, come puntualmente accade quando viene introdotta nella lingua italiana una qualche modifica destinata a durare, seguiti poi dagli scrittori in prosa) un simile espediente con indubbia efficacia (nell’esempio citato, noi avremmo quindi scritto “anima-di-tutto”, anziché “anima di tutto”); legare insieme simili parole — cum grano salis e con la giusta parsimonia, è ovvio — aiuta notevolmente l’italiano ad arricchirsi in uno degli ambiti linguistici ove maggiormente difetta ma, soprattutto, è convinzione ormai stabilita che tale espediente renda la lettura di testi tradotti dall’inglese e dal tedesco assai più agevole e comprensibile. Provare per credere.
Altro non resta da dire. Crediamo di avere sviscerato in modo sufficientemente approfondito questa traduzione, sperando di avere offerto qualche stimolo ai traduttori delle opere di Mère e Sri Aurobindo. È importante che, dopo un primo periodo (non breve, visto che è durato l’intera seconda metà del Novecento) in cui la lacuna da colmare nel panorama editoriale italiano era talmente enorme che bastava tradurre e pubblicare in qualunque modo un testo di Mère e Sri Aurobindo per offrire un servizio utile, ora sarebbe finalmente tempo di rendere pubbliche solo le traduzioni davvero meritorie e di fare molta attenzione a perfezionare per quanto possibile ogni più minuto dettaglio.
Ottobre 2013