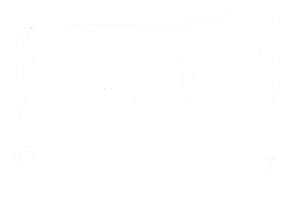Oltre gli “idola”
di Gaia Ambrosini
Il druido Uscias, sul finire di Dana — dramma lirico di Tommaso Iorco — rivolgendosi alla popolazione celtica d’Irlanda su richiesta del re Eremon, pronuncia, fra le altre, queste parole (Atto V, scena III):
Il freddo dell’inverno coglierà
il figlio della terra, fino a quando
non si libererà di tutti gli idola,
dentro di sé ritrovando la Dea.
Vorrei approfittare dell’occasione per una breve riflessione sugli idola, per meglio cogliere il senso di questi versi.
La dottrina degli “idola”, cioè la dottrina della naturale fallibilità della mente umana, la troviamo formulata dal filosofo inglese Francis Bacon (spesso italianizzato con Francesco Bacone e vissuto a cavallo fra il XVI e il XVII secolo), il quale, per le sue qualità di fondatore dell’indirizzo sperimentale, è ritenuto l’iniziatore della filosofia moderna.
Gli “idola”, questi errori che lui chiama volantes fantasiæ, sono come fantasmi che assediano la mente degli uomini.
In Bacon non c’è quella fiducia presente in altri nella capacità della mente di afferrare il senso profondo delle cose. Gli idola sono perciò costitutivi intrinseci della nostra natura di uomini in quanto esseri mentali.
Il filosofo inglese distingue cinque gruppi di idola, denominati — in modo assai suggestivo — della spelonca, della tribù, del foro, del teatro, della scuola.
La “spelonca” (idola specus) è assimilabile alla caverna di Platone. Ogni uomo vive come in una spelonca, non vede la realtà direttamente, ne vede a malapena alcune ombre riflesse, perviene cioè a una conoscenza indiretta del mondo: vede le apparenze, non la realtà diretta delle cose.
Gli idola della “tribù” (idola tribus)derivano dal fatto di essere associati, di vivere insieme in un certo modo. I paradigmi mentali di un membro di una tribù bantu, per esempio, sono estremamente lontani dai paradigmi mentali di un gruppo di docenti di una università europea. Ma in qualunque tribù — nel senso specifico di collettività — sono presenti errori e pericoli, cui la mente incorre per il fatto di vivere in quella cultura e quindi di subirne i limiti.
Vi sono poi gli idola del “foro” (idola fori). Il termine è preso a prestito dal foro degli avvocati, luogo per antonomasia dove si disputa. E, per estensione, identifica gli idola che derivano dal linguaggio stesso. Quando usiamo le parole, dice Bacon, crediamo di usarle solo per chiarire, in realtà oscuriamo in parte la verità (in un’aula di tribunale ciò risulta particolarmente evidente), perché le parole, come egli stesso osserva acutamente, «ritorcono la loro forza sull’intelletto». Vale a dire che quando scegliamo una parola, scegliamo di dire una cosa, ma al tempo stesso nascondiamo quella cosa, perché la parola non dice mai — aggira, o raggira, l’essenza della cosa per tentare di coglierne l’apparenza deformata. La parola, in definitiva, non serve solo a comunicare, serve anche a occultare, vale a dire che la scelta di una parola è condizionante.
Vengono quindi ci sono gli idola del “teatro” (idola theatri), che sono quelli che derivano dallo «spettacolo delle filosofie», per riprendere la metafora (irriverente ma assai azzeccata, con quel tocco di humour e di auto-ironia tipicamente anglosassone) utilizzata dallo stesso Bacon. Siamo a teatro e assistiamo alle prolisse recite verbali, costituite dagli interminabili e inconcludenti monologhi dell’intelletto, inseriti nella scenografia rappresentativa delle dottrine del passato (Bacon suddivide tali idola in tre ulteriori sottocategorie: empirica, sofistica, superstiziosa). Esse raccontano sempre la stessa cosa — è come andare a teatro tutte le sere e assistere per tutta la vita alla rappresentazione della stessa commedia, benché interpretata da attori differenti, ognuno con un proprio stile e permettendosi qualche lieve variante.
Infine, vi sono gli idola detti della ‘scuola’(idola scholæ), consistenti nel riporre una fiducia cieca e assoluta nelle regole e negli insegnamenti del passato, a discapito della propria personale sperimentazione e di nuove scoperte. È la deferenza asinina che molti uomini mostrano, per fare un esempio, nei confronti di uno scienziato, o di un illustre cattedratico, al punto da credere a qualunque cosa affermi, solo perché questi riveste una posizione sociale che gli conferisce un indubbio prestigio culturale, ulteriormente supportata dalla buona reputazione di cui la scienza gode nella attuale società. Oggi, in particolare, va molto di moda inchinarsi servilmente all’uomo di potere, ricco e influente, poco importa se si tratta di un essere spietato e privo di scrupoli: la volontà-di-potenza è tutto, la volontà-di-dominio soltanto conta. In altro contesto sociale, in altra cultura, la medesima ignorante infatuazione si rivolgerebbe allo stregone, al capo-tribù, al guerriero più forte e violento.
È, questa, una descrizione degli errori tale da darci l’immagine di una mente che è per natura limitata, che ha certo la possibilità di apportare qualche miglioramento alla situazione interiore-esteriore, ma mai di cambiarla radicalmente (né, ancor prima, di comprenderla appieno). Vale a dire che l’essere pensante, mediante la sua mente, non conoscerà mai come l’Ente Supremo conosce. La mente conosce solo in modo indiretto quanto osserva fuori di sé, mentre la Gnosi Divina è conoscenza-di-sé, inalienabile e assoluta.
C’è qui un forte senso — che è il medesimo che si ritrova in Galileo Galilei, se si vuole — di quelli che Kant chiamerà i «limiti della ragione», che poi è un tema che emerge con Locke e che attraversa l’intera storia della filosofia occidentale, mentre nella filosofia orientale questo è proprio il punto di partenza per oltrepassare tali limiti e per trovare una conoscenza per identità che, a quanto pare — e per tornare al punto da cui siamo partiti —, era contemplata anche presso i celti e annoverata fra le conquiste più rilevanti.
L’uomo — in quanto essere mentale — non è affatto lo specchio del mondo, o al più è uno specchio appannato del mondo, non vede tutto e, come se non bastasse, quanto vede appare in maggiore o minore misura fatalmente deformato; per forza di cose si trova costretto l’uomo a limitare il proprio intelletto, circoscriverlo a determinate operazioni; di conseguenza, alcune cose può sapere e molte altre non le può sapere. O, come dice Sri Aurobindo in uno di quei versi mirabili di Savitri:
«Il troppo sapere osta | la conoscenza del tutto».
Non a caso è proprio Sri Aurobindo a sostenere che, per acquisire una visione globale e “sopra-mentale” (o divina, se si preferisce), l’uomo deve superare se stesso, compiersi in un nuovo essere che, sulla terra (ovvero nel mondo fenomenico, nella manifestazione) sappia vivere ed esprimere la Verità suprema, la Conoscenza integrale.
Allora, riprendendo il dramma lirico Dana con il monologo conclusivo del druido Uscias, la Grande Dea di Luce e d’Amore, la Magna Mater (il Potere dinamico della Realtà Suprema)
risorgerà, visibile e concreta,
portando il giorno eterno sulla terra.
Regina della foresta e sua essenza,
tornerà a esser linfa in tutti gli alberi.
E, necessariamente,
Quel giorno sarà privo di tramonto.