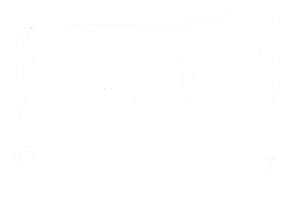LE GRANDI EPOPEE DELL’UMANITÀ
di Tommaso Iorco
(autore tutelato S.I.A.E.)

All’alba del terzo millennio dell’umana barbarie, sommerse dall’assordante frastuono delle numerose sirene d’allarme che frangono l’aere inquieto delle nostre metropoli, le voci dei poeti paiono ormai fatalmente destinate all’estinzione, al pari delle Sirene delle antiche mitologie. Lo stesso verbo poetico si è andato frantumando sempre più, assediato dal ritmo sincopato e nevrotico di questo spasmo esiziale cui presuntuosamente diamo il nome di modernità. Per non parlare della grande poesia epica, la quale pare definitivamente perduta. L’intera poesia — o dovremmo dire tutta quanta l’arte? — sembra quasi sottoscrivere il proprio epitaffio per mano dei poeti ‘ultramoderni’ che, sazi dell’antica bellezza delle Muse, non paghi d’avergli stracciato ogni vestito di dosso mostrandone le belle nudità, ora sono tutti intenti a radiografare le Nove, in cerca di chissà quale arcano. […] Sappiamo infatti a che punto la Roma dei Cesari stimasse la poesia, al pari della Grecia dell’età di Pericle, dell’India delle grandi dinastie, dell’Italia rinascimentale… Non più così, oggi, nell’èra che segna il colossale trionfo dell’homo economicus.
E tuttavia, proprio non ci riesce di guardare al passato con malinconico rimpianto; da inguaribili orfici, siamo anzi convinti che la poesia è destinata a rinascere dalle sue stesse ceneri, tornando ad affascinare l’umanità con i suoi ritmi, i suoi colori, la sua musica, il suo fascino magico e mantrico. Perfino la poesia epica. Anzi: soprattutto la poesia epica. Solo il tempo, ovviamente, potrà dirci se la nostra intuizione è esatta, o se è frutto unicamente di una troppo accesa fantasia d’inveterati sognatori. Per intanto, possiamo cercare di rintracciare, nell’ambito della poesia epica mondiale (ora che finalmente è crollata ogni barriera che pretendeva circoscrivere la cultura entro i ristretti limiti di una limitata area geografica), quelle opere che ci pare meritino la palma dell’immortalità. Scoprendo, forse, anche qualche capolavoro ingiustamente ignorato.
Dall’antichissima età vedica derivano, dopo i vigorosi inni dei Veda e la poesia sapienziale delle Upanishad, le due più vetuste epopee che l’umanità conosca, ovvero il Ramàyana di Valmiki e il Mahabhàrata di Vyasa, la prima narrante le gesta leggendarie di Rama (e del fido scimmio Hanumat), che pare affondino le loro radici fin nel Mesolitico, la seconda incentrata sulla vita esemplare di Krishna, che la tradizione pone nella prima metà del quarto millennio a.C. […] Queste due epopee, che gli studiosi ormai pongono, per bellezza, forza poetica e genuinità d’ispirazione, al fianco delle sorelle omeriche (basti citare uno dei più celebri sanscritisti del Novecento, Sir Monier-Williams: «Vi sono molti passaggi nel Ramâyana e nel Mahâbhârata che superano Omero quanto a bellezza descrittiva. Nelle epiche indiane la prosodia è più curata, regolare e raffinata e la lingua si situa ad uno stadio più avanzato rispetto a quella omerica»), sono affatto diverse tra loro nello stile: l’epopea di Rama alla ricerca dell’amata moglie Sita (figlia del grande rajarshi Janaka, più volte citato nelle Upanishad più antiche), è tutta femminile nello stile: Valmiki, questo sublime cantore della dolcezza, della lealtà e dell’abnegazione, ha impregnato i sette libri che compongono la sua opera (per un totale di circa ventiquattromila versi ottonari) della migliore esaltazione di quella pura sensualità, quell’idealismo alato, quella sontuosa delicatezza e nobile prodigalità che dovrebbe costituire uno dei pilastri principali del carattere di ogni essere umano. Per contro, l’energico Vyasa, nello sterminato Mahâbhârata (qualcosa come duecentomila versi ottonari divisi in otto libri, che ne fanno la più voluminosa epopea che l’umanità conosca — anche se, originariamente, l’epopea di Vyasa doveva contenere circa 25mila versi a cui, in seguito, è stato aggiunto altro materiale da vari autori, fra i quali Vaishampayana e Ugraishravas), ha trasfuso tutto il proprio vigoroso impeto mascolino nel descrivere le imprese coraggiose, eroiche, cavalleresche, figlie di un pensiero riflessivo robusto e di una spiritualità onninclusiva, irradiazioni di un’aurea età protostorica giunta all’apice del suo fulgore e, insieme, al suo inevitabile tramonto. […] Nel caso del Ramâyana, in particolare, molte sono le analogie con le epopee omeriche, non soltanto per la freschezza che le accomuna, ma anche per la forte somiglianza di taluni dettagli (l’arco col quale Ulisse sconfigge i proci, ad esempio, pare del tutto simile a quello che Rama riesce, lui solo, a tendere, conquistando così l’amata Sita). […] Occorre anche sottolineare, nell’accostamento tra le epopee sanscrite e quelle greche, come nonostante la chiarezza e la spontaneità pervadano sia le epopee di Omero che quelle di Vyasa e di Valmiki, la lingua del Ramâyana e del Mahâbhârata è assai più elaborata e colta della lingua omerica, e lo stesso pensiero è incommensurabilmente più profondo e ricco. La poesia di Vyasa e di Valmiki è più grande, più intima, più ricca di quella d’Omero. Quest’ultimo, d’altra parte, proprio in virtù della sua semplicità, possiede un senso della misura che le epopee sanscrite, nella loro straripante pienezza e profusione di suggestioni, d’idee, di miti, tendono a porre giocoforza in sordina. […] Dall’India, culla della civiltà ârya, il germe dello spirito epico germogliò in tutta l’area indoeuropea, producendo ricche fioriture artistiche. […]
Segue poi la celebre epopea di Gilgamesh, la quale presenta però non pochi problemi, a partire da quello filologico, essendo la versione attuale un’incompleta composizione di frammenti in varie lingue, fra cui principalmente il sumero, l’accadico e l’ittita. La redazione più antica di cui si hanno tracce risale al settimo secolo a.C., sebbene vi siano buone ragioni per supporre che l’epopea avesse una tradizione scritta già nel secondo millennio a.C. (il suo autore resta tuttavia ignoto, occultato dalla caligine del tempo). Gli storici peraltro hanno individuato la reale esistenza di un sovrano di nome Gilgamesh di Uruk, vissuto verso il 2700 a.C. o giù di lì, ricordato per il suo modo giusto di regnare e per avere voluto il restauro del tempio della dea Ninlil a Nappur. Grande è il fascino che tale testo riesce ancora oggi a esercitare — complice non da ultimo la sua vicenda, narrante la ricerca da parte dell’omonimo eroe di una via d’uscita dalla sorte mortale che accomuna gli umani —, rendendo tale opera assai vicina a noi, pur se lontana di quattro millennî. […] Durante la sua ricerca dell’immortalità, Gilgamesh non accetta la consolazione di un eterno rinnovarsi della natura, quale avrebbe potuto dargli la dea Ishtar, né l’ascensione in un qualche paradiso celeste, come il giardino degli dèi ov’egli giunse percorrendo il cammino del sole, e neppure si accontenta di essere liberato dalla vecchiaia per condurre una vita di agi e di ozio, come fu concesso a un suo antenato (tale Utnapìshtin) — Gilgamesh chiede molto di più: l’immortalità sulla terra e la trasformazione di questa a immagine dei cieli. Purtroppo, non riuscirà nell’intento, e nel finale si trova a varcare anch’egli, come ogni essere umano, il confine ultimo della vita, laddove scorrono le acque della morte e dell’abisso, apsu, le acque che stanno sopra il firmamento — rimandando così al ben più antico mito vedico delle acque dell’oceano in basso e dell’oceano in alto, apas (molti sono in realtà i collegamenti col simbolismo vedico, l’approfondimento dei quali potrà forse un giorno spiegarci, tra le altre cose, chi fossero e donde giungessero i sumeri). […]
E arriviamo al grande Omero, con le sue celebratissime epopee eroiche, l’Iliade (15.653 esametri divisi in 24 libri) e l’Odissea (12.100 esametri, anch’essi in 24 libri). Talmente tanto è stato scritto, soprattutto nella parte occidentale del mondo, a proposito di queste due grandi creazioni poetiche, e in modo così autorevole e scrupoloso, che si ha quasi timore d’aggiungere alcunché. Resta comunque sorprendente che uno stesso autore abbia potuto redigere due testi così differenti tra loro, uno narrante fatti d’armi (la mitica guerra di Troia, risalente all’VIII-VII secolo a.C.) culminanti nell’ira del greco Achille contro il troiano Ettore, l’altro le peripezie di quell’insaziabile indagatore dell’ignoto a nome d’Odisseo (o Ulisse, che dir si voglia), eroe greco distintosi nella medesima guerra di Troia (al suo ingegno si ascrive, come sappiamo, l’espediente del cavallo di legno), il quale, alla fine di questa, parte alla volta dell’isola di Itaca, il suo regno, dove lo attendono la moglie Penelope e il figlio Telemaco, incorrendo però, sulla via del ritorno, in una serie di avventure contro creature titaniche e semidei (il gigante Polifemo, la maga Circe, la voluttuosa Calipso). E tuttavia, ciò pare del tutto probabile, vista la forte unità di stile che pervade le due narrazioni. […] Un’antica consuetudine vede nell’Iliade il poema dell’ardimento giovanile, mentre nell’Odissea quello della riflessione più adulta. In ogni caso, la narrazione omerica è sempre una rappresentazione matura, pur nella semplicità lineare che contraddistingue la sua narrazione: non ci sono pensieri reconditi, né sentimenti occultati con astuzia; al contrario, tutto accade alla luce del giorno, senza quei risvolti psicologici, quella raffinatezza intellettuale o quelle ombre crepuscolari che la poesia posteriore introdurrà nel suo impianto. Omero, come disse Victor Hugo, «è un immenso poeta fanciullo», inebriato di tutto lo strepito e la magnificenza della vita; per lui, gli umori gioiosi o collerici degli uomini come del mare, i conviti pieni di allegra spensieratezza, il tumulto delle mischie, lo strepito dei campi di battaglia cosparsi di corpi insanguinati, destano meraviglia, stupore, talvolta terrore, forse anche rassegnazione, ma mai sgomento, mai angosciosi interrogativi sul senso dell’esistenza e, soprattutto, mai un pessimistico ritrarsi dalla battaglia della vita.
Restando in area europea, e più precisamente nell’Italia del primo secolo a.C., eccoci a Virgilio e alla sua travagliata e incompiuta epopea, l’Eneide, in dodici libri (pari a 9.896 esametri), che riprende il mito della guerra di Troia per narrare le vicende di Enea e le sue fatiche per riparare nel Lazio, come pretesto narrativo per esprimere l’aspirazione dell’Autore a vedere l’umanità finalmente libera dalla morsa inesorabile del Fato, e approdare in un Divino che è amore. […] L’impianto dell’Eneide, nella prima metà ricorda per certi versi l’Odissea, mentre nella seconda l’Iliade, senza però tutte quelle ripetizioni imposte da una trasmissione esclusivamente orale; nella prima parte sono infatti narrate le lunghe peregrinazioni di Enea (l’ira di Giunone, gli interventi di Eolo e di Nettuno, l’approdo sulle coste cartaginesi, l’accoglienza di Didone, la partenza alla volta della Sicilia, la discesa negli inferi), mentre nella seconda sono descritte le guerre indigene, che Enea deve sostenere, fino all’uccisione di Turno. Il tutto, inizialmente concepito per celebrare l’impero di Cesare Augusto ed esaltare la Roma contemporanea — il poema nasce negli anni immediatamente successivi alla vittoria di Anzio (31 a.C.), che sembrava segnare la fine dell’età del ferro e l’avvento di un’aurea stagione di pace e di giustizia, tanto sognata da Virgilio —, a mano a mano che prosegue nella stesura diventa però l’occasione per compiere una profonda meditazione sul destino degli uomini da parte di questo «savio gentil che tutto seppe», per dirla con Dante (Commedia, I.VII.3). La conclusione è affidata alla speranza della vittoria su quel male che costantemente sembra sbarrare il cammino dell’umanità. E nonostante il senso di angosciosa impotenza che pervade l’intero poema, vi traluce comunque, in filigrana, un sentore profondo che l’umana avventura non è vana ed è alla fine destinata a trionfare su ogni avversità, a dispetto delle apparenze che paiono eternamente contraddire questo inesausto e insopprimibile anelito. […] L’esametro quantitativo di Virgilio è profondo, ricco, elaborato con somma perizia e, quel che più conta, altamente ispirato. Alcuni versi dell’Eneide figurano tra le più sublimi creazioni della poesia universale, vere e proprie gemme mantriche d’inesauribile fascino, recanti echi d’eterno e d’infinito. Talmente tanto amore Virgilio profuse in quest’opera, che nell’ipotesi di non poterla portare a compimento chiese venisse distrutta, per impedire a qualunque altro poeta di prenderla in mano e terminarla, com’era d’uso al suo tempo. […]
All’incirca nello stesso periodo, o forse di poco posteriore (sebbene la datazione sia piuttosto controversa), ma in tutt’altro ambiente geografico, approdiamo nell’empireo poetico del più grande bardo indiano, Kalidàsa, conosciuto come lo Shakespeare dell’India grazie alle sue straordinarie doti di drammaturgo, distintosi tuttavia anche come poeta lirico (basti citare il bellissimo ciclo lirico Meghadùta) e, soprattutto, autore di due poemi epici, dei quali almeno uno merita a pieno titolo di entrare nel novero dei grandi capolavori epici dell’umanità: l’incompiuto Kumàrasambhava, otto canti d’inesauribile bellezza, incentrati sul matrimonio tra il dio Shiva e la sua amata dea Pàrvati, e la conseguente nascita del loro divino figlio Kumàra. Oltre a darci prova della sua profonda conoscenza dei testi sapienziali indiani (nella fattispecie, il profondo simbolismo vedico-upanishadico del rapporto mistico tra Purusha e Prakriti, l’Essere e la Natura), Kalidasa ci offre un poema in cui domina un elevatissimo tono epico, intervallato da momenti di intenso lirismo (la descrizione, contenuta nel terzo canto, della primavera, non possiede eguali in tutta la letteratura mondiale). Il dialogo (contenuto nel quinto canto) tra la dea Parvati camuffata da asceta e Shiva che le rende visita sotto le vesti di un postulante, è uno dei momenti più felici e ispirati del poema, in un serrato botta e risposta pieno di verve. Per non parlare degli ultimi due canti, considerati a giusto titolo come l’acme assoluto del genio poetico di Kalidasa. Nessun altro poeta sanscrito possiede uno stile così semplice e al tempo stesso così aggraziato. […] Nulla è ornamentale in Kalidasa, nulla artificiale o eccessivo. La forza della sua poesia è tutta nella musicalità del suo verbo e nella semplicità delle sue espressioni, sobrie e insieme cariche di colore e di dolcezza, semplici e tuttavia mai banali, straripanti una bellezza al tempo stesso sensuale e al limite del sovrasensibile. Del dio Shiva di cui è devoto, Kalidasa ha ereditato certamente quell’austerità che, trasposta sul piano poetico, ha reso immortale, assieme a lui, un vate d’altra latitudine del calibro di Eschilo. […] Alcuni critici ritengono superiore l’altra sua epopea, il Raghuvàmsha, ma tale giudizio ci sembra dettato soprattutto dalla scarsa lunghezza del Kumarasambhava che, con i suoi 1.218 versi (pur se si tratta di versi di sedici sillabe), è uno dei più brevi poemi epici esistenti.
Possiamo indicare anche il Kiratarjuniya, composto in sanscrito da Bharavi. Si tratta di un’epopea piuttosto celebre per lo stile maestoso e per la sua profondità. La storia si sviluppa da un episodio del Mahabharata, nel momento in cui i cinque fratelli Pandava sono esuli nella foresta. Per riguadagnare il regno perduto, Arjuna si reca sullo Himalaya per cercare Shiva allo scopo di propiziarlo alla causa sua e dei suoi fratelli. Ma il dio assume le sembianze di un ‘kiràta’, un cacciatore tribale vestito di pelle di tigre. Arjuna ottiene i suoi favori a causa della nobiltà e del valore che mostra di possedere, perciò Shiva gli fa dono della propria terribile arma pashupata.
Restando ancora in India, un’altra coppia di poemi epici merita i nostri favori, ossia il Cilappatikàran di Ilanko e il Manimekalài di Sethalai Sathanar (autori ambedue vissuti nel Sud dell’immenso subcontinente asiatico — e ottimi amici, per giunta — nel secondo secolo d.C.), impregnati di cultura buddhista, del cui senso di compassione le due opere sono ampiamente pervase. La stessa relazione tra le due epopee, scritte in tamîl, è talmente forte da indurre alcuni critici a parlarne come di un’epopea gemella. Il Cilappatikaran (trenta canti divisi in tre parti, per un totale di 4.883 versi) è incentrato sulla storia di Kannàki, mentre Manimekalai (trenta canti anch’esso, e 4.857 versi complessivi) è il nome della sorella di Kòvalam, marito della stessa Kannaki. […] In questi due poemi, e in modo particolare nel secondo, le immagini sono intense e posseggono una grande forza evocativa, la musicalità risuona in modo efficace e come pregna di un magico potere ipnotico, la poesia appare ovunque pienamente matura e adeguata, il tutto in un movimento ritmico fluido e solenne. Forse, la propaganda buddhista presente in essi è, talvolta, eccessiva, sebbene non danneggi mai il tono epico — e questo, in fin dei conti, è tutto ciò che conta nel formulare un giudizio squisitamente poetico. […]
Anche la letteratura persiana ha il suo capolavoro epico. Molti, in realtà, e lunghissimi, sono i poemi persiani (citiamo per tutti quello del celebre mistico sufi Jalàluddin Rumi, il Mathnawì, sei libri per un totale di 35.700 versi doppi, a rime baciate, ove ogni verso consta di ben ventidue sillabe), ma relativamente pochi sono quelli in forma di epopea. Un vero e proprio poema epico è invece quello sortito dalla penna di Abu l-Qasìm Hasan ibn Ishaq, meglio conosciuto — per nostra fortuna! — con il breve soprannome di Firdusi (“il paradisiaco”), autore dello Shanaméh (Il Libro degli 'Scià', i re persiani), grandiosa epopea di circa 50.000 versi, nella quale è raccolta tutta la storia leggendaria della Persia, dalla creazione del mondo fino ai giorni del suo autore, vissuto nel X secolo, e quindi al tramonto dell’impero sasanide, prima della conquista musulmana. […] Firdusi introdusse nel suo testo un frammento di circa mille versi del poeta Daqiqi che aveva cominciato a comporre un’opera di intento analogo, interrotta poi per la morte dell’autore. […] Nello Shanameh si susseguono le imprese mitiche e quelle reali dei cinquanta sovrani succedutisi, descritte in lingua neopersiana e con una ispirazione poetica che viene meno soltanto in pochi punti di eccessiva minuzia descrittiva. La critica giudica comunque assai superiore, dal punto di vista artistico, la prima parte, prevalentemente mitica, in confronto alla seconda, che ha intenzioni più cronistiche. Lo stile di Firdusi si distingue per la sua forte espressività, per l’immediatezza dell’immagine e la profondità con cui i personaggi e i loro sentimenti vengono scolpiti. Il tema centrale dell’epopea è costituito dall’eterna lotta tra le forze del Bene, rappresentate dal saggio dio Ohrmazd, e quelle del Male, capeggiate dal terrifico dio Ahriman, secondo l’insegnamento di Zoroastro. I varî sovrani che si susseguono nel racconto poetico, servono chi l’uno chi l’altro dio, mostrando in tal modo la capitale differenza tra un mondo governato dalle forze del Bene o dai poteri del Male. […] Firdusi fu anche un buon drammaturgo e, come se non bastasse, in vecchiaia si dedicò alla creazione di un altro poema epico, Yusuf u Zalikha, di circa diecimila versi, nel quale viene ripresa la storia biblica di Giuseppe, senza però raggiungere la stessa intensità d’ispirazione che contraddistingue lo Shanameh.
Trasferendoci in area germanica, l’epopea principale della tradizione teutonica è certamente il Nibelungenlied, composto — su leggende ben più remote (come quelle narrate nel Beowulf, il più antico poema epico tramandatoci dalle letterature germaniche, composto intorno al 700 e narrante le gesta dell’eroe omonimo che uccide il mostro Grendel e, cinquant’anni dopo, un drago, perdendo la vita) — nei secoli XII-XIII da un ignoto autore austriaco. Questo poema, costituito da 9.516 versi a rime baciate, narra vicende in parte leggendarie (gli stessi nibelunghi sono dei nani dotati di poteri magici che stanno a guardia di un favoloso tesoro custodito nelle viscere della terra — le reminiscenze ârya sono forti — e che passa poi a Sigfrido e quindi ai burgundi), in parte trasformazioni fantastiche di fatti storici (come l’annientamento dei Burgundi da parte degli Unni, avvenuto nel 437, e gli sponsali di Attila con la principessa germanica Crimilde). L’epopea è divisa in due parti: la prima tratta le nozze di Sigfrido con Crimilde e la sua uccisione da parte di Hagen, la seconda lo sterminio dei burgundi e la vendetta di Crimilde. […] La narrazione procede con un ritmo serrato, robusto e fiero che ricorda la potente compattezza di un’avanzata militare, e lo stesso linguaggio è forgiato in modo titanico, impregnato di virile intensità, tutto teso all’esaltazione del valore guerriero e di quella che Nietzsche chiamerà la “volontà-di-potenza” dei sassoni — che, come la storia purtroppo ci insegna, talvolta si è trasformata in ‘delirio-di-onnipotenza’. […]
In area francese, intorno all’anno 1.000, un autore ignoto compose il primo capolavoro epico della letteratura medioevale: la Chanson de Roland, incentrata su un episodio della battaglia vittoriosa di Carlomagno sui Saraceni, avvenuta il 15 agosto 778 in Spagna. Sulla via del ritorno, nel ripassare i Pirenei la retroguardia del re franco venne sorpresa e sconfitta da montanari baschi in una località che nel poema assume il nome di Roncisvalle. Qui morì il paladino Rolando (o Orlando), prefetto della Marca di Bretagna che comandava la retroguardia. Il migliore dei nove manoscritti a noi pervenuti, quello di Oxford, è in dialetto normanno, mentre il testo originale era scritto in lingua d’oïl (antico francese). Il poema consta di 4.004 versi decasillabi ed è diviso in 291 strofe, dette “lasse”, costruite ciascuna su una sola assonanza (in quel periodo, infatti, la poesia francese alla rima preferì l’assonanza, vale a dire l'identità dell’ultima vocale accentata). L’autore ha doti artistiche di prim’ordine, unitamente a un forte senso nazionale e religioso. L’atmosfera che è riuscito a creare nell'epopea è potentemente suggestiva, ove è impressa l’orma sicura di un creatore di autentico genio. Le gesta narrate ebbero profonda eco in buona parte d’Europa, in particolare in Italia (ancora oggi costituisce tema ricorrente nell’Opera dei Pupi, il teatro delle marionette siciliano). [...]
Ed eccoci giungere a un’epopea, tutta allegorica, considerata a giusto titolo come una delle più grandi in assoluto: la Divina Commedia del sommo Dante. Poema tripartito (e in terza rima), contenente 4.233 endecasillabi, possiede cento canti totali (d’altronde la numerologia è importantissima, per Dante). […] Possiamo certo dissentire dall’impianto teologico che l’Autore, uomo del medioevo in tutto e per tutto, pone a fondamento delle tre Cantiche, ma non possiamo non inchinarci e deliziarci dinnanzi a questo mirabile poema, con la sua straordinaria musicalità, il suo perfetto equilibrio tra austerità e sontuosità espressiva, il suo stile conciso e chiaro, la sua melodia a un tempo straordinariamente dolce e trionfalmente squillante. […] Mirabile prodotto della più alta intelligenza poetica, ha peraltro anche i suoi momenti di puro misticismo. […] L’idioma dantesco è uno dei più affascinanti che mai sia stato creato, ricco di vigore e insieme di soave musicalità, tutto grandezza e nobiltà senza mai cadere in uno stile ampolloso e artificiale; è profondo, ma anche scattante e conciso, colorato e tuttavia mai sovrabbondante, nobile e robusto ma insieme eccezionalmente flessibile e sinuoso, grave e tuttavia mai pesante (talvolta un po’ retorico nel suo pensiero, ancorato com’è a una dogmatica che era ormai tempo di superare, come ben si accorse il Petrarca, ma sempre incommensurabilmente grande nel verbo poetico e nell’ispirazione creativa). E ciò basta a farne un capolavoro assoluto di poesia epica, sebbene talvolta la critica stenti assurdamente a riconoscere una reale epicità nel suo argomento, solo perché le sue avventure sono tutte allegoriche e volte nell’intimo — argomentazione assurda, come solo un inveterato ed attardato positivista potrebbe ancora sollevare. La grande epopea interiore è forse meno epica e nobile delle grandi imprese intellettuali e materiali? […] Petrarca tentò egli stesso di creare, nei Trionfi, un poema epico d’impianto più ‘moderno’, libero cioè da tutti quegli inaccettabili ed inconsistenti puntelli dottrinali che abbondano nella Divina Commedia — ma Petrarca, lo sappiamo, è un poeta lirico ineguagliato nel suo genere, e la sua penna mal s’adatta al tono epico.
Mentre, proprio agli antipodi del Medioevo, si erge Ludovico Ariosto, la coscienza poetica più elevata del Rinascimento, vissuto nella prima metà del 1500, il cui poetare fu continuamente minacciato dalla proterva rozzezza del cardinale Ippolito d’Este. Il suo straripante poema epico-cavalleresco, l’Orlando Furioso, è un tripudio di vitalità e di entusiastica celebrazione della vita. Quarantasei canti, ben 38.736 endecasillabi d’omerica chiarezza. La storia cavalleresca, dettatagli dal gusto dell’epoca, pare in realtà solo un pretesto per narrare appassionati sentimenti d’amore. Nel descriverci fatti d’armi, oltretutto, l’Ariosto ce li presenta sempre dall’alto, per così dire, come in un volo aereo, temperando l’asprezza dei campi di battaglia con uno stile lieve, lineare, preciso nel tratto e variopinto nel colore, ove i più minuti dettagli si inseriscono con rara perfezione nel quadro, e concorrono ad esaltare (e giammai a esacerbare) l’armonia dell’insieme. Anche il ritmo fluido del verso è un puro godimento — giacché ci troviamo di fronte alla più bella ottava rima che la poesia italiana abbia saputo creare: la musicalità delle cadenze ritmiche e la finezza luminosa e leggera delle stanze destano un sentimento di piacevole abbandono, che induce a lasciarsi cullare da questo movimento che delizia i sensi. L’epopea si legge quasi cantando, senza mai stonature; non sono neppure presenti cadute di tono per prolissità di particolari (che pure abbondano). […] L’alta nobiltà poetica dell’epopea si ispira, assai più che alle “chansons de geste”, da cui trae a piene mani il materiale narrativo, all’Eneide. Sono state evidenziate da più parti le affinità tra Enea e Ruggiero, così come il Fato dell’Eneide corrisponde in tutto e per tutto alla Provvidenza del Furioso. […] Come disse il Carducci, quello dell’Ariosto è «il poema che canta le glorie di una dinastia italiana contro l’impero e la Chiesa; il poema che trasforma con un lavoro perfettamente classico la materia medievale e rende finalmente italiana la lingua toscana».
Sul finire del medesimo secolo (e nel medesimo continente), Torquato Tasso, certo meno generoso dell’Ariosto, e con un’ispirazione assai meno fresca e spontanea, compone la Gerusalemme Liberata. Venti canti, per un totale di 15.332 endecasillabi, incentrati sulla marcia dei crociati verso Gerusalemme. Molti sono i difetti di tale opera, e il paragone con l’Orlando Furioso non lo si può neppure azzardare, tuttavia i suoi pregi restano tali da fargli meritare senza alcun dubbio un posto nell’elenco. Certo, tra il Furioso e la Liberata c’è lo stesso abisso che separa la feconda apertura dello spirito rinascimentale e la rigida chiusura della restaurazione cattolica. Ma la buona fede del Tasso, al pari del suo stile meticolosamente cesellato e della sincera tensione catartica che lo ispira, riscattano la sua creazione e la salvano dalle acque dell’oblio. […] L’uso ricorrente dell’enjambement, già sperimentato con successo nell’Aminta (che alcuni ritengono, esageratamente, il vero capolavoro tassiano), contribuisce a conferire all’epopea quell’accento drammatico e tormentato che la contraddistingue (e che tanto piacque ai romantici), rendendola a suo modo unica, intensa, musicalmente vibrante in un moto di vivace gravità. […]
Anche il Portogallo possiede un proprio capolavoro epico con i Lusiadi — Os Lusíadas in portoghese — scritto da Luís Vaz de Camões. La prima edizione fu stampata nel 1572, tre anni dopo il ritorno dell'autore dall'Oriente. L'opera è composta da dieci canti e 1102 strofe, le ottave endecasillabiche (le cosiddette “ottave ariostesche”). Scritto seguendo il classico stile omerico, il poema epico si concentra sul periodo storico delle grandi scoperte geografiche avvenute tra il XV e XVI secolo, dando una rilettura leggendaria e fantastica della storia, come fece Virgilio in relazione alla storia di Roma. L’azione centrale è la scoperta della via marittima per l’India realizzata da Vasco de Gama, ma il racconto descrive anche altri episodi della storia del Portogallo, esaltandone il suo popolo. Gli eroi dell’epopea sono, come dice il titolo, i lusiadi, figli di Lusos, cioè il popolo portoghese. Malgrado il contesto moderno della Controriforma, gli dèi della mitologia classica, dalla vetta del monte Olimpo e dalle profondità degli abissi, ispirano e sostengono l’azione dei marinai portoghesi, muniti di astrolabio e cannoni. […]
Passando al XVII secolo, e trasferendoci in area britannica, giungiamo a Milton, e al suo capolavoro, Paradise Lost. Dodici libri, 10.565 pentametri giambici sciolti (blank verse). L’apparato religioso del poema è forse ancor più irritante e prosaico della Commedia dantesca (pur se assai meno aderente al rigido puritanesimo dell’Inghilterra seicentesca di quanto comunemente si creda), e tuttavia il vigore che promana dal poema è grandioso, soprattutto nei primi canti. Anzi, si può affermare che se Milton avesse scritto tutto il poema con la forza espressiva e l’ispirazione dei primissimi canti, avrebbe creato qualcosa di sublime. […] La caratterizzazione di Lucifero è notevolissima, una delle più vive che siano mai state create, e il tono epico è di nobile e austera levatura, così come il ritmo, imponente e vigoroso come solo la poesia dei popoli sassoni sa offrirci. […] Interessante è notare quanto la vicenda semitica presa da soggetto da Milton sia stata trasformata per potersi adattare al tono epico. Il rigido monoteismo professato dalle popolazioni semitiche, infatti, che non ammette le varie deità, risulta decisamente avverso nei confronti dell’epopea, la quale è tutta tesa nel porre massimo rilievo al molteplice nell’universo, al divenire cosmico (giacché, come ha detto Benedetto Croce nella sua mirabile Estetica, «l’espressione è sintesi del vario, o molteplice, dell’uno», e non già dell’Uno nella sua immutabile unità). Milton ha dovuto fare ricorso a tutto il suo genio artistico per ricreare l’apologo biblico onde poterlo conformare all’estro mitologico del tono epico, senza tuttavia modificarne la sostanza. […]
Tutto il Settecento, come sappiamo, sottostà alla convinzione che quanto si poteva dire in poesia è già stato espresso nel passato, mentre dal XIX secolo lo stile epico si fa via via sempre meno frequentato, e prenderà sempre più spazio il cosiddetto ‘frammentismo lirico’, arrivando assurdamente a credere che la sola poesia possibile sia il componimento formato da pochi versi, e più è breve e soggettivo meglio è. Con l’avvento dell’èra industriale, e dei suoi ritmi sempre più serrati e travolgenti, la fretta si impadronisce degli uomini, e quindi anche degli artisti. Purtuttavia, nel cuore del XIX secolo esiste un’epopea che merita la nostra più alta considerazione e stima: ci riferiamo al meraviglioso ciclo poematico di Victor Hugo, intitolato La Légende des Siècles, ove il tono epico raggiunge sommità mai osate altrove nella letteratura francese. È un vero peccato che tale poema sia passato quasi senza essere notato, e consigliamo vivamente la riconsiderazione di un’opera i cui pregi poetici sono immensi. Esprimere il lungo cammino dell’umanità nel suo difficile percorso verso la luce, in una sorta di opera ciclica, questo pare il piano ispiratore del poema. Si parte dai primi albori dell’uomo per arrivare alla Rivoluzione francese, con qualche tentativo di incursione nel futuro. Il genere umano è visto da Hugo come un unico corpo collettivo in marcia verso il proprio compimento, similmente alle antiche concezioni orientali del Vaishvamànava, dell’Uomo universale. Il progetto è assai ambizioso, e viene sviluppato con grande genialità, sebbene i tempi non fossero ancora maturi per una visione globale di così ampio raggio. Tuttavia, nelle intenzioni questo poema è ottimo, e nella sua fattura squisitamente poetica a dir poco eccellente. […] Questo è anche l’unico poema epico, tra quelli selezionati, a non seguire un unico metro dall’inizio alla fine: si tratta infatti di un’opera polimetrica, intessuta di inni e di poemetti; tuttavia, non ci troviamo in presenza di una raccolta di testi lirici riuniti sotto un denominatore comune: un unico respiro palpita nell’intera opera, che consideriamo epica poiché possiede in sommo grado il tono epico, sebbene si discosti dall’epopea così come viene tradizionalmente intesa (ben diverso è il caso del Faust di Goethe che, nonostante possieda un tono epico e sia senza alcun dubbio una delle grandi opere della poesia universale, non può essere considerata un’epopea). […]
Alcuni prendono anche in considerazione, fra le grandi epopee mondiali, il poema finnico Kalevala, costituito di 50 canti (per un totale di 23.000 versi), così intitolato dal nome dell’eroe e progenitore mitico Kaleva, pubblicato nel 1849 dal poeta finlandese Elias Lönnrot elaborando canti popolari epici e lirici. Ma nonostante il vivo sentimento della natura, il tono è magico e fiabesco più che propriamente epico.
Non possiamo neppure esimerci dal citare, sia pur di sfuggita, un testo epico purtroppo appena abbozzato, ovvero quell’Hyperion di John Keats che, se fosse stato portato a termine, anziché fermarsi a pochi frammenti a causa della prematura scomparsa del suo Autore, sarebbe certamente entrato a far parte dei grandi poemi epici dell’umanità.
E, per chiudere in bellezza, giungiamo alla vetta della lista con il sublime capolavoro epico e mantrico di Sri Aurobindo, ovvero Savitri. L’epopea della vittoria sulla morte, un poema spirituale di straordinaria perfezione. Tre parti, dodici libri, quarantanove canti. 23.837 pentametri giambici di mirabile fattura. La più vasta epopea in lingua inglese, vero e proprio testamento di Sri Aurobindo. Un miracolo di indicibile musicalità, in cui l’ispirazione s’invola oltre se stessa, per farsi rivelazione. Decisamente, qualcosa di miracoloso aleggia in quest’opera che, pur se incompiuta, rappresenta un assoluto di visione, laddove bellezza e verità dimorano in un unico radioso nido. […] Il suo stile, di meticolosissima precisione, ricorda quello dell’architetto più che del pittore, eppure dalla sua magica tavolozza mantrica scaturiscono i colori vividi e freschi di un mondo dai contorni che si dilatano, offrendo visioni di complessi architettonici in cui l’irruzione del soprannaturale è costante e privo di soluzione di continuità con la sfera fisica, così come la spirale evolutiva è un ascendere senza sosta all’eternamente Oltre (che tuttavia non è mai un altrove esclusivamente extra-cosmico). […] L’impianto è superbo, la ricchezza e la varietà di temi pressoché infinita, ma il vero elemento che la rende perfetta è l’autenticità del suo centro ispiratore. Tutto ruota attorno a un unico asse portante, similmente all’axis mundi, il perno mistico di tutti i reami visibili o invisibili, movens immobile, estremo significante delle cose tutte. […] Sì, Sri Aurobindo parte dal punto in cui tutti gli altri si sono fermati. […] Non è neppure un caso, a nostro avviso, che sia stato scritto in inglese (in blank verse, per la precisione): in che altra lingua poteva essere scritta quest’opera universale destinata a diventare patrimonio di tutta quanta l’umanità? […] L’antichissimo mito del riscatto dell’uomo sulla morte trova nelle luminose pagine di Savitri, nella bellezza e nella forza dilaganti senza sosta da esse, una sorta di anticipazione di quella gioia che costituisce la meta — oltreché il fondamento, il sostrato segreto — del lungo percorso evolutivo, culminante in una vita divina sulla terra, comprendente la divinizzazione della materia: il Divino ovunque svelato e incarnato nel divenire cosmico, “per la gioia delle miriadi che sono l’Uno”.
© Gennaio 2001