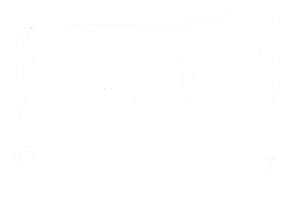Asante Afrika
- a cura del CENTRO STUDI arya -

Asante Afrika: grazie, Africa.
Grazie per aver permesso al mondo occidentale di vergognarsi (ma non ancora abbastanza) e di guardare in faccia la propria barbarie, perpetrata a danno dei tuoi figli, questi fratelli calorosi che il tuo sole ha reso color dell’ebano.
La tratta degli schiavi è uno dei tanti capitoli vergognosi della storia della sedicente ‘cultura’ occidentale. Uno dei peggiori. I problemi morali legati all’uso massiccio della schiavitù da parte dei cristiani furono superati rintracciando nella Bibbia un precedente che poteva essere letto come un presupposto ‘naturale’ della schiavitù: Canaan, da cui si fanno discendere i camiti (l’insieme dei gruppi etnici dell’Africa settentrionale e orientale) fu maledetto da Noè, suo nonno, poiché Cam (padre di Canaan e figlio di Noè) gli mancò di rispetto mentre questi dormiva con le membra scoperte, in preda a ubriachezza. Così, la frase contenuta in Genesi, IX.20-25: «Sia maledetto Canaan! Schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli!», servì a rendere giustificabile per i cristiani la pratica della schiavitù in età moderna (per la precisione, dal XV al XX secolo — approfittiamo per ricordare che nel 1973 le Nazioni Unite adottarono una Convenzione internazionale per la soppressione e la punizione del crimine di apartheid, tesa a precisare che gli atti volti a stabilire e mantenere la supremazia di persone di un gruppo etnico sugli altri violavano la legge internazionale; ma furono necessari altri vent’anni di pressioni interne e internazionali prima che i governanti xenofobi del Sudafrica si arrendessero).
È da dire che il concetto di razza, oggi, ha perso totalmente credito in ambito scientifico; una prima negazione di qualsiasi base oggettiva alla superiorità razziale la troviamo nella Dichiarazione sulla razza e sui pregiudizi razziali dell’UNESCO, datata 1978. Oggi sappiamo che l’archivio genetico è praticamente comune a tutta quanta l’umanità... Basti pensare che ognuno di noi ha due genitori che, a loro volta, discendono ciascuno da un padre e da una madre. Andando indietro nel tempo con questo calcolo, alla decima generazione (calcolando 30 anni a generazione) ognuno di noi condivide il patrimonio genetico di 1024 individui; e alla ventesima generazione, questo valore sale a 1.077.336 antenati; quando poi giungiamo alla trentaduesima generazione, vale a dire intorno al 1.000 d.C., il nostro archivio genetico può essere legato a qualcosa come 4.412.932.096 persone! E poiché questo valore, all'inizio dell’età dei liberi Comuni, era probabilmente pari a oltre il doppio del numero complessivo degli abitanti umani del pianeta, ne risulta che un abitante attuale dell'Italia (o della Pomerania, non fa differenza) condivide parte del patrimonio genetico di tribù di aborigeni australiani, navigatori polinesiani, pastori nomadi dell’Africa centro-occidentale, cavalieri mongoli al seguito di Gengis Khan. Per quanto paradossale possa risultare un simile ragionamento, ha una sua generale validità: il genere umano condivide — praticamente da sempre — una formidabile omogeneità genetica. L’illusione dell’esistenza di razze separate che sarebbero venute in contatto tra loro in tempi relativamente recenti, causando improbabili processi degenerativi, è stato un clamoroso FALSO storico divulgato nel XIX secolo da studiosi inglesi e statunitensi. Tale razzismo “scientifico”, poi adottato dalla cultura tedesca, svolse un ruolo preminente nello sterminio degli Ebrei pianificato dalla Germania nazista. Mentre negli stessi Stati Uniti d’America fu una comoda giustificazione per la tratta degli schiavi dall’Africa.
Rimane tuttavia ancora radicata nell’immaginario collettivo l’idea di una presunta preminenza della società occidentale bianca nei confronti di un’alterità il più delle volte conosciuta solo superficialmente, accusata di inferiorità intellettiva e arretratezza evolutiva. Il darwinismo sociale prima, inquietanti teorie come l’eugenetica dopo, rendono difficile lo sradicamento di pregiudizi razziali assurdi e pericolosi. Oggi è stata negata l’idea delle differenze nelle capacità intellettive delle diverse popolazioni, tuttavia ci troviamo a convivere spesso con atteggiamenti di intolleranza nei confronti delle etnie altre, alimentati in parte da vecchi stereotipi e da recenti timori xenofobi ignoranti e stupidi.
Da un punto di vista strettamente culturale, sono pochi i popoli su cui la mentalità occidentale nutra più equivoci che sugli abitanti autoctoni dell’Africa. Le culture africane sono abituate da generazioni a essere considerate ‘primitive’, in tutte le accezioni di questo abusatissimo termine, che le confina in una posizione di inferiorità. Nonostante ciò, nessuna persona intellettualmente onesta può rimanere sorda all’alta qualità dell’arte africana, dalla letteratura orale, alla musica, alla danza, alle arti figurative.
L’elemento forse più sorprendente nella letteratura popolare dell’Africa indigena è l’unitarietà — elemento che non si è mai verificato in nessuna altra terra di queste dimensioni. Agli occhi di una competente africanista come Alice Werner, tale unitarietà è un fattore di vitale importanza per lo studio della cultura dell’Africa indigena — per citare le sue stesse parole, «comunque si studi l’Africa, geograficamente, etnologicamente o psicologicamente, a mano a mano che ci si inoltra si avverte sempre più l’assenza di confini precisi» (African Mythology). E l’unitarietà non si limita esclusivamente ai tipi d’intreccio e ai contenuti specifici, ma si estende anche agli espedienti letterari — per esempio, alla funzione dei canti nel contesto prosastico, alla riconoscibile prevalenza delle spiegazioni eziologiche. Ma ancora più sorprendenti ed essenziali sono il crudo realismo, l’insistito accento sul vincolo che lega l’uomo alla terra. L’uomo, per fare un esempio, quando vuole comunicare con gli dèi, non cerca di salire al cielo: sono gli dèi a scendere sulla terra. In alcuni miti africani, addirittura, si narra che gli dèi un tempo abitavano la terra, donde sono stati costretti per varie ragioni a trasferirsi in cielo. Peraltro, il tema della stretta unione tra cielo e terra, come primo stadio dell’evoluzione del cosmo, è qui largamente diffuso. La cosmologia yoruba divide l’esistenza in due emisferi: l’emisfero superiore, orun, che è la regione invisibile degli dèi, degli antenati e degli spiriti; e l’emisfero inferiore, aye, il mondo tangibile degli uomini, degli animali, delle piante, dei minerali. E tutti gli esseri viventi, appartenenti ai due emisferi, condividono la medesima energia vitale, ase. Per ciò, individui saggi, iniziati, veggenti, vengono denominati alase.
La musica e la danza africani sono universalmente riconosciute per la loro bellezza e il loro profondo radicamento culturale. Ne sono uno splendido esempio gli ‘uomini-sonaglio’, autentiche simbiosi di suoni, forme, colori — danzatori che sono strumenti musicali e coreografi viventi; adorni d’ogni sorta di oggetti appesi al corpo, con il loro movimento creano direttamente il ritmo e il vortice dei colori, mentre tutti i sensi e i muscoli sono invitati a partecipare. Altro esempio, che sottolinea la funzionalità sociale della musica, ci proviene dalla medicina. Lo stregone, cui spetta il compito di scoprire ed esorcizzare il male, ha tra le sue terapie la musica — da cui la recente musicoterapia. Ed è per lo meno curioso constatare come, secondo le statistiche di alcuni ospedali africani, questi stregoni abbiano maggiore successo dei medici laureati, soprattutto per trattare malattie di origine psicosomatica.
Vogliamo poi passare all’arte figurativa africana? Essa è stata il fertile retroterra cui hanno attinto i maggiori artisti occidentali dal tardo Ottocento a oggi. Da Paul Klee a Henry Monroe, a Matisse, a Picasso (il quale definiva l’arte africana «insuperabile»), tutti gli artisti moderni hanno subito in qualche misura l’influenza di quell’arte e inseguito il sogno di riprodurne la bellezza e la potenza espressiva. In realtà, già dal Rinascimento l’arte africana iniziò a esercitare un’influenza crescente in Europa, come attesta Rabelais, il quale descriveva l’Africa come un Paese «famoso per creare cose nuove e incredibili». Oggi,che il vecchio dissidio tra valore etnografico e artistico dei prodotti della cultura africana è in gran parte superato, tale valore è maggiormente riconosciuto.
In definitiva, questa sia pur rapida scorsa dell’arte africana è un esempio concreto della validità dell’affermazione che la civiltà mondiale non può essere altro che la coalizione su scala planetaria di tutte le culture, ognuna delle quali conservi la propria originalità. Ne consegue che il mondo occidentale deve finalmente smetterla di credersi superiore e di volere imporre (spesso con la forza!) nel mondo intero il suo modello, ipocritamente definito “democratico”, ma che in realtà vorrebbe livellare l’umanità verso il basso e trasformare gli uomini in voraci locuste.
Asante Afrika — grazie, Africa.
Kumradhi Afrika — scusa, Africa.
Dicembre 2003